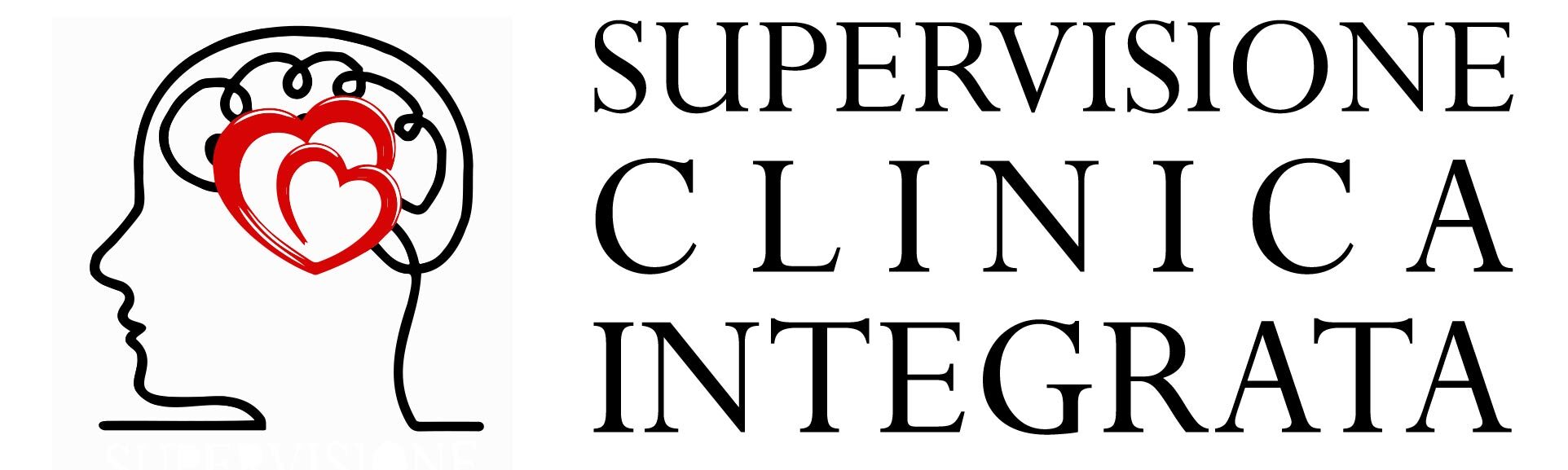Fra te e me un concerto di emozioni
Il testo analizza l’importanza delle ricerche condotte da Beatrice Beebe nel campo della psicoanalisi infantile, sottolineando il loro ruolo fondamentale nel rinnovare la teoria evolutiva alla base della psicoanalisi. Si discute anche dell’importanza della relazione terapeutica in diversi ambiti della psicologia, evidenziando come i cambiamenti in corso stiano portando a una revisione profonda del modello terapeutico, influenzati dalle neuroscienze e dalle ricerche sull’efficacia terapeutica. Si sottolinea l’importanza della regolazione interattiva e dell’autoregolazione nelle relazioni diadiche, sia tra madre e bambino che tra analista e paziente. Questi concetti sono considerati cruciali per comprendere la psicoterapia come una relazione bidirezionale, in cui paziente e terapeuta riconoscono le competenze reciproche e si autoregolano per adattarsi nella relazione. Si discutono anche le implicazioni di queste ricerche per il modello analitico bioenergetico, suggerendo che il modello originario di Lowen possa in alcune parti essere superato alla luce delle nuove scoperte sulla competenza del bambino e sull’importanza dell’influenza reciproca nella relazione terapeutica.
Nunzio Oriolo (*)
Abstract
I risultati provenienti in parte dalle neuroscienze, in parte dalle ricerche sull’efficacia terapeutica e soprattutto dalla ricerca nell’ambito della psicologia dell’età evolutiva, hanno gettato una nuova luce sulla natura dei processi interattivi nella relazione terapeutica. Essi impongono una rivisitazione dei modelli terapeutici. L’articolo affronta le principali dimensioni della regolazione affettiva nella relazione terapeutica alla luce dei risultati dell’infant research ed espone alcune considerazioni sulle possibili conseguenze per il lavoro clinico in Analisi Bioenergetica.
Parole chiave: analisi bioenergetica, implicazioni cliniche, infant research, modelli interattivi, relazione terapeutica
Preambolo
Il mattino ha l’oro in bocca; perciò di primo mattino due analisti bioenergetici si aggiravano per il centro di Roma in uno splendido fine settimana di primavera. La città brillava di una luce insolita e, passeggiando per le strade della capitale, i due potevano ammirare gli alberi in fiore e udire il cinguettio degli uccelli e il gorgoglio dell’acqua nelle fontane. Convennero che quella fosse la stagione perfetta per un soggiorno a Roma perché allora si può godere delle sue bellezze e di temperature miti. Mentre osservavano una giovane coppia passeggiare immersa in quella magica atmosfera, si ricordarono del loro obiettivo. Erano diretti alla John Cabot University situata nello storico quartiere di Trastevere, nel complesso dell’Accademia Nazionale dei Lincei, per partecipare ad un convegno su “psicoterapia e ricerca sull’infanzia”(**) .
Nella sala semibuia riconobbero tra i partecipanti diversi volti di amici che, come loro, erano completamente assorti ad ascoltare una curiosa signora di mezza età. Il suo aspetto fisico e la sua lunga e folta chioma grigia sembravano ricordare i lunghi anni di lavoro dedicato alla ricerca e, allo stesso tempo, la sua voce decisa e squillante, unita ai suoi movimenti vivaci, suggeriva la prorompente energia dei bambini.
Stava commentando delle registrazioni video allo scopo di illustrare il lavoro di ricerca sull’interazione madre/bambino e come si potessero applicare queste ricerche all’interazione analista/paziente. Vorrei riportare alcune frasi per me salienti del suo discorso, estrapolate dai miei appunti personali:
«[…] Tutte queste persone sono volontari che hanno lavorato con me 10 anni per codificare i dati. Guardate ora: una videocamera è puntata sul bambino e una sulla madre. Guardate: stanno sorridendo. Gli occhi sono completamente aperti. È un concerto di sorrisi! – mi piace – tutto è completamente aperto, sia il loro viso, che il loro ritmo vocale, le loro mani […]».
«Il modo solito in cui le persone usano la infant research per il trattamento degli adulti è quello di pensare ad un quadro più ricco e completo dello sviluppo precoce del bambino o del paziente. Ma non è questo ciò che sono interessata a fare io. Ciò che faccio io, invece, è osservare come funziona l’interazione. Il mio interesse è rivolto ai principi organizzatori dell’interazione. Nonostante sia interessante pensare a come possa essere andata la storia precoce del paziente, non è quello il mio interesse principale. Il mio interesse principale ai fini dell’obiettivo terapeutico è come va, cosa succede “tra te e me”. Giusto? Come va la comunicazione “tra te e me”. Quindi mi chiedo se l’infant research possa informare i terapeuti per adulti su cosa essi fanno a livello non-verbale con i loro pazienti […]».
«Cos’è il sistema diadico nella comunicazione? Il sistema diadico è tutto questo: come io influenzo te, come tu influenzi me, come io ti sorrido e tu mi sorridi a tua volta[…]».
«Quando ero all’università le persone pensavano che la rappresentazione fosse simbolica e non esisteva qualcosa come la rappresentazione pre-simbolica, e poi nei primi anni ‘80 c’è stata una lunga attività di ricerca da parte di coloro che si occupavano di percezione e cognizione. Essi hanno cominciato ad usare il termine rappresentazione per il genere umano ed era un tipo diverso di rappresentazione, non il tipo di rappresentazione che abbiamo in mente, era una rappresentazione non simbolica, basata su aspettative di azioni […] Perciò le aspettative rappresentazionali del bambino sono spazio, tempo, affetto ed arousal […]».
Questa persona così singolare è Beatrice Beebe, un’autrice fra le più rappresentative della psicoanalisi contemporanea. Da trent’anni si occupa di Infant Research portandone i risultati al cuore della riflessione psicoanalitica. I suoi articoli sono diventati punti di riferimento per gli autori di tutti gli orientamenti che si siano posti il problema di aggiornare o riformulare la teoria evolutiva che sta alla base della psicoanalisi.
Come mai degli analisti bioenergetici sottraevano tempo al meritato riposo per poter ascoltare quello che aveva da dire Beatrice Beebe ad un convegno di psicoanalisti? Certo in altri tempi lo avrebbero fatto per partecipare ai classici laboratori di analisi bioenergetica come quelli condotti, verso la fine degli anni ’60, da Alexander Lowen, John Pierrakos, Stanley Keleman. In questi workshop – come dice ad esempio Robert Hilton: “[…] la stanza era occupata da una trentina di persone che camminavano in cerchio in abbigliamento intimo, aspettando il loro turno per lavorare con uno dei terapeuti, il quale avrebbe letto il loro corpo, detto quale era il loro problema e proposto un lavoro corporeo adeguato […]” (Hilton, 2007, p. 53).
Ovviamente, sono trascorsi da allora molti anni e molte cose sono cambiate e tuttora sono in evoluzione sia nel mondo dell’analisi bioenergetica che, in generale, nei diversi ambiti della psicologia.
- Nuovi sviluppi
La relazione terapeutica ha assunto un’importanza fondamentale in diversi ambiti della psicologia grazie ad una serie di cambiamenti che si stanno verificando in questo variegato mondo. Questi importanti cambiamenti nel mondo della psicologia determinano necessariamente un modo diverso di concepire la relazione terapeutica e impongono una rivisitazione molto profonda del modello terapeutico. Essi provengono in parte dalle neuroscienze, in parte dalle ricerche sull’efficacia terapeutica e soprattutto dai nuovi sviluppi della ricerca nell’ambito della psicologia dell’età evolutiva, che hanno gettato una nuova luce sulla natura dei processi interattivi nelle diadi madre-bambino e nelle relazioni in generale, nonché nella relazione terapeutica in particolare.
Negli ultimi decenni la psicologia evolutiva e la psicologia clinica si sono appropriate di strumenti tipici della psicologia sperimentale. Mentre in passato certe affermazioni venivano solo intuite, ossia erano dedotte dal lavoro clinico, in seguito, invece, sono state verificate, attraverso esperimenti molto sottili, alcuni dei quali sono partiti da contesti psicopatologici.
Oggi si assiste ad una maggiore convergenza tra i modelli della psicologia dello sviluppo e i modelli clinici. È molto difficile scindere, nelle matrici più moderne, i contributi della ricerca sullo sviluppo dai contributi clinici. C’è stata una convergenza di interessi e, fondamentalmente, anche i clinici sono diventati più attenti alla verifica sperimentale. Molti clinici si sono preoccupati di andare a verificare, soprattutto, quello che accadeva nella prima infanzia. Questi studi hanno messo in evidenza degli aspetti che prima non erano così certi ed hanno determinato un modo diverso di lavorare in terapia.
Vi è stata ad esempio una revisione dei vecchi modelli stadiali, sia nella psicologia dello sviluppo che in ambito psicoanalitico. Le ricerche, infatti, hanno sempre più messo in evidenza che lo sviluppo è assolutamente rispondente alle differenze individuali. Quindi possiamo dire che ci possiamo aspettare un certo processo all’incirca in una certa fase, ma questo non è vero sempre e per tutti. Va completamente rivisitato il concetto dello stadio perché nelle crescite reali noi non abbiamo questa corrispondenza. Si è visto che le teorie stadiali classiche non tengono conto delle differenze individuali e spesso la sequenza cronologica degli stadi non è rispettata nella realtà (Stern, 1985).
Anche nella psicoanalisi c’è una parte che dibatte sul fatto che non ci sono delle fasi nella terapia, così come non ci sono delle fasi nello sviluppo psichico fisse e determinate, cioè che parla della possibilità di lasciare il determinismo e lavorare per il processo. (Lichtenberg et al., 1992; Mitchell, 2000).
In realtà, anche il modello analitico bioenergetico era, almeno all’inizio, molto in linea con una prospettiva stadiale. Questo oggi è stato messo in discussione e sta portando ad un cambiamento nel nostro modo di lavorare.
Un altro concetto che oggi sta prendendo più piede, ma che rivoluzionerà le teorie, è che si va avanti, ma si torna pure indietro. Nelle crescite reali, quello che succede ai bambini molto spesso è che apprendono una cosa, ma per un periodo possono ritornare pure indietro – la cosiddetta regressione fisiologica – per poi riandare avanti. Insomma, c’è una serie di regressioni fisiologiche, che sono momentanee e che non si presentano in tutti i bambini. Questi, in neonatologia, sono gli studi di Brazelton. Egli, insieme a Sparrow, parlano di ‘touchpoint’ (Brazelton e Sparrow, 2002; Brazelton, 2006), ossia di questi momenti di andare avanti e tornare indietro. Sono dei momenti di svolta, loro li chiamano momenti di contatto.
La regressione deve essere comunque temporanea, altrimenti si riconosce un problema. Per esempio, il bambino inizia a camminare e poi ritorna carponi, si fa i suoi mesi di carponi e poi riprende a camminare.
Questo in terapia potrebbe suggerire che momenti “regressivi” nel processo terapeutico potrebbero essere considerati fisiologici.
Un altro contributo importante proviene da studi di area neurobiologica. Ad esempio, Trevarthen ha scritto “empatia e biologia” (Trevarthen, 1997), un libro su una serie di studi condotti non solo da lui, ma anche da altri studiosi, di verifica dei meccanismi organizzatori delle diadi comunicative sulle emozioni. Questi studi hanno tentato di connettere quello che succede nell’interazione a qualcosa di più strutturale, sul piano neurobiologico. Hanno mostrato che le interazioni dove c’è uno scambio che ci coinvolge emotivamente sembrano avere un segno profondo nel nostro sistema nervoso centrale. Rispetto all’empatia c’è l’idea che si attivano in particolare le parti del cervello legate alla motricità. Cioè, nel mio entrare in empatia io assumo, in modo non cosciente, il modo di stare posturalmente del mio interlocutore. Si tratta di una cosa che era stata molto discussa a livello di intuizione clinica, ma non era stata mai verificata prima.
- La centralità della relazione in Analisi Bioenergetica
Anche il mondo dell’Analisi Bioenergetica sta vivendo un momento di grande cambiamento, nel quale si cerca una cornice teorica in cui inserire il modello terapeutico.
La teoria dell’analisi bioenergetica classica si basava fondamentalmente sui caratteri di Lowen. I caratteri erano inseriti in un modello psicoanalitico, pulsionale, intrapsichico e da lì, pian piano, l’Analisi Bioenergetica si è mossa verso una maggiore intersoggettività e sulla possibilità di stare di più nella relazione diadica.
Anche la psicoanalisi è passata da una concezione monopersonale con un terapeuta neutrale, ad una in cui è attivo; da una concezione in cui l’analista accompagna il paziente nel processo terapeutico come una guida, mantenendo un atteggiamento anonimo e impersonale, si è giunti ad una concezione relazionale e intersoggettiva dove ogni aspetto del funzionamento della personalità viene ricondotto al contesto relazionale.
La consapevolezza del corpo, del livello di comunicazione non verbale o implicito, le tecniche e gli esercizi, propri dell’approccio analitico bioenergetico, hanno ancora una valenza per noi, ma solo se inseriti in un contesto relazionale. Sono elementi specifici che ci appartengono, ma che ci devono portare ad una valorizzazione di aspetti che avvicinano all’altro, permettendoci di stare di più con l’altro. In sostanza, non dobbiamo cambiare gli strumenti, ma il modo in cui stare col paziente nel setting.
- Il contributo dell’Infant Research
Beebe e Lachmann (2002) hanno scritto un libro: “Infant Research e Trattamento degli adulti”. In questo libro parlano molto sia di tutti gli esperimenti sui bambini sia di come queste esperienze possano facilitare il trattamento degli adulti. In esso sono riportate le prove sperimentali a sostegno del modello della regolazione affettiva della relazione ed hanno messo in luce delle dimensioni che hanno un grande significato per il mondo psicoterapeutico. Di seguito cercherò di esporre gli aspetti che ritengo più salienti e di metterli in relazione con gli spunti che possono offrire per il lavoro clinico.
3.1 Un bambino competente
La ricerca oggi ci mostra un bambino sorprendentemente competente, impegnato fin dalle primissime ore di vita in interazioni interpersonali assai complesse. Già il feto è in grado di regolare il proprio livello di attivazione, ad esempio mettendosi a dormire per difendersi da stimoli spiacevoli. Il neonato è già predisposto ad interagire con le persone per tutta una serie di capacità; ad esempio, nelle prime ore di vita distingue la voce, l’odore e il volto della madre e li preferisce a quelli di una persona estranea; è anche in grado di riconoscere lievi differenze nel ritmo e nell’intonazione del linguaggio. Nasce con la capacità di stimare eventi della durata di frazioni di secondo ed ha una notevole capacità di percezione spaziale.
L’espressione e la percezione degli affetti nel volto del partner, alla nascita sono già molto sofisticati. I neonati hanno modi innati e facilmente osservabili di esprimere gli affetti attraverso il volto, la voce e il corpo. Sono in grado di esprimere interesse, gioia, disagio, disgusto e sorpresa e riescono a percepire gli affetti anche in base al profilo melodico e al tono della voce.
La ricerca mostra che il neonato preferisce un volto gioioso rispetto ad uno arrabbiato, e se la madre mostra una espressione arrabbiata il bambino fa lo stesso, non può sottrarsi in alcun modo all’emozione riflessa sul volto del partner. Come succede anche per gli adulti, la semplice percezione dell’emozione nel partner crea uno stato di risonanza emotiva in chi la percepisce.
Inoltre, nel primo giorno di vita è in grado di riconoscere la propria voce e di distinguerla da quella di altri neonati. Nei primi mesi si crea delle aspettative sugli eventi ambientali e su come si evolveranno le relazioni sociali. A due mesi dimostra già di avere una memoria straordinaria e gli affetti possono influenzare il recupero del ricordo.
3.2 Regolazione interattiva ed autoregolazione
Daniel Stern (Stern, 1971) e i suoi collaboratori hanno svolto un lavoro pionieristico nell’analizzare le interazioni tra madri e bambini filmandoli in varie situazioni. Dal momento che il bambino emette dei segnali per la madre, si può vedere se questa comprende il linguaggio del corpo del bambino – e si è visto che è così. Essi analizzarono i singoli fotogrammi corrispondenti a frazioni di secondi per vedere le reazioni e le espressioni sia delle madri che dei bambini e studiare in tal modo la relazione.
In base a questo tipo di ricerche, Stern aveva parlato di una comunicazione affettiva tra madre e bambino ossia della sintonizzazione affettiva, che è diversa dalla semplice imitazione. Egli aveva notato che una sintonizzazione affettiva efficace si ha quando la madre è in grado di cogliere lo stato affettivo che sottende il comportamento del bambino e di presentare un comportamento che non sia l’esatta riproduzione di quello del bambino, ma che, in qualche modo, vi corrisponda (Stern, 1985, pp. 147-168).
Anche Tronick (1989) aveva parlato nei suoi studi di un sistema reciproco in cui anche il bambino iniziava ad essere un interlocutore competente.
Più recentemente, Beebe e Lachmann hanno studiato il gioco di madri e bambini “normali” a 3-4 mesi dalla nascita in una situazione di rispecchiamento facciale. Madre e bambino siedono una di fronte all’altro, in una stanza vuota. Le telecamere sono poste nelle pareti in modo non invasivo. Alle madri viene chiesto di giocare con i bambini come avrebbero fatto a casa, ed entrambi sono lasciati liberi di interagire. In seguito vengono analizzati i singoli fotogrammi.
Con questo metodo, Beebe e Lachmann hanno documentato l’esistenza di un forte processo di regolazione affettiva bidirezionale. Non è solo la madre che influenza il bambino, ma anche viceversa. Queste ricerche dimostrano chiaramente che i bambini già da piccolissimi sono in grado di modulare le intenzioni di un adulto, modulando, a loro volta, il loro comportamento. Ciò è possibile solo perché hanno nella loro mente la rappresentazione di ciò che la mente dell’altro sta per attivare. Hanno una pre-aspettativa e su questo lavorano per modulare la relazione.
Chiaramente non si tratta d’aspetti espliciti ma di aspetti che il bambino a 3 mesi non è in grado di raccontare. E’ in grado di comportarsi in modo che l’altro abbia la sensazione che lui è un interlocutore molto competente, perché interagisce con l’altro e lo modula. L’altro modula lui, ma lui modula l’altro e lo fa in modo intenzionale, non casuale. Eppure fino a tre o quattro anni non è in grado di raccontare che lo sta facendo.
Affermare che l’adulto e il bambino sono interlocutori competenti non significa che sono simili nella competenza. Si tratta comunque di competenze eterogenee. Le madri sono efficaci nel leggere le emozioni dei loro bambini e i bambini, a loro modo riescono a modulare i loro stati e a sintonizzarsi. I bambini non hanno la stessa capacità della madre, anzi loro usano l’espressione facciale per modularsi.
Tuttavia, per quanto nessuno dei due partner influenzi l’altro allo stesso modo o in misura uguale, entrambi contribuiscono attivamente alla regolazione dello scambio. Gli studiosi hanno denominato questa caratteristica delle relazioni diadiche “regolazione interattiva”.
Il grande merito di Beebe e Lachmann è stato di introdurre, tra i principi che regolano le relazioni, accanto alla regolazione affettiva, l’autoregolazione, ossia la capacità di regolare i propri stati interni, come qualcosa di “fisiologico” per la relazione. Per esempio, il bambino può ridurre il proprio livello di attivazione interno distogliendo lo sguardo, voltandosi, eccetera. Questi ed altri movimenti nell’orientamento spaziale non è detto che sono indicatori di disturbo o di disfunzione, ma rappresentano un’altra dimensione dello stare insieme, cioè un’autoregolazione nella relazione. E non è vero che l’autoregolazione viene prima della regolazione interattiva, ma sono due aspetti che si integrano, nel senso che carenze nell’autoregolazione incidono sulla qualità della regolazione affettiva, come specifiche carenze nella regolazione affettiva incidono sull’autoregolazione.
L’infant research ha dimostrato che i processi fondamentali che regolano l’interazione a livello non verbale sono gli stessi sia nei bambini che negli adulti. La capacità di avviare scambi visivi o vocali della durata di frazioni di secondo è presente sia nell’infanzia che nell’età adulta, e buona parte dell’organizzazione della comunicazione non verbale resta simile per tutta la vita.
Quindi, se è vero che i bambini già da molto piccoli iniziano ad essere ricettivi su una serie di aspetti che sono impliciti, è anche vero che si tratta degli stessi impliciti che ritroviamo nei sistemi organizzatori delle relazioni anche tra i grandi. Essi sono perciò cruciali per la comprensione di quello che accade in psicoterapia.
Beebe e Lachmann suggeriscono al mondo psicoanalitico, alla luce di queste verifiche, il passaggio da una concezione monopersonale ad una bipersonale della regolazione affettiva della relazione, in cui ciascun partner influenza le parole e le azioni dell’altro e ne è influenzato. Essi sostengono che, soprattutto a livello non verbale, madre e bambino, così come analista e paziente, coordinano continuamente i loro ritmi comportamentali. Persino i momenti di “silenzio” verbale o gestuale sono comunicativi.
Paziente ed analista non possono essere più considerati come due entità separate. Ogni membro della relazione terapeutica è influenzato continuamente sia dal proprio comportamento (autoregolazione) sia da quello del partner (regolazione interattiva).
Tutto questo ha anche conseguenze sul nostro modello analitico bioenergetico. Alla luce di queste ricerche, il vecchio modello di Lowen è superato, in quanto le competenze del bambino sono assolutamente maggiori di quello che si pensava. Non c’è un bambino in balia completa dell’adulto. Lo può essere per alcune cose, ad esempio lo è nel senso che non può aprirsi il frigorifero e prendersi una cosa, però è assolutamente capace di interagire.
Inoltre, se l’influenza non è soltanto della madre sul bambino, ma è anche viceversa, tutto questo comporterà una rivisitazione molto profonda del modello terapeutico. Perché si dovrà lavorare non su “io sono il terapeuta e tu sei il paziente”, ma sull’influenza reciproca che c’è nella relazione. Come al bambino vanno riconosciute delle competenze innate, anche nel processo terapeutico vanno riconosciute al paziente delle competenze. Quindi quella terapeutica diventa una relazione bi-direzionale.
Un altro aspetto importante, che anche per noi ha grandi conseguenze è il concetto di autoregolazione come un fatto fisiologico, naturale, nel gioco delle diadi. Ad esempio, anche noi, in Analisi Bioenergetica, a volte, nel non restare nello sguardo e nel distogliere lo sguardo dall’altro, per un po’ di tempo, abbiamo letto una sospensione del contatto emotivo, e lo abbiamo letto anche in termini non molto positivi, in termini di resistenza. Ora, se iniziamo a considerare questo come una forma di autoregolazione, si apre una prospettiva completamente diversa. Una cosa è considerarlo un modo per distanziarsi, altro è sentire che il paziente si autoregola e che anche il terapeuta si autoregola, per “aggiustarsi” nella relazione.
3.3 La sequenza “Caccia e fuga”
Un altro modello interattivo dove regolazione affettiva ed autoregolazione sono intrecciate è la sequenza “caccia e fuga” la quale dimostra che i bambini hanno un modo già da piccolissimi di regolarsi rispetto ad un ambiente che non è congruo e posseggono un vasto repertorio di mezzi per affrontare le intrusioni e, all’occorrenza, per difendersi da esse.
Così gli autori descrivono lo schema d’interazione “caccia e fuga”: “[…] mentre la madre “incombe” sul volto del bambino, il bambino ritrae la testa. La madre lo cerca, gli “dà la caccia” avvicinando la testa e il corpo, mentre il bambino ritrae ancora di più la testa. In questa sequenza, le risposte si succedono in frazioni di secondo, cosicché, ancor prima che la madre abbia completato il movimento della testa verso il bambino, quest’ultimo ha già iniziato ad allontanarsi. Abbiamo a che fare con aggiustamenti reciproci semi-sincronizzati. Dopo che il bambino ha allontanato la testa, la madre si protende per prenderlo. Mentre cerca di prenderlo, il bambino, di riflesso, raddrizza la testa, senza guardarla. Appena la madre lo prende in braccio, il bambino allontana nuovamente la testa. Quindi, ogni sforzo della madre per stabilire un contatto visivo con il bambino è destinato a fallire, e prima che i suoi movimenti siano completati, il bambino le è già ‘sfuggito’ […]» (Beebe e Lachmann, 2002, pp. 103-104).
Nel caso in cui questa sequenza diventi stabile, ossia tipica della coppia, l’esperienza del bambino si organizzerà attorno all’aspettativa di una regolazione affettiva disturbata. Poiché la stimolazione avversiva è contingente rispetto al suo comportamento, il bambino arriverà ad aspettarsi questo tipo di interazione negativa anche in seguito.
Questa sequenza offre una serie di spunti molto interessanti per il lavoro clinico. Ad esempio, uno può riguardare l’uso dello sguardo in terapia. Lo sguardo è una delle cose cui in analisi bioenergetica si riconosce enorme importanza, soprattutto ad uno sguardo che rimanda al paziente un messaggio del tipo “io ci sono, sto qui, posso entrare in empatia con te”. È importante che il nostro sguardo non sia neutro ma nemmeno bisognoso. A volte c’è il bisogno del terapeuta di avere delle conferme attraverso lo sguardo e può succedere che il paziente si viva la cosa come una invasione, proprio come avviene nella sequenza “caccia e fuga”. Così il terapeuta ricerca lo sguardo del paziente, e quest’ultimo mostra uno sguardo evitante. Spesso in questi casi si parlava di resistenza del paziente. La resistenza ha una connotazione negativa. Il paziente resiste e, quindi, se resiste, bisogna farlo smettere in qualche modo.
3.4 Sincronia della comunicazione affettiva
Un terzo modello di regolazione affettiva riportato da Beebe e Lachmann è quello del “timing interpersonale” e si riferisce alla regolazione nell’interazione madre-bambino dei ritmi cinesici, degli scambi vocali simultanei, e alla coordinazione temporale delle interazioni vocali. Gli studi evidenziano che entrambi i partner sono estremamente sensibili alla durata del proprio comportamento e di quello altrui, in quanto la valutano istante per istante e vi si adattano. È stato anche riscontrato che la corrispondenza dei ritmi nella comunicazione visiva e vocale tra madre e bambino è simile a quella dei dialoghi tra adulti.
Sulla base di questo modello di interazione nei primi mesi di vita, è possibile predire lo sviluppo successivo del bambino in termini di attaccamento. In particolare, il grado di coordinazione temporale nel dialogo madre-bambino a 4 mesi è predittivo dell’attaccamento e delle capacità cognitive a 1 anno. Un alto grado di coordinazione bidirezionale è indice di rischio perché predice un attaccamento insicuro-disorganizzato, anche un livello di coordinazione troppo basso riflette una interazione disturbata. Livelli intermedi consentono un attaccamento ottimale.
In realtà gli studi sul “timing interpersonale” rientrano in una vasta serie di ricerche fatte nella psicologia dello sviluppo sulla contingenza o sincronia della comunicazione affettiva (Beebe e Lachmann, 2002). Questi evidenziano che i bambini molto piccoli sono già molto sensibili alla contingenza, alla sincronia. La comunicazione affettiva tra due partner funziona, o meglio c’è, se è sincronica, se è contingente. Ad un “tuo” sguardo io ne reciproco un altro, che non è uguale, ma che vi corrisponde in qualche modo. Se questo non succede, provoca nei due elementi della relazione dei disturbi che, se si accumulano, iniziano a generare alcuni aspetti di insicurezza che chiameremo successivamente insicurezza nell’attaccamento.
La sincronia è stata verificata attraverso due tipi di esperimenti. Uno è quello che hanno condotto la Murray con Trevarthen nell’85 (Murray e Trevarthen, 1985). Un neonato e la propria mamma separati, in una situazione sperimentale di doppio video. Il bambino vedeva la sua mamma perché il video gliela riproduceva e la mamma lo stesso. Il doppio video era messo perché si manipolavano le immagini e si creava un feedback ritardato. Finché il bambino vedeva la mamma reagire alla sua espressione, in modo congruo, egli era in evidente stato di agio, di armonia. Non appena il ricercatore ritardava di qualche secondo la risposta della mamma, il bambino cominciava a stare in uno stato attonito, di confusione, di smarrimento. Anche se questa, per un bambino molto piccolo, è una espressione molto forte, si vede in realtà che il bambino non si vede riconosciuto nell’espressione della mamma.
Un altro esperimento, fatto con bambini di tre mesi di vita, si chiama “il paradigma del volto immobile” di Tronick (Arestia, 2010; Tronick et al., 1978; Tronick, 2008). Dopo due minuti di gioco spontaneo venne detto alle madri di guardare per due minuti il bambino senza cambiare espressione e senza parlare. I bambini sorridevano ed emettevano vocalizzi per richiamare l’attenzione della madre e si mostravano sorpresi per la sua mancata risposta, alternando ai ripetuti tentativi di sollecitare la sua risposta brevi momenti di disimpegno visivo. Tronick ha osservato che gli effetti dell’esperimento del volto immobile persistono alcuni minuti dopo che la madre ha ripreso a giocare normalmente: il bambino diventa scontroso ed evita di guardarla.
Questo esperimento è molto citato quando si parla della patologia borderline perché uno degli aspetti, che nelle storie retrospettive è stato recuperato, è la mancanza, assoluta o quasi, di rispecchiamento e riconoscimento emotivo nel volto delle figure accudenti. Nelle sindromi borderline una delle cose più ricorrenti è di non aver avuto alcun tipo, o scarsissimo, di riconoscimento nel volto, nello sguardo, nell’espressione emotiva, delle proprie emozioni e quindi di aver sperimentato davvero quello che viene chiamato il volto immobile, che è un volto che appartiene molto a persone con una depressione importante. Se proviamo ad immaginare a stare davanti a una situazione in cui l’altro è veramente da un’altra parte: per un bambino è veramente destrutturate.
La non sintonizzazione nella diade primaria ci ricorda tantissimo la non sintonizzazione nella relazione terapeutica. Anche quest’ultima è una relazione di accudimento, tra le altre funzioni che ha. Possiamo anzi affermare che la sintonia è una parte molto importante del processo terapeutico.
Anche se non lo sappiamo, quando ci si incontra, ognuno “sente” dove sta l’altro e ci si mette in sintonia. Dove mi vuole portare l’altro? E io dove voglio andare? Dove vogliamo andare insieme? Questo è quello che non ci si dice, ma che accade, e costituisce la trama non detta della relazione.
La sintonia ha molto a che vedere con la musica, il tempo, il ritmo, la qualità della voce. E la qualità della voce in terapia è fondamentale (Facioni e Gidaro, 2010). Spesso ci viene rimandato di lavorare sulla voce, che a volte è un urlo, come nelle classi, e di integrarla con una qualità della voce che può, pian piano, diventare più una presenza emotiva, una forma a sé di comunicazione. A volte, una voce aggressiva, forte, anche se noi non ci pensiamo, può avere tutta una serie di effetti “stonanti”.
- I tre principi di salienza
Beebe e Lachmann propongono tre principi che stabiliscono quali eventi siano salienti per il bambino e organizzano le sue aspettative sull’incontro interattivo. Essi sono: il principio di regolazione attesa, quello di rottura e riparazione e il principio dei momenti affettivi intensi. Rivediamoli brevemente.
4.1 Regolazione attesa
In base al primo principio, le regolazioni attese e prevedibili attuate durante l’interazione tra madre e bambino creano una serie di aspettative che organizzano l’esperienza del bambino. I tre modelli di regolazione affettiva di cui abbiamo discusso prima, e cioè il rispecchiamento facciale, la sequenza caccia e fuga e la sincronia affettiva, se diventano ripetitivi, creano nel bambino delle aspettative che influenzano le successive esperienze interattive. Così, il modo in cui si evolvono le esperienze relazionali nel primo anno di vita va ad influenzare assolutamente quello che accade nella costruzione del legame affettivo o di attaccamento.
Quanto la figura accudente è stata con il bambino, quanto lo ha riconosciuto, quanto lo ha rispecchiato, tanto questo genera sicurezza nel bambino e la fiducia nelle relazioni. Quanto l’altro è stato per il bambino altalenante o ad intermittenza genera una certa ansietà, un comportamento di maggiore irritabilità, soprattutto rispetto alle situazioni di difficoltà.
Se il bambino si fa male, o non vuole mangiare una cosa, o ha mal di pancia, o sonno, tutte queste cose si manifesteranno in modo diverso a seconda di come le figure importanti sono state accanto a lui, di come sono riuscite a fare queste prime funzioni di rispecchiamento facciale, vocale, di sintonizzazione affettiva.
Anche nella relazione terapeutica, Beebe e Lachmann vedono in atto l’azione del principio di regolazione attesa. Essi affermano: “Nel processo terapeutico, le azioni di entrambi i partner sono intimamente associate, nel tempo, nello spazio, negli affetti e nel livello di attivazione. In ogni partner si organizzano aspettative sul grado in cui egli influenzerà o non influenzerà l’altro, e verrà o non verrà influenzato dall’altro, in vari modi. […] Paziente e terapeuta costruiscono modi caratteristici di porsi domande reciprocamente, di alternarsi nel dialogo e di interrompersi per un certo tempo quando necessario. In questo processo entrambi costruiscono aspettative reciproche, e disconfermano le paure di essere ignorati, forzati, violati, fraintesi o criticati” (Beebe e Lachmann, 2002, p.175-1766).
4.2 Rottura e riparazione
In base al principio di rottura e riparazione, le esperienze si organizzano in base al riconoscimento, da parte del bambino, di qualcosa che modifica o “rompe” l’interazione, violando le sue aspettative, e al conseguente sforzo di riparare la rottura. Le ricerche hanno sottolineato il profondo impatto organizzante delle interazioni di rottura e riparazione. I bambini sono attenti alle conferme o alle violazioni delle aspettative, e ne sono influenzati profondamente. La conferma di una aspettativa è associata a un affetto positivo, mentre la sua violazione ad uno negativo.
Inoltre, nelle interazioni normali e positive si è riscontrato che vi sono molti stati poco coordinati ed una forte tendenza a correggere l’interazione ritornando brevemente a stati più sintonizzati. Queste esperienze di rottura e riparazione aumentano il senso di efficacia del bambino, sviluppano la capacità di controllo degli eventi e contribuiscono all’aspettativa di partecipare insieme al partner al processo di riparazione. In questo modo il bambino impara ad aspettarsi che la riparazione sia possibile e questo rende possibile lo sviluppo di un attaccamento sicuro.
In generale, una cosa interessante che emerge da queste ricerche è che c’è tutta una serie di rotture nella relazione che hanno la funzione di proteggere la relazione, paradossalmente, non per romperla.
Una relazione che porta allo sviluppo di un attaccamento sicuro è sicuramente quella dove i partner si sintonizzano, rompono questa sintonia e fanno diverse esperienze di riparazione. È molto diversa da quella relazione in cui non si sintonizzano e non riescono a riparare.
Una conseguenza per il lavoro clinico è che come le altre relazioni, anche la relazione terapeutica è normale che abbia rotture e riparazioni. Quindi, a volte, certi pazienti troppo bravi, che non sentiamo compiacenti, dovrebbero allarmarci e portarci a chiederci cosa non va. I bambini che da piccoli non danno alcun tipo di problema, più o meno sono riconosciuti oggi come “silenziosamente a disagio”. Quindi, anche nella relazione terapeutica non vi è solo la sintonizzazione tout court, ma una delle cose, che sembrano più utili e funzionali, è riuscire ad affrontare nella relazione delle rotture ma anche a ripararle.
In sintonia con l’infant research che sottolinea che uno dei punti salienti nella costruzione delle relazioni sono proprio le rotture/riparazioni, anche le ricerche sull’alleanza terapeutica (Lingiardi, 2002) si concentrano sulle rotture e riparazioni.
Queste ricerche portano a concludere che le rotture e riparazioni sono l’essenza del cambiamento, non inconvenienti da risolvere ma aspetti trasformativi. Nell’affrontare una rottura dell’alleanza, il terapeuta non dovrebbe considerarla un semplice malfunzionamento della relazione terapeutica, un inconveniente da risolvere al più presto, bensì un punto di partenza potenzialmente trasformativo.
Questo impone un modo nuovo di lavorare. Il vecchio concetto era lavorare sulla rottura come su una resistenza. Se invece, si considera la rottura come funzionale alla relazione terapeutica e questa cosa può essere elaborata col paziente, il paziente comprende che è il suo bisogno di prendere il suo spazio nella relazione e può cominciare a trovare una modalità diversa. Se noi in questo caso la leggiamo in questo senso, la rottura diventa molto funzionale alla terapia.
Inoltre, il paziente viene anche riconosciuto nella sua possibilità di creare un ritmo alla relazione, che non deve essere per forza il legame atteso dal terapeuta. È un legame che si costruisce e che viene modulato da entrambi e quindi anche dal paziente. Anche permettere all’altro di stare in una situazione di rottura dell’alleanza è terapeutico.
4.3 Momenti affettivi intensi
In base al principio dei momenti affettivi intensi, esperienze affettive intense possono avere un impatto notevole sull’organizzazione dell’esperienza da parte del bambino. L’esperienza di fusione del bambino che si addormenta sul seno materno, o gli attacchi d’ira, sono esempi di affetti intensi. Nel primo caso i momenti intensi organizzano una esperienza di controllo sul proprio corpo, nel secondo caso organizzano una esperienza di perdita di controllo.
Nell’ambito dell’interazione fra paziente e terapeuta, i momenti affettivi intensi offrono l’opportunità di nuove esperienze, consentono di rivivere affetti antichi e rappresentano la possibilità di una nuova forma di intimità nella relazione.
Conclusione
Sono molto affascinato dal modo in cui si sta evolvendo il modello terapeutico in Analisi Bioenergetica. Credo che stia emergendo un modo di lavorare nella relazione terapeutica molto interessante e di grande qualità. Mi piace in particolar modo l’umanità, la dignità e il profondo rispetto per la persona che caratterizzano queste nuove modalità.
Beebe e Lachmann concludono il loro libro affermando: “il contributo dell’infant research va oltre la sua applicazione al trattamento degli adulti…. Essa ci offre un quadro sistematico dell’origine dei processi mediante i quali ci mettiamo in relazione con noi stessi e con gli altri” (Beebe e Lachmann, 2002, p. 216).
Ai bambini che hanno reso possibili queste ricerche va la nostra massima gratitudine, ed a loro dedico le parole di Daisaku Ikeda: “I bambini sono i messaggeri venuti dal futuro. Non abbiamo altra scelta che affidare a loro il nostro mondo. Io ho fiducia nei bambini. Credo nella loro capacità di crescere e svilupparsi” (Ikeda, 2007, p. 1).
Note.
(**) Convegno internazionale con BEATRICE BEEBE presentato dall’ ISIPSÉ Istituto di Specializzazione e Scuola di Psicoterapia in Psicologia Psicoanalitica del Sé e Psicoanalisi Relazionale il 29-30 Maggio 2010 a Roma.
Bibliografia
Arestia, E. (2010). “Recensione: Ed Tronik – Regolazione Emotiva nello sviluppo del processo terapeutico”. Corpo Narrante, 2
Beebe B., Lachmann F. M. (2002), trad. it: Infant Research e Trattamento degli adulti, Milano: Raffaello Cortina, 2003.
Brazelton T. B., Sparrow J. D (2002), trad. it.: Il bambino da tre a sei anni. Milano: Rizzoli, 2008.
Brazelton T. B., (2006), trad. it.: Il bambino da zero a tre anni. Guida allo sviluppo fisico, emotivo e comportamentale del bambino. Milano: Rizzoli, 2008.
Facioni T., Gidaro V. (2010). “La voce che rivela”. Corpo narrante, 2
Hilton, R. (2007), “Analisi bioenergetica e modelli di intervento terapeutico”, in Grounding, 1, pp. 53-54.
Ikeda, D. (2007) I tesori del futuro, sogni e speranze per le gemme del domani. Milano: Esperia.
Lichtenberg J. D., Lachmann F. M., Fosshage J. L. (1992) trad. it.: Il Sè e i Sistemi Motivazionali, Verso una teoria della tecnica psicoanalitica. Roma: Astrolabio, 2000.
Lingiardi V., (2002) L’ alleanza terapeutica. Teoria, clinica, ricerca. Milano: Raffaello Cortina.
Mitchell S. (2000), trad. it.: Il modello relazionale. Dall’attaccamento all’intersoggettività. Milano: Raffaello Cortina, 2002.
Murray, L., Trevarthen C., (1985), “Emotional regulation of interactions between two-month-olds and their mothers”, in Field T. , Fox N . (a cura di) Social perception in infants, Ablex, Norwood, NJ, pp. 137-154.
Stern, D. N. (1971), “Una microanalisi dell’interazione madre-bambino” in D. N. Stern (a cura di), Le interazioni madre-bambino. Milano: Raffaello Cortina Editore, 1998, pp. 501-517.
Stern, D. N. (1985), trad. it.: Il mondo interpersonale del bambino. Torino: Bollati Boringhieri, 1987.
Stern D. N. (1998), Le interazioni madre-bambino. Milano: Raffaello Cortina.
Trevarthen C., (1997), trad. it: Empatia e biologia. Psicologia, cultura e neuroscienze. Milano: Raffaello Cortina, 1998.
Tronick, E. Z., Als, H., Adamson, L., Wise, S., & Brazelton, T. B. (1978). “The infant’s response to entrapment between contradictory messages in face-to-face interaction” in American Academy of Child Psychiatry, 17, pp. 1-13.
Tronick, E. (1989) trad. it.: “Le emozioni e la comunicazione affettiva del bambino”, In Riva Crugnola, C. (a cura di), La comunicazione affettiva tra il bambino e i suoi partner. Milano: Raffaello Cortina, 1999, pp. 41-62.
Tronick, E. (2008), Regolazione emotiva nello sviluppo e nel processo terapeutico. Milano: Raffaello Cortina.
(*) Psicologo, Psicoterapeuta.