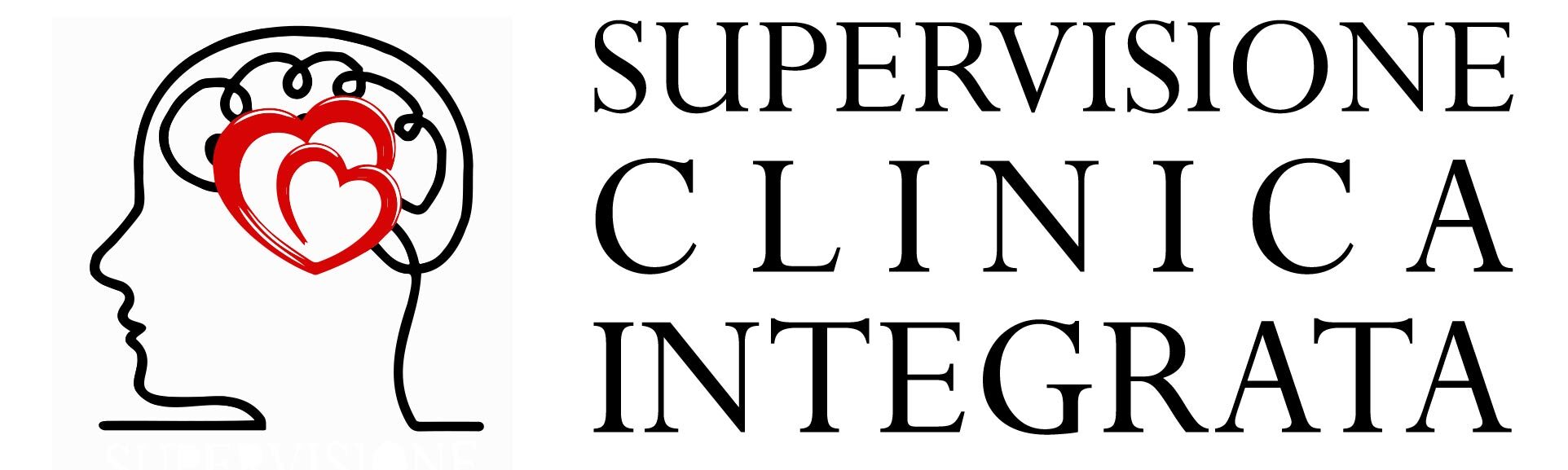Desiderio, relazioni e piacere digitale
Il testo analizza come la società moderna, caratterizzata da eccessiva connessione e visibilità, privilegi il bisogno immediato rispetto al desiderio. Utilizzando il Modello Biodinamico ® , il quale integra visioni psicodinamiche e bioenergetiche, si esamina l’impatto delle app di incontri sulle relazioni, evidenziando come la predominanza dell’interazione virtuale e la mancanza di contatto fisico influenzino la connessione emotiva e la soddisfazione relazionale. Si riflette anche sugli effetti di queste dinamiche sulla salute mentale, evidenziando che l’inibizione del desiderio può complicare la crescita psicologica, come sostenuto da Carl Jung.
(*) Violante Veronesi
“L’uomo moderno è affamato di desideri artificiali, creati e alimentati dalla società dei consumi, che lo distolgono dai suoi veri bisogni e lo portano verso l’alienazione.”
E. Fromm, 1976
Abstract
Viviamo in una società iper-connessa, iper-visibile, iper-assimilante, iper-attiva. Una società che sembra essere più vicina alla dimensione psichica del bisogno che a quella del desiderio. Un bisogno che deve essere immediatamente gratificato, che rimanda a una dimensione di urgenza, impellenza, compulsività. Il desiderio e la sua funzione di attesa rispetto “all’oggetto desiderato” evoca lontananza, distanza, carenza.
Alla luce del Modello Biodinamico ®, la lente Psicoterapica che integra la visione Psicodinamica e quella Psicocorporea Bioenergetica, esploriamo come i cambiamenti culturali e tecnologici interagiscano o interferiscano con le relazioni umane.
Osservando la relazione tra desiderio e gratificazione immediata ci siamo chiesti: come la disponibilità immediata di connessioni tramite app di incontri influenza la profondità e la durata delle relazioni? Cosa porta le persone a conoscersi tramite APP e cosa comporta conoscersi in questa forma?
Rispetto alle dinamiche mente-corpo e al principio di identità funzionale che li lega: come la mancanza di contatto e il predominio delle interazioni virtuali influenzano la connessione emotiva e la soddisfazione relazionale?
Quale l’impatto di queste forme di amori moderni sulla salute mentale?
Sappiamo che il comportamento umano è guidato da una successione di riflessioni su costi e benefici che determinano se un’azione verra’ ripetuta più volte, oppure mai. Quando i costi superano i benefici, quando il costo di stare nella dimensione del desiderio è più alto del beneficio (a volte illusorio e ingannevole) della soddisfazione del bisogno immediato, può essere compreso come le persone si muovano nella direzione dell’agire il bisogno, piuttosto che tollerare e contenere eventuali sensazioni percepite spiacevoli, associate all’attesa del coronamento del desiderio.
Tuttavia l’inibizione della funzione desiderante può rendere molto complessa l’evoluzione psicologica. In altre parole, di Carl Jung (1976): ”il desiderio è l’elemento centrale della vita psichica, poiché rappresenta l’energia vitale che spinge verso la crescita e l’auto-realizzazione.”
- Relazionarsi in un mondo “digital”
La riflessione sui mutamenti che stanno coinvolgendo le relazioni del nuovo millennio non può prescindere una considerazione sui cambiamenti culturali avviati dalla rivoluzione digitale, in particolare per quanto riguarda le applicazioni di incontri. Queste piattaforme offrono la possibilità di incontrare qualcuno la sera stessa o mai; gli incontri possono nascere virtuali e rimanere tali, oppure evolversi in interazioni reali. La digitalizzazione delle relazioni introduce dinamiche nuove e complesse. Da un lato, consente di superare barriere geografiche, permettendo di esplorare nuove connessioni. Dall’altro, può promuovere relazioni superficiali, basate sull’immagine e sulla gratificazione immediata, piuttosto che sulla costruzione di legami. La tecnologia facilita la connessione, ma va a creare una inevitabile distanza. Le relazioni digitali mancano della dimensione corporea e non verbale che è fondamentale per il benessere psicologico. Il contatto, tra le altre cose, stimola il rilascio di ossitocina, ormone che promuove il legame emotivo e riduce lo stress (Heinrichs et al., 2003). La mancanza di segnali non verbali nelle interazioni virtuali può portare a una disconnessione emotiva (Mishna et al., 2012). L’affidamento esclusivo alle interazioni virtuali può portare a sentimenti di solitudine e isolamento (Primack et al., 2017). Le relazioni costruite esclusivamente online possono portare le persone ad essere molto insoddisfatte (Sprecher, 2011). La dipendenza dalle interazioni virtuali può ridurre le competenze sociali nel mondo reale, ostacolando la capacità di formare relazioni significative faccia a faccia (Kuss & Griffiths 2011). La dicotomia tra se digitale e se reale può creare dissonanza e conflitti interni, influenzando negativamente l’autostima e il senso di identità. Inoltre, l’anonimato e la distanza fisica offerte dalle piattaforme digitali possono portare a comportamenti meno responsabili e più disinibiti, spesso lontani dalla realtà di chi si è veramente.
Noi Psicoterapeuti ascoltiamo ogni giorno storie di persone che ci raccontano quanto le app oggi siano una conditio sine qua non, per conoscere e farsi conoscere. Sono utilizzate in modi diversi: per amicizia, amore, sesso, nulla. Alla luce di queste considerazioni, è importante promuovere una riflessione sul modo in cui si sta utilizzando la tecnologia nelle relazioni e sul valore di mantenere un equilibrio tra il mondo digitale e quello reale. Le relazioni richiedono tempo e soprattutto la capacità di essere disponibili fisicamente ed emotivamente.
- Il contatto
L’essere umano moderno sembra avere sviluppato un piacere nel digitare. Lo schermo si sta sostituendo alla pelle. Talmente assorbiti dal touch-screen, si rischia di dimenticare la bellezza del con-tatto.
Il significato umano del tatto è notevolmente più profondo di quanto spesso si riconosca. Il tatto è uno dei sensi più importanti del nostro corpo. L’esperienza tattile e la sua mancanza influenzano lo sviluppo del comportamento e la creazione di una “memoria della pelle” (Montagu, 1971). Tra i sensi, il tatto è il primo a formarsi a livello embrionale, rappresentando il primo ponte di collegamento tra il nuovo essere e il mondo esterno. Essendo la pelle uno degli organi più precoci nello sviluppo embrionale, la funzione del contatto si configura come un bisogno primario dell’uomo. Grazie a una serie di studi condotti sul mondo animale, è stato illustrato quanto la stimolazione cutanea sia fondamentale per un sano sviluppo. L’osservazione del comportamento animale dimostra quanto la necessità di essere accarezzati sia una necessità biologica. La stimolazione cutanea nella prima infanzia, nelle diverse forme che può assumere, esercita un’influenza altamente benefica: ha un’incidenza decisiva nello sviluppo dei rapporti emotivi e affettivi. È possibile affermare che il bisogno di stimolazione tattile dovrebbe essere aggiunto all’elenco delle necessità fondamentali di tutti gli esseri viventi. Nessun organismo può sopravvivere a lungo senza stimolazione tattile proveniente dall’esterno, cioè senza contatto, inteso come piacevole sensazione della pelle di un altro sulla propria. Il tatto, nelle varie forme che può assumere, dal semplice contatto corporeo alla massiccia stimolazione tattile legata al rapporto sessuale, è fondamentale. Come nel rapporto sessuale, in nessun’altra situazione la pelle si vede così completamente coinvolta e implicata. Vi sono importanti collegamenti tra la stimolazione tattile in epoca infantile e il tipo di rapporti sessuali che si vivono nella vita adulta.
- Il selfie – Piccolo Sé
Tendenzialmente in ogni profilo, su qualsiasi applicazione, ci si presenta con un SELFIE. Da un punto di vista semantico il selfie è un piccolo se’, un aspetto dell’identità, la riproduzione dell’immagine di sé. Ha un’importante relazione con la sperimentazione dell’identità. É stato descritto come una celebrazione dell’io (Ruthledg, 2022). É stata proposta la riflessione sulla differenza tra selfie e autoritratto pittorico: il selfie è caratterizzato dalla velocità e dalla superficialità, ha bisogno di un tempo brevissimo per la sua realizzazione e coinvolge in modo tangenziale e piuttosto effimero il pensiero dell’autore. L’autoritratto invece richiede precisione ed elaborazione del pensiero e delle emozioni durante la sua esecuzione. L’avvento della fotocamera frontale e la comparsa delle piattaforme social hanno reso estremamente più fruibile e rapido il processo di auto rappresentazione, che appartiene alla nostra specie e che si lega con forza al tema dell’identità e alla la rappresentazione di sé. In chi guarda un selfie è impossibile far penetrare il proprio sguardo in profondità (Spaccarotella, 2019). Ricercatori di tutto il mondo stanno iniziando a comprendere la vasta portata del fenomeno non solo da un punto di vista sociologico ma anche psicologico, osservando e studiando quali motivazioni sociali e soggettive possono essere coinvolte nella massiccia diffusione degli autoscatti.
Nel selfie chi guarda chi? Questa domanda che può sembrare curiosa, introduce la tematica del rapporto con lo specchio e quindi con lo sguardo e svela il principio che distingue un’azione che faccio per me, da una che ha bisogno della presenza dell’altro.
Se mi guardo allo specchio o mi faccio un selfie allo specchio, lo sguardo in questione è solo il mio. Se mi guardo allo specchio e scatto un selfie e lo invio a qualcuno, lo sguardo in questione non è più solamente il mio, ma quello di un pubblico. E lo sguardo dell’altro di norma torna indietro attraverso un commento, un giudizio, un’emoticon e si trasforma in un feedback, in una valutazione: in qualche modo diventa l’immagine di me, che l’altro mi restituisce.
Qui si può comprendere il passaggio concettuale dall’autoritratto inteso come atto unico e teso alla rappresentazione di sé, al selfie riconoscibile come atto ripetibile all’infinito e orientato al racconto di se. Dunque lo smartphone assume le funzioni di uno specchio simbolico e materiale e se lo scatto non piace si può rifare ancora e ancora e ancora. Raggiunta l’immagine desiderata si può modificarla con filtri. Questo processo di modifica continua crea un sé ideale che gli altri vedono per come si vorrebbe apparire o come si desidererebbe diventare. Questo può portare alla creazione di un alter ego virtuale che, sebbene verosimile, non è reale. Può sorgere un divario tra il sé reale e quello idealizzato, portando a una dissonanza tra identità virtuale e reale (Spaccarotella, 2019).
- L’intimità e lo sguardo
Sembra si stia verificando un passaggio dall’intimità all’extimità, un concetto proposto dallo Psicologo Michele Spaccarotella nel testo Il Piacere Digitale (2019). Oggi sappiamo essere molto diffuso il bisogno di rendere pubblici aspetti personali e a volte intimi per farli conoscere e convalidare tramite la condivisione online. Viene spontaneo chiedersi se questo bisogno di approvazione esterna a volte inconsciamente agito con il fine di aumentare l’autostima, non stia in realtà rendendo le persone più insicure e dipendenti dallo sguardo degli altri, facendo a tratti o totalmente perdere di vista ciò che è più prezioso: la propria intimità. Non tutto ciò che è intimo necessita di essere condiviso o sottoposto al giudizio di un like.
Il corpo online è diventato l’impero dello sguardo e la dinamica dei social può far sì che si smetta di interessarsi agli altri in quanto tali, preoccupandosi solo del modo in cui si verrà guardati e visti.
Lo sguardo dei social network e delle app è spesso fondato su un’azione filo – esibizionistica, che può attivare una curiosità di tipo voyeuristico, mentre paradossalmente nell’agito voyeurista c’è l’estrema paura di entrare in relazione (sessuale) con l’altro, che può essere solo guardato. Nelle relazioni digitali, a ben vedere, questi due atteggiamenti prendono forma: si può mostrare in maniera approfondita ogni parte del corpo, sperando di suscitare reazioni di eccitazione degli altri e si ha la possibilità di guardare il corpo degli altri, senza il timore di essere visti. Il confine tra voyeur e persona che sbircia i profili altrui diventa molto labile. La domanda che viene spontanea è: ci troviamo forse all’interno di un sistema disfunzionale che si autoalimenta? Il corpo è la casa che abitiamo, simbolicamente e materialmente. È interessante riflettere su come il corpo viene mostrato e proposto all’attenzione degli altri, specialmente con l’avvento delle nuove tecnologie. Possiamo parlare di corpi digitali? Stiamo parlando di un corpo, come di relazioni, che subiscono un’idealizzazione e una virtualizzazione. Un corpo trasformato in un oggetto ambivalente da mostrare online, ma spesso da celare alla presenza reale. Un corpo ridotto a un’idea di presenza. Un corpo che ha bisogno di sentirsi raggiungibile, accessibile, ma che allo stesso tempo teme l’altro, che va tenuto a debita distanza e che può essere allontanato da sé semplicemente disconnettendosi.
Questa dinamica evidenzia una tendenza dissociativa tra l’immagine virtuale e la realtà interna percepita. L’interazione online può portare a una perdita del senso di autenticità e intimità, poiché le relazioni virtuali possono rivelarsi superficiali e fugaci.
La consapevolezza di come questi strumenti influenzano le percezioni e relazioni può aiutare a utilizzarli in modo più sano e consapevole, investendo maggiormente su interazioni più autentiche e significative.
- Perchè incontrarSi in chat
Ci sono alcune caratteristiche specifiche delle “app” che possono spingere gli individui a preferirle rispetto ai corteggiamenti o incontri di persona. E’ più facile raccontarsi ed essere disinibiti. Con maggiore facilità si possono trasferire sull’interlocutore un insieme di qualità che si stanno ricercando attivamente nella nuova conoscenza (idealizzazione). Nessun limite di tempo, luogo e lingua. Si ha molto tempo per pensare ad una risposta (magari anche interpellando l’intelligenza artificiale), quindi nessun imbarazzo. Parlare in assenza della corporeità dell’altro, dello sguardo dell’altro, consente un dialogo “libero” e meno impacciato: anche i più timidi sono più inclini a tirar fuori se stessi. Parlare per molto tempo con la stessa persona crea quel clima di familiarità che alla lunga ara nello scambio più riservato e confidenziale. La fluidità data dalla connessione permette di chattare con più persone nello stesso momento (poli contatti) senza dover rinunciare a nessun tentativo di flirt, in una sorta di bulimia relazionale. Ci si può mostrare migliori di come si è realmente: facendo perdurare così la fase dell’idealizzazione e manifestando quella naturale tendenza del genere umano a falsificare (anche solo un po’) il modo in cui appare al mondo. Tutto quello che viene scritto e inviato può essere cancellato, può sparire (elimina per tutti). Lo spazio della chat viene vissuto come un rifugio accogliente, nel quale l’altro /sconosciuto paradossalmente può svolgere la funzione dell’elemento rassicurante al quale si può ricorrere nel momento del bisogno.
Tra le altre, queste caratteristiche possono rendere le chat mezzi attraenti per la socializzazione, ma possono anche favorire l’instaurarsi di percezioni distorte delle e tra le persone ed incrementare l’evitamento degli stress che le persone associano all’incontrarSi dal vivo. Di certo sappiamo che tutto merita di essere contestualizzato, che stiamo assistendo ad un cambiamento epocale in ambito relazionale e che le persone stanno sperimentando nuovi mezzi di comunicazione e di incontro. Sarebbe superficiale non riflettere un po più a fondo sulla questione.
- Relazioni digitali e salute mentale
Le app di incontri, come Tinder, Bumble e altre hanno rivoluzionato il modo in cui le persone si connettono romanticamente e sessualmente: questo ha portato con sé nuove sfide ed anche potenziali impatti sulla salute mentale. Di seguito una panoramica più ampia degli effetti che sono stati documentati. Le app di incontri offrono una vasta gamma di potenziali partner, il che può sembrare positivo, ma può anche portare a un sovraccarico di scelte. Il paradosso della scelta, come descritto da Barry Schwartz (2004), suggerisce che troppi options possono causare stress e insoddisfazione cronica. Gli utenti possono sentirsi sopraffatti e indecisi, preoccupandosi costantemente di fare la scelta sbagliata.
L’abbondanza di opzioni può portare alla paura di perdere opportunità migliori (FOMO, fear of missing out), causando stress e indecisione cronica. Gli utenti possono sperimentare sentimenti di insoddisfazione costante, temendo di non trovare mai la “persona giusta” (Schwartz, 2004).
L’esperienza di rifiuto può essere amplificata nelle app di incontri, dove le interazioni sono spesso brevi e superficiali. Uno studio pubblicato su Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking ha trovato che le esperienze di rifiuto e interazioni negative possono influenzare negativamente il benessere emotivo degli utenti (Smith et al., 2020).
Gli utenti delle app di incontri possono sviluppare ansia da prestazione, preoccupandosi costantemente di come appaiono nelle loro foto o di come vengono percepiti dagli altri (Sprecher,, 2011).
Le app di incontri facilitano la comparazione sociale, dove gli utenti confrontano costantemente se stessi con gli altri. Questa comparazione può portare a sentimenti di inadeguatezza, dispercezione corporea, bassa autostima e comportamenti alimentari disordinati (Fardouly et al., 2015).
Gli utenti delle app di incontri possono diventare dipendenti dal feedback esterno, come i “like” e i “match”, per il loro senso di valore.
L’uso delle app di incontri può anche esacerbare l’ansia sociale. Le interazioni online possono sembrare meno minacciose, ma possono anche ridurre le opportunità di sviluppare competenze sociali nel mondo reale.
Altri studi rilevanti, come ad esempio quelli di Finkel e Eastwick (2008) evidenziano che le scelte rapide e le interazioni multiple riducono l’investimento emotivo, portando a relazioni più brevi e meno profonde, con implicazioni negative per la salute mentale degli utenti. Le app di incontri possono facilitare incontri rapidi che possono portare a comportamenti sessuali a rischio. L’anonimato e la facilità di accesso possono aumentare la probabilità di incontri non sicuri (Garofalo et al., 2020)).
Alcuni utenti possono sviluppare una dipendenza dalle app di incontri, sentendo il bisogno di controllare costantemente i loro profili e interazioni. Questo può interferire con le attività quotidiane e le relazioni reali (Kang et al.., 2020).
Le app possono promuovere relazioni superficiali e transitorie, dove l’attenzione è più sulla quantità che sulla qualità delle connessioni. Questo può portare a un senso di vuoto emotivo (Bouffard et al., 2022). La valutazione continua da parte degli altri utenti può portare a una percezione negativa di sé stessi, soprattutto se i riscontri ricevuti sono per lo più negativi o insoddisfacenti (Kang et al.., 2020). Diversi studi hanno esaminato come l’uso di queste piattaforme possa essere associato a livelli più alti di stress, ansia, sintomi depressivi e bassa autostima. Gli utenti possono sperimentare sentimenti di solitudine e isolamento quando le interazioni non portano ai risultati desiderati. (Tang et al., 2021). Le persone con esperienze relazionali traumatiche possono mostrare sintomi di evitamento, preferendo le interazioni virtuali per evitare il rischio di ulteriori ferite emotive (APA, 2013).
- Tendenza all’Evitamento e Dimensione Post-Traumatica
La tendenza all’evitamento degli incontri faccia a faccia può essere collegata anche ad una dimensione post-traumatica, dove esperienze passate negative o traumatiche influenzano il comportamento e le preferenze relazionali attuali. Questa tendenza può emergere come meccanismo di difesa per evitare il dolore e il disagio associati alle interazioni dirette. Il trauma relazionale si verifica quando una persona subisce esperienze emotivamente dolorose e traumatiche nelle relazioni interpersonali, come l’abbandono, il tradimento o l’abuso. Queste esperienze possono lasciare cicatrici emotive profonde che influenzano il modo in cui una persona si relaziona con gli altri in futuro. Gli individui con trauma relazionale possono mostrare sintomi di evitamento, evitando situazioni che ricordano loro il trauma originale. Questo per evitare il rischio di ulteriore dolore emotivo.
Il Disturbo da Stress Post-Traumatico – PTSD include sintomi di evitamento in cui le persone evitano attivamente situazioni, luoghi o persone che ricordano loro l’evento traumatico. Le esperienze traumatiche nelle relazioni passate possono portare a preferire le interazioni virtuali, che offrono un ambiente percepito come più sicuro, perché si sente di avere più controllo sulla situazione. Le app di incontri permettono agli utenti di stabilire connessioni a loro ritmo, con la possibilità di interrompere la comunicazione in qualsiasi momento senza conseguenze dirette. Questo ambiente di basso rischio è particolarmente attraente per chi ha esperienze traumatiche: possono servire come un rifugio sicuro per coloro che hanno paura dell’intimità fisica, permettendo loro di esplorare le relazioni senza il rischio immediato di ferite emotive.
Il ciclo di evitamento può rafforzare i sentimenti di inadeguatezza e bassa autostima e può perpetuare l’isolamento e la solitudine, poiché le persone evitano le situazioni che potrebbero aiutarle a guarire e a costruire relazioni più sane.
- Benefici degli Incontri Virtuali: Evidenze dalla Letteratura
Gli incontri virtuali, facilitati dalle app di incontri, offrono anche vantaggi. Danno la possibilità di connettersi con un vasto numero di persone che altrimenti non sarebbe possibile incontrare. Questa accessibilità aumenta le probabilità di trovare partner compatibili, specialmente per chi vive in aree con limitate opportunità sociali (Castro et al., 2020). Possono aiutare le persone che si sentono isolate o hanno difficoltà a socializzare a trovare connessioni significative. Possono essere particolarmente utili per gruppi di persone che possono avere meno opportunità di socializzazione tradizionale (Lin, J., & Lundquist, J., 2020). Permettono di risparmiare tempo nella ricerca di un partner, fornendo strumenti per filtrare i potenziali incontri basati su interessi comuni, valori e obiettivi di relazione. Questo rende il processo di selezione più mirato e efficiente (Smith, J., & Johnson, A., 2020). Permettono di connettersi con gli altri in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, offrendo una flessibilità che le interazioni faccia a faccia non possono garantire. Questo è particolarmente utile per persone con orari di lavoro impegnativi o che viaggiano spesso (Smith, 2020). Offrono uno spazio sicuro per esplorare la propria identità e preferenze relazionali. Questo può essere utile per chi è in fase di esplorazione della propria sessualità (Smith, J., & Johnson, A. (2020).
Conclusioni
Siamo solo all’inizio in questo studio su come le app di incontri influenzino lo sviluppo psicologico delle persone e viceversa e quali siano le implicazioni di queste interazioni digitali. Di certo hanno trasformato il modo in cui le persone si connettono e si relazionano.
Abbiamo proposto una panoramica ovviamente non esaustiva degli effetti psicologici e sociali delle app di incontri e della ricerca del piacere digitale, evidenziando le complessità delle relazioni virtuali e le loro implicazioni sulla salute mentale.
La review sulla letteratura empirica evidenzia come abbiano modificato i percorsi tradizionali di socializzazione e promosso nuovi modi di incontrare partner romantici e sessuali, trasformando le dinamiche relazionali, privilegiando il bisogno immediato rispetto al desiderio profondo. Nelle app di incontri, la gratificazione immediata si manifesta nella possibilità di trovare potenziali partner rapidamente, spesso basando le decisioni su criteri a volte superficiali. Il desiderio, invece, implica una ricerca e una costruzione lenta di aspettative e attrazioni che richiedono tempo e sviluppo. Le relazioni costruite sul desiderio, basate su connessioni emotive e valori condivisi, tendono a svilupparsi in modo più profondo e significativo.
Abbiamo visto gli esiti sulla salute mentale, ovvero livelli più alti di stress, ansia, depressione e bassa autostima, rispetto a chi non le utilizza. Sappiamo che il crescente bisogno/fenomeno di condivisione pubblica della propria intimità per ottenere approvazione e validazione può alimentare insicurezze, portando le persone a dipendere dallo sguardo degli altri per la propria autostima. La mancanza di contatto fisico va ad influenzare negativamente le relazioni. Il corpo digitale rischia di diventare un oggetto esibito, mentre la connessione reale e autentica viene trascurata.
Il setting terapeutico assume un ruolo fondamentale come luogo di regolazione dello stress relazionale. La Psicoterapia può aiutare a ristabilire il contatto con il proprio corpo e le proprie emozioni, offrendo un spazio sicuro per esplorare e integrare queste esperienze, per poi portarle nel mondo. Noi Terapeuti abbiamo l’opportunità di incontrare le persone nella loro intimità (..) e le persone possono imparare ad apprezzare l’effetto di un contatto adeguatamente sicuro, non virtualizzato, non sessualizzato. Possono inoltre comprendere i meccanismi psicologici che sono alla base delle relazioni e delle relazioni digitali. E i rischi.
In conclusione, la tecnologia offre nuove opportunità di connessione, ma è essenziale trovare un equilibrio tra il mondo digitale e quello reale. Nessuna immagine o auto-citazione potrà essere mai uguale ad un incontro. Che va incoraggiato, sempre e comunque. Il contatto fisico e la carezza rimangono bisogni primari dell’essere umano, come sottolinea Ashley Montagu (1971): «È attraverso la pelle che diventiamo esseri in grado di amare».
Tuttavia una relazione nata su un app, se portata avanti in modo autentico e consapevole, può durare una vita e recare soddisfazione e piacere. La consapevolezza di questi aspetti può guidare verso relazioni più autentiche e soddisfacenti, sia online che offline.
Come terapeuta considero essenziale comprendere le complesse interazioni tra mente e corpo nelle relazioni moderne, specialmente nel contesto delle app. La consapevolezza di queste dinamiche può aiutare a guidare gli interventi terapeutici, favorendo relazioni più autentiche e soddisfacenti.
Bibliografia
- American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.).
- Bouffard, S., Giglio, D., & Zheng, Z. (2022). Social media and romantic relationships: Excessive social media use leads to relationship conflicts, negative outcomes, and addiction via mediated pathways. Social Science Computer Review, 40(6), 1523–1541.
- Castro, Á., & Barrada, J. R. (2020). Dating Apps and Their Sociodemographic and Psychosocial Correlates: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(18), 6500. doi:10.3390/ijerph17186500.
- Damasio, A. (1994), trad. it.: L’errore di Cartesio. Milano: Adelphi, 1995.
- Eastwick, P.W., Finkel, E. J., Mochon, D., & Ariely, D. (2007). Selective versus unselective romantic desire: Not all reciprocity is created equal. Psychological Science, 18, 317–319.
- Eastwick, P.W., & Finkel, E.J. (2008). Do people know what they initially desire in a romantic partner? Journal of Personality and Social Psychology, 94, 245-264.
- Fardouly, J., Diedrichs, P. C., Vartanian, L. R., & Halliwell, E. (2015). Social comparisons on social media: The impact of Facebook on young women’s body image concerns and mood. Body Image, 13, 38-45.
- Fiore, A.T., & Donath, J.S. (2005). Homophily in online dating: When do you like someone like yourself? Short Paper, ACM Computer-Human Interaction 2005.
- Fiore, A.T., & Donath, J.S. (2004). Online personals: An overview. Short Paper, ACM Computer-Human Interaction 2004.
- Garofalo, R., Kuhns, L. M., Reisner, S. L., Mimiaga, M. J., & Parsons, J. T. (2020). Behavioral interventions to reduce HIV risk: What works for young men who have sex with men? AIDS and Behavior, 24(12), 3518-3530.
- Fiore, A T., Taylor, L S., Mendelsohn, G.A., & Hearst, M. (2008). Assessing attractiveness in online dating profiles. Short Paper, ACM Computer-Human Interaction 2008.
- Fiore, A.T., Taylor, L.S., Zhong, X., Mendelsohn, G.A., & Cheshire, C. (2010). Who’s right and who writes: People, profiles, contacts, and replies in online dating. In Proceedings of Hawai’i International Conference on System Sciences, 43.
- Fromm, E. (1976), Avere o essere? Milano: Mondadori.
- Finkel, E.J., & Eastwick, P.W. (2008). Speed-dating. Current Directions in Psychological Science, 17, 193-197.
- Gibbs, J.L., Ellison, N.B., & Heino, R.D. (2006). Self-presentation in online personals: The role of anticipated future interaction, self-disclosure, and perceived success in Internet dating. Communication Research, 33, 1-26.
- Green, S., & Singleton, R. (2013). Social media and interpersonal relationships: The role of online interactions in offline friendships. Journal of Social and Personal Relationships, 30(3), 303-319.
- Heinrichs, M., Baumgartner, T., Kirschbaum, C., & Ehlert, U. (2003), “Social support and oxytocin interact to suppress cortisol and subjective responses to psychosocial stress”, in Biological Psychiatry, 54(12), pp. 1389-1398.
- Hitsch, G.J., Hortaçsu, A., & Ariely, D. (in press). Matching and sorting in online dating. American Economic Review.
- Hitsch, G.J., Hortaçsu, A., & Ariely, D. (2009). What makes you click: An empirical analysis of online dating. Working Paper, retrieved Jan. 2010 from: Online Dating Analysis
- Jung, C. G. (1976). Il desiderio è l’elemento centrale della vita psichica. Torino: Boringhieri.
- Kang, H. K., & Wei, L. (2020). The role of online feedback in self-esteem regulation. Computers in Human Behavior, 105, 106175.
- Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011), “Online social networking and addiction—a review of the psychological literature”, in International Journal of Environmental Research and Public Health, 8, pp. 3528-3552.
- Lee, L., Loewenstein, G., Ariely, D., Hong, J., & Young, J. (2008). If I’m not hot, are you hot or not? Physical-attractiveness evaluations and dating preferences as a function of one’s own attractiveness. Psychological Science, 19, 669-677.
- Lin, J., & Lundquist, J. (2020). Online Dating in Asia: A Systematic Literature Review. ResearchGate.
- Lyons-Ruth, K. (2000), “I sense that you sense that I sense”, in Infant Mental Health Journal, 21, pp. 85-99.
- Mishna, F., Bogo, M., Root, J., Sawyer, J. L., & Khoury-Kassabri, M. (2012), “It just crept in”: The digital age and implications for social work practice”, in Clinical Social Work Journal, 40, pp. 277-286.
- Montagu, A. (1971). Il linguaggio della pelle. Milano: Rizzoli.
- Norton, M., Frost, J., & Ariely, D. (2007). Less is more: The lure of ambiguity, or why familiarity breeds contempt. Journal of Personality and Social Psychology, 92, 97-105.
- Primack, B. A., Shensa, A., Sidani, J. E., Whaite, E. O., Lin, L. Y., Rosen, D., … & Miller, E. (2017), “Social media use and perceived social isolation among young adults in the US”, in American Journal of Preventive Medicine, 53(1), pp. 1-8.
- Ruthledge, P. (2022). “The psychological effects of online dating”, in Journal of Social and Personal Relationships, 39, pp. 210-225.
- Schwartz, B. (2004). The Paradox of Choice: Why More Is Less. New York: Ecco.
- Sears-Roberts Alterovitz, S., & Mendelsohn, G.A. (2009). Partner preferences across the life span: Online dating by older adults, Psychology and Aging, 24, 513-517.
- Smith, A., & Anderson, M. (2020). The impact of rejection in online dating: A psychological perspective. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 23(6), 421-427. https://doi.org/10.1089/cyber.2019.0731
- Smith, A., & Duggan, M. (2020). Dating Apps and Their Sociodemographic and Psychosocial Correlates: A Systematic Review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(20), 7362.
- Smith, J., & Johnson, A. (2020). Dating Apps: A Literature Review. Academia.edu. Retrieved from edu.
- Spaccarotella, M. (2019), Il Piacere Digitale. Roma: Carocci.
- Sprecher, S. (2011), “The influence of social networks on romantic relationships: A review”, in Journal of Social and Personal Relationships, 28(3), pp. 407-426.
- Tang, M.J., & Chan, E.T. (2021). “The impact of online social networking (social media) on interpersonal communication and relationships.” Journal of Social and Personal Relationships, 30(3), 303-319. doi:10.1177/0265407512470508.
- Toma, C., Hancock, J., & Ellison, N. (2008). Separating fact from fiction: An examination of deceptive self-presentation in online dating profiles. Personality and Social Psychology Bulletin, 34, 1023-1036.
- Waheed, M. (2020). Online Dating in Asia: A Systematic Literature Review. ResearchGate. Retrieved from ResearchGate.
(*) Psicologa, Psicoterapeuta