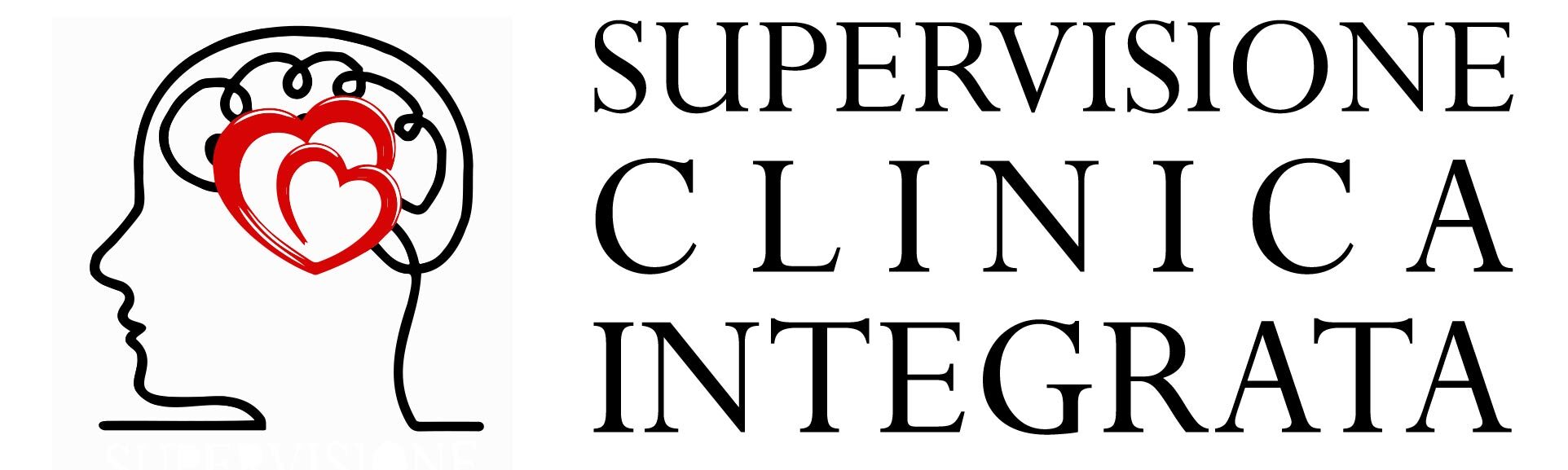Dal mito di Narciso ad Instagram: l’evoluzione del narcisismo
(*) Rosa Elisa Miceli
“Specchiò il suo volto su quella levigata e pura superficie e subito l’amore per quell’immagine riflessa lo ammaliò fuori da ogni ragione”.
(Metamorfosi di Ovidio, libro III)
Abstract
Narciso, mito greco di grande narrazione ed anche di maggiore divulgazione ha sempre affascinato, per la sua storia e per le tematiche che ha evocato, dando definizioni che oggi si usano come se dovessimo sfuggire da un nemico relazionale, che ci intrappola in dinamiche affettive e di dipendenza che non ci permettono autonomia ed individualità. Ma chi è Narciso oggi? Come si è evoluto il mito e quali sono le modalità rappresentative di sé che cerca di esprimere? Questo articolo prova ad esplorare attraverso una visone integrata dell’evoluzione del mito mediante l’utilizzo di Instagram, provando a fare una riflessione che includa pensiero e corpo nella visibilità di sé.
1. Il mito di Narciso
La storia del bel Narciso trae la sua origine da Ovidio che narra la sua storia nelle metamorfosi. Nel mito di Narciso, un giovane vede la propria immagine riflessa in uno specchio d’acqua e se ne innamora, ma questa narrazione un po’ riduttiva non riflette ciò che intendeva Ovidio, secondo il quale Narciso pensa di vedere un altro uomo riflesso e non se stesso, quindi non è l’amore di sé che porta alla distruzione ma nel trovare un partner perfetto, con il quale può esistere un amore ideale. In realtà vari autori hanno osservato quanto la storia di Narciso sia una riflessione sulla imperfezione della capacità di conoscere se stessi, quando troviamo noi stessi dovunque possiamo essere vittimi di un’illusione, il mito racconta semplicemente di un malinteso rispetto all’identità dell’altro, che poi è l’illusione dell’innamoramento (Dombek, 2016). Il narcisismo indica una modalità che pensa di guardare qualcun altro ma in realtà guarda se stesso, il proprio viso. Il mito, dunque, parla più di un mancato riconoscimento che dell’amore di sé. La storia di Ovidio narra di qualcuno che guarda un altro e vede una versione idealizzata di sé, e poi s’innamora di un riflesso invece che di una persona. Ecco come Narciso, diventa il simbolo sia dell’amore che del riconoscimento perché non è forse riconoscendo noi stessi che riusciamo ad amare l’altro?
2. Il narcisismo in psicoanalisi
Secondo Kohut (1971), dare un’esposizione completa delle difficoltà e dei problemi legati al narcisismo rispetto alle conoscenze ed alle capacità di ogni singolo autore risulterebbe inadeguato. Più di vent’anni dopo, Gabbard (1994), riflette su quanto le persone con uno disturbo narcisistico possano richiedere più di una prospettiva teorica ai fini esplicativi. Attualmente, parlare di narcisismo vuol dire confrontarsi con cent’anni di storia del pensiero psicoanalitico ed essere consapevoli del passaggio da una concezione monopersonale della psiche e dell’incontro clinico ad una concezione bipersonale e intersoggettiva, in cui l’altro è sempre psichicamente presente, svolgendo un ruolo di co-costruttore del mondo interno del soggetto e di co-regolatore del suo funzionamento (Kernberg, 2002).Un tema determinante nel narcisismo è il confine tra i suoi aspetti “normali” e patologici. Il narcisismo sano, se con questo termine intendiamo la capacità di riconoscere le proprie qualità positive e di regolare la propria autostima, potrebbe essere collocato lungo una posizione intermedia, verso un continuum che presenta due estremi patologici (un’immagine negativa di sé, con sentimenti d’inferiorità e di impotenza/un’immagine positiva di sé con sentimenti di superiorità ed onnipotenza. Tuttavia, il confine tra normalità e patologia del narcisismo è comunque problematico ed è influenzato da fattori sociali ed evolutivi, così come le diverse fasi del ciclo di vita rappresentano un riferimento fondamentale nella valutazione del narcisismo tra sano e patologico. Il termine narcisismo viene usato per la prima volta da Havelock Ellis (1898) in uno studio sull’autoerotismo, nel 1899 anche Paul Nacke lo utilizza per definire un individuo che tratta il proprio corpo come si tratta quello di un oggetto sessuale, ma è Isidor Sadger che, nel 1908, lo introduce nella terminologia psicoanalitica avanzando l’ipotesi che il narcisismo avrebbe potuto vendicare una sua collocazione nel normale sviluppo sessuale dell’individuo. La complessità del costrutto sul narcisismo è presente nel pensiero di Freud in cui dopo varie revisioni arriva nel 1914 ad utilizzare la metafora degli pseudopodi dell’ameba per descrivere l’alternanza tra investimento libidico dell’Io ed investimento libidico degli oggetti, postulando un investimento libidico originario dell’Io (narcisismo primario), in cui una parte è ceduta insieme agli oggetti, ma persiste è ha con gli investimenti d’oggetto, la stessa relazione che il corpo di un organismo ameboidale ha con gli pseudopodi che emette. Successivamente Freud, connetterà il termine narcisismo a una fase ancora più precoce dello sviluppo dell’apparato psichico, caratterizzata dall’investimento di rappresentazioni dell’Io non ancora differenziate da quelle degli oggetti (Freud, 1975). A differenza di Freud, invece, Melanie Klein (1952) ritiene che non esista una fase di narcisismo primario che precede le relazioni oggettuali e mette in luce il ruolo dell’invidia nei disturbi narcisistici, connotando questo sentimento come una manifestazione psicologica degli impulsi umani più distruttivi, che impediscono di stabilirsi di un rapporto valido con gli oggetti buoni, minano il senso di gratitudine e rendono incerti la distinzione tra buono e cattivo (Klein, 1969). Per Winnicott, invece, il focus si sposta al bambino come sistema chiuso alla diade madre bambino: le patologie che oggi chiamiamo narcisistiche sarebbero frutto di un fallimento materno nel sostenere e supportare lo sviluppo dello spazio potenziale generato dall’illusione di autosufficienza e dipendenza da una realtà riconosciuta come esterna, tali madri non avrebbero permesso di arrivare a fare l’esperienza dell’uso dell’oggetto, cioè di conoscere e rapportarsi all’oggetto nella sua alterità, ma solo entrando in rapporto con l’oggetto attraverso l’identificazione (Ronningtam, 2001). Secondo Kernberg, invece, il narcisismo patologico è ben diverso da quello normale e sarebbe determinato dall’investimento libidico di una struttura patologica, il Sé grandioso, che si sviluppa per proteggersi dalle angosce persecutorie e depressive e da un’invidia particolarmente intensa, si forma per mezzo delle proiezioni degli aspetti negativi di sé e del proprio mondo interno sugli oggetti esterni (Kernberg, 2002). La fenomenologia del narcisismo è il tentativo di compensare illusoriamente deficit dovute a carenze dell’ambiente oppure la conseguenza di dinamiche intrapsichiche connotate da un’aggressività intensa? Possiamo osservare come il narcisismo sano rappresenti il prodotto della capacità di vivere in equilibrio tra sogni ed illusioni dell’uomo apollineo e la dimensione magmatica, dionisiaca della realtà.
3. Il corpo di Narciso
La personalità narcisistica viene definita da Kernberg come un insieme di grande ambizione, grandiose fantasie, stati emotivi d’inferiorità, dipendenza eccessiva, uniti ad uno stato d’incertezza cronica, non soddisfazione di sé, atteggiamenti crudeli e speculazione degli altri (Kernberg, 2002).Tale definizione basata su una descrizione dettagliata dà la possibilità di individuare le persone narcisiste, anche se per comprenderli in profondità è indispensabile andare oltre la superfice che determina quella caratteristica. Abbiamo visto come nella visione psicoanalitica il disturbo ha genesi nella prima infanzia come una conseguenza tra l’unione tra un Sé ideale, l’oggetto ideale ed immagini reali del sé. I soggetti narcisisti, sono totalmente presi dall’immagine di sé e non hanno la capacità di differenziare tra ciò che credono di essere e ciò che realmente sono. Secondo il modello psicoanalitico, però tutto questo si verifica nella psiche caratterizzando la personalità, non prendendo in considerazione ciò che si verifica da un punto di vista corporeo, che determina sia il pensiero che il comportamento. Diventa importante osservare in un’ottica biodinamica il sé corporeo, oltre a quello psichico, che viene percepito dalla mente ed è correlato dalla sensazione e dalla percezione dell’esistenza del corpo, che di conseguenza è una struttura della mente e visualizza delle immagini e se l’elemento corporeo è parte di sé, l’immagine che abbiamo del sé reale dovrebbe essere un’immagine corporea, abbandonando l’immagine di sé stessi soltanto se si esclude la realtà di un sé incorporato. Le persone narcisiste considerano il corpo come uno strumento della mente, dipendete dalla propria volontà e le attività del proprio corpo sono determinate non sulle emozioni ma sulle immagini. In sintesi, per Lowen, la personalità narcisistica è caratterizzata da un individuo non spinto da uno stato emotivo. In tale ottica, il narcisista, sembrerebbe essere privo di un Super Io e non avendo e conoscendo dentro di sé il senso del limite, si muove per impulsi con la libertà di esperire un proprio modo operandi lontano dalle regole sociali, che vengono affettivamente minimizzate dominato da un grande senso di vuoto che lo conduce spesso a stati depressivi. Secondo Lowen,, ogni aspetto del narcisismo è influenzato dalla difficile relazione genitore-figlio, da una mancanza nello sviluppo e riteneva che bisognava analizzare ciò che il genitore aveva fatto al bambino, invece che valutare quello che si erano dimenticati di fare, anche se molto spesso i bambini sono esposti ad entrambi i traumi fatti di mancanze e dimenticanze. Nel momento in cui il bambino non si sente riconosciuto e rispettato nella sua individualità non avverte da parte dei genitori un supporto adeguato, ma non riuscendo ad accettare questa mancanza, attraverso la seduzione tenta di avere una corrispondenza genitoriale con l’immagine che si sono fatti. Maggiore è la mancanza di più sarà la distorsione, che sarà la causa del disturbo. Per il narcisista non vi è alcun interesse per gli altri, ma vi è anche mancanza per i propri bisogni, attuando spesso comportamenti autodistruttivi, vi è un investimento dell’Immagine costruita, amandola, poiché ha un Sé debole e non capace di metabolizzare le proprie azioni. Tante persone, in maniera naturale desiderano migliorare la propria immagine, cercando di fare una buona impressione a se stessi agli altri, il narcisista però non ha un interesse sano per la propria immagine e per la propria apparenza, ma vive esclusivamente per la propria immagine, che non trova un riscontro e non essendo supportata da ciò che il corpo vive, ha un continuo bisogno di trovare nutrimento dal riconoscimento dell’altro, motivo per il quale la personalità narcisistica per funzionare è dipendente dall’ambiente, e ciò lo porta a distaccarsi sempre di più dal suo vero sé, che nel corpo trova emozioni e sentimenti. Dunque, dato che l’immagine si struttura come elemento fondamentale della personalità, l’individuo cercherà di eliminare qualsiasi tipo di sentimento che lo rifiuterà, trasformando il vero sé che si trova al di sotto rabbioso e ribelle, negato e nascosto. Il narcisista non ha empatia e nega ciò che prova realmente, a tale proposito Lowen fa un paragone con la guerra, dove si insegna a vedere i propri nemici come persone non reali, in modo da risultare facile uccidere, in questo contesto non c’è alcun spazio per i sentimenti, bisogna eseguire gli ordini, non discutere e combattere, poiché in questo momento prendere contatto con il dolore e le proprie paure non li renderebbe efficaci. Per Lowen vi sono nei narcisisti dei sentimenti che sono potenzialmente presenti, che si vedono ogni tanto in una dimensione distorta ed prendono due sembianze: irrazionale rabbia e un sentimentalismo lacrimoso al posto dell’amore, osservando che se da una parte L’io riesce a gestire i sentimenti cercando di diminuire l’intensità, dall’altra ciò che proviamo sono delle risposte del corpo, motivo per il quale non si può negare ciò che temiamo senza negare la collera (Lowen, 2003)
4. Lo specchio di Instagram
Nel 1979 uscì un libro che ebbe un grande successo:” la cultura del narcisismo di Cristopher Lash, dove si affermava che i mezzi di comunicazione di massa elettronici prosperano su immagini superficiali con il risultato che la vita di molti manca di sostanza e profondità (Lash, 1981). La pubblicità, i film e la televisione mostrano uomini e donne prestanti e bellissimi, denti bianchi, un corpo perfetto, capelli fluenti ed un abbigliamento impeccabile, dove il messaggio che arriva è che non è tanto come ti senti ma come appari. Twenge e Campbell hanno effettuato una serie di ricerche sui narcisisti e su una vita vissuta sul web, sul cambiamento degli stili parentali e sull’influenza dell’onnipresente telefono portatile. Da queste ricerche è emerso il concetto di narcisismo generazionale, secondo il quale coloro che sono nati dopo 1982 tendono a condividere un insieme di valori e convinzioni, tra cui l’idea che sia tutto dovuto. La generazione dei millennial è cresciuta con uno strumento quantitativo per l’accrescimento dell’autostima: il numero di like sui social media, che fornisce gratificazione istantanea per l’intero giorno e fino alle ore piccole di notte, anche se chiunque abbia in tasca un cellulare viene influenzato dalla possibilità di soddisfare immediatamente i propri bisogni, da prodotti consegnati a casa in meno di un’ora o di messaggi e post che richiedono una risposta istantanea. L’ammirazione per se stessi è un tratto fondamentale di questo narcisismo culturale, il fenomeno dei selfie è onnipresente tra i giovani che sono sicuramente la generazione più fotografate e video registrata di tutti i tempi. Oggi i genitori vivono gli eventi dei figli come una guerra con gli altri genitori per conquistare la postazione migliore per avere la foto o il video più bello dell’esibizione del figlio. Da un’altra prospettiva si potrebbe sostenere che lo smartphone si stia essenzialmente sostituendo alla funzione parentale, in quanto fornisce un mezzo attraverso cui le persone possono rappresentare se stesse. I social network rappresentano lo strumento più usato per ferire qualcuno nel gruppo dei pari, ad esempio, commentando il post di tutti tranne quello di una persona in particolare, si possono infliggere ferite narcisistiche alla vittima che viene trascurata. Il narcisismo sta prendendo il sopravvento nei social media, soprattutto su Instagram dove poter sbandierare un gran numero di follower o di visualizzazioni delle proprie storie conta più dello stipendio. Twenge e Cambell riconoscono che molti dei narcisisti descritti nel gruppo dei millennial non presentano un vero e proprio disturbo di personalità, ma sono individui con alti livelli di narcisismo, che pensano di essere migliori degli altri anche se non lo sono, non hanno relazioni affettuose di cura reciproca e in molti casi si sentono superiori agli altri (Twenge, 2014). E’ importante riflettere sui cambiamenti che si sono verificati nelle nostre vite da quando Internet ha assunto il ruolo di oggetto sé ma anche di oggetto relazionale. Il narcisismo riguarda essenzialmente le nostre difficoltà nel vedere noi stessi e gli altri e di relazionarsi gli uni con gli altri. Internet, ha effetti importanti su questa dimensione dell’esistenza: comunicare all’altro cosa si sta facendo e come ci si diverte a farlo con un post sembra molto più importante che godersi il momento che si sta vivendo. Vi è qualcosa d’intrinsecamente narcisistico su Instagram in cui molti spettatori assistono ai nostri successi e possiamo modificare quello che vede il pubblico, filtrando gli elementi positivi della propria immagine. La comunicazione sui social ha una qualità superficiale che si può adattare bene all’organizzazione narcisistica dei suoi partecipanti ma emerge una riflessione:” Sono i social a rendere narcisista chi li usa o chi l’è già per sua natura tende ad essere attratto da questa forma di comunicazione?”. Varie ricerche hanno dimostrato come il tempo passato su Instagram sia predittivo di un alto livello di narcisismo e di come alcune persone utilizzano lo specchio del social per gridare al mondo di essere visto, notato. Il proprio Sé viene modulato sulla base di come si viene visti dagli altri on-line, il livello empatico è diminuito considerato il tempo in cui si è non connessi e la riflessione da fare e sul perché non siamo con l’altro quando questo è accanto a noi?
5. Conclusione
Nell’antichità, il bel Narciso scoprendo la propria immagine si innamorò di sé fino ad arrivare alla morte, oggi guardando una nostra foto ed il successo che possa raggiungere ci fa sentire visti dall’altro e quindi capaci di esistere, attraverso un corpo ch’è stato preparato per l’esibizione pubblica riusciamo a pensarci come individui. Notiamo come lo specchio di sé sia diventato la nostra immagine pensata e vista dall’altro, perdendo completamente il nostro Sé corporeo e personale in quanto sempre “filtrati”. Forse la riflessione trasformativa da fare e quanto la visibilità propria posso dare spazio ad una dimensione più autentica di sé, dove corpo e pensiero possano diventare uno strumento di consapevolezza e rappresentazione, che possa aiutare il Narciso di oggi a rispecchiarsi e nella riflessione di sé stesso ci possa essere una costante condivisione del proprio amore, pensato come una foto in cui il primo like è quello proprio, il riflesso narcisistico primario si collocava nel vuoto adesso ci riflettiamo attraverso l’altro per trovare noi stessi.
Bibliografia
- Dombek, K. (2016). The Selfishness of Others: An Essay on the Fear of Narcissim. Farar. New York: Straus, and Giroux.
- Freud, S. (1975). Introduzione al Narcisismo. Torino: Boringhieri
- Kernberg, O. (2002). Narcisismo, aggressività e autodistruttività nella relazione terapeutica. Milano: Cortina.
- Klein, M. (1969). Invidia e gratitudine. Firenze: Martinelli
- Lash, C. (1981). La cultura del narcisismo. L’individuo in fuga dal sociale in un’età di disillusione collettive. Milano: Bompiani
- Lowen, A. (2003). Il narcisismo L’indennità rinnegata. Torino: Feltrinelli
- Ronningtam, E. (2001). I disturbi del narcisismo. Milano: Raffaello Cortina
- Twenge, J. C. (2014). L’epidemia del narcisismo. Milano: Excelsior 1881
(*) Psicologa, Psicoterapeuta