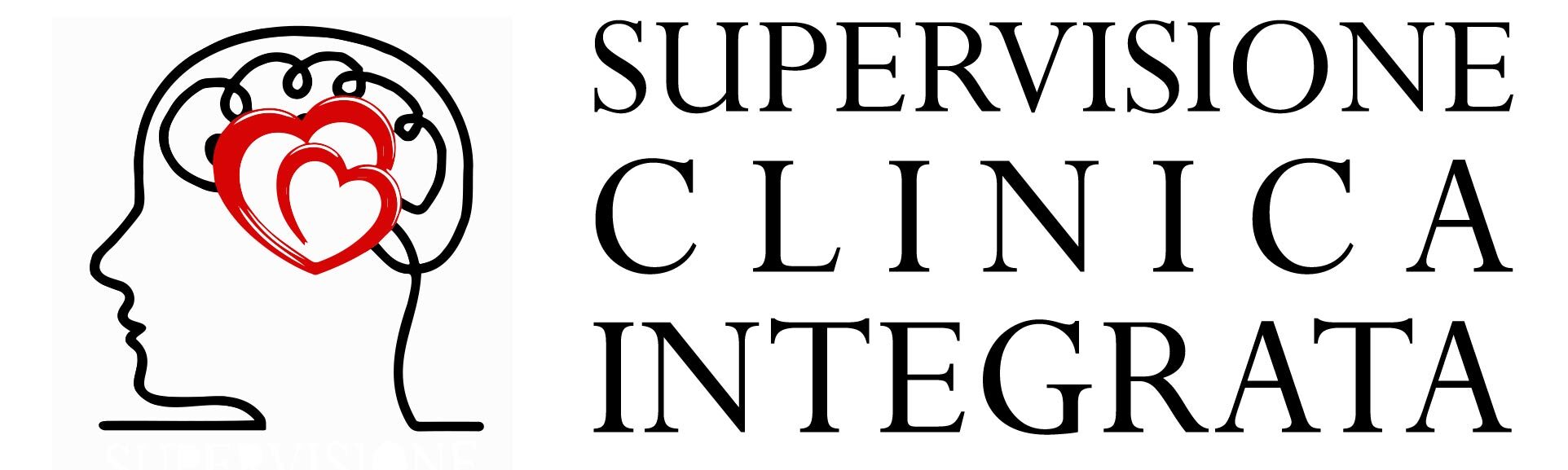Fiore blu: radicare il sé nel corpo ferito
Abstract
Il disturbo di conversione rappresenta una delle manifestazioni più complesse e affascinanti dei disturbi somatici di origine psichica, caratterizzato dalla presenza di sintomi fisici che non trovano una spiegazione organica evidente, ma sono strettamente collegati a processi inconsci, conflitti emotivi e traumi. Introdotto da Freud e tradizionalmente studiato all’interno della psicoanalisi e della psicologia clinica, esso evidenzia come le tensioni psichiche possano essere “convertite” in sintomi corporei, confermando un’interazione profonda tra mente e corpo.
La psicologia dinamica, con il suo focus sui movimenti inconsci e sui conflitti psichici, offre un quadro teorico utile per comprendere le origini e le manifestazioni del disturbo di conversione. In parallelo, l’analisi bioenergetica, considera il corpo come un deposito di emozioni represse e tensioni muscolari che riflettono conflitti psichici irrisolti. Integrando le due prospettive, il corpo diventa un veicolo di comunicazione e di elaborazione dei conflitti interiori e consente un approccio bottom-up per affrontare i sintomi.
(*) Grazia A. Vulpis
A Fiore Blu, una splendida ragazza dallo sguardo dolce e generoso, ancora impegnata a curare le proprie ferite, ma con l’ostinato desiderio di sbocciare ogni primavera, sempre più rigogliosa.
Questo articolo è stato ispirato dalla narrazione della storia di una bambina, Fiore Blu, che nei suoi primi anni di vita ha subito episodi traumatici di separazione, deprivazione affettiva e maltrattamenti. Il racconto evidenzia come il suo bisogno di difendersi da minacce e paure, da emozioni devastanti e impossibili da sostenere, venga espresso dalla fragilità del suo corpo, che diventa contemporaneamente alleato e nemico.
Nel tempo Fiore Blu sviluppa un disturbo di conversione, che qui viene letto in chiave biodinamica, un approccio che integra la psicologia dinamica e l’analisi bioenergetica, evidenziando come gli elementi fondanti di queste teorie, insieme, possano contribuire a una comprensione più profonda del paziente e a strutturare interventi terapeutici completi, che considerano la persona nella sua unità psicofisica.
-
Il disturbo di conversione
Il disturbo di conversione è oggi definito nel DSM-5-TR disturbo da sintomi neurologici funzionali; è caratterizzato dalla presenza di sintomi neurologici causati da fattori psicologici e non da lesioni o anomalie del sistema nervoso.
I sintomi spesso si sviluppano bruscamente e l’esordio a volte può seguire un evento stressante. Consistono solitamente in deficit evidenti a carico della funzione motoria volontaria e sensoriale; talvolta comprendono anche convulsioni, alterazione dello stato di coscienza e anomalie posturali degli arti. Per esempio, i pazienti potrebbero presentare disturbi della coordinazione o dell’equilibrio, astenia, paralisi di un braccio o di una gamba, perdita di sensibilità in una parte del corpo, perdita di responsività, cecità, visione doppia, sordità, afonia, difficoltà di deglutizione, sensazione di nodo in gola o ritenzione urinaria (Dimsdale, 2022).
Il disturbo di conversione, così come è stato introdotto da Freud, è una manifestazione dell’inconscio, rappresenta un meccanismo di difesa che protegge l’individuo dall’esperienza dolorosa o traumatica, spostando l’attenzione sul sintomo fisico. L’emozione o il ricordo traumatico non possono essere mentalizzati o verbalizzati, quindi si “convertono” in manifestazioni fisiche.
Essendo visti come espressione di conflitti inconsci, i sintomi si sostituiscono alle parole, che non vengono pronunciate in quanto il conflitto non raggiunge il livello di coscienza del soggetto. Essi non sono un’anomalia da rettificare, ma rappresentano il livello di sofferenza della persona e il modo in cui l’inconscio si rivela ad essa.
Nella clinica della conversione isterica il sintomo è linguisticamente articolato e interpretabile come metafora del conflitto psichico, differisce dal sintomo psicosomatico, che non è simbolizzabile, il corpo prende il posto della parola. Questo rende il sintomo difficile da trattare esclusivamente con gli strumenti classici della parola e dell’interpretazione.
Nella conversione isterica i sintomi sono di natura neurologica e non si realizza una lesione dell’organo, a differenza di quanto accade nella manifestazione psicosomatica.
I fenomeni psicosomatici si riferiscono a condizioni in cui fattori psicologici influenzano direttamente lo stato fisico di una persona, portando a sintomi corporei concreti senza una causa organica evidente. Ad esempio, stress o ansia possono manifestarsi con dolori, disturbi gastrointestinali o altri sintomi fisici. La clinica dei fenomeni psicosomatici si concentra quindi sulla comprensione di come emozioni, pensieri e stati psicologici vari possano contribuire alla comparsa di sintomi fisici, che rappresentano un modo in cui il corpo esprime i propri conflitti interiori, la propria condizione emotiva.
Nella clinica psicosomatica, il corpo è reale, non è solo rappresentato o simbolizzato, quindi la lesione non è interpretabile come una formazione dell’inconscio, ma si presenta come un evento reale, di cui bisogna individuare il senso.
Come osserva Lacan, il corpo appare come luogo di iscrizione di un trauma non simbolizzato, spesso legato a esperienze precoci di rottura del legame con l’Altro (genitore, “caregiver”). Il sintomo psicosomatico non è una rappresentazione, ma una traccia reale, una “ferita” che non ha trovato parola.
La clinica psicosomatica presuppone il cambiamento anche nel trattamento del paziente e uno spostamento del focus, che passa dall’interpretazione del contenuto alla costruzione di un contenitore psichico (Recalcati, 2023).
In un’ottica biodinamica, si può considerare il disturbo di conversione come un conflitto psichico inconscio, che si manifesta attraverso blocchi energetici e tensioni muscolari croniche. Il sintomo non è solo un simbolo psichico, ma la manifestazione di una vera e propria interruzione del flusso energetico nel corpo, l’emblema di una disfunzione dell’integrazione mente-corpo che può essere ripristinata con un intervento bottom-up, il quale, partendo dall’esperienza corporea, consente di riconoscere e verbalizzare i vissuti repressi e intervenire parallelamente sul piano emotivo e relazionale, affinché il sintomo non sia più necessario come valvola di sfogo.
-
Lo strappo delle radici
Il trauma non è solo un evento accaduto una volta nel passato, ma si riferisce all’impronta lasciata da quell’esperienza sulla mente, sul cervello, sul corpo. Questa impronta ha continue conseguenze sul modo in cui l’organismo umano gestisce la sopravvivenza nel presente. Perché avvenga un reale cambiamento, il corpo ha bisogno di apprendere che il pericolo è passato e di vivere nella realtà presente (Bessel van der Kolk, 2015).
Ma cosa accade quando il presente è così spietato da spingerti continuamente nel passato? Anche la realtà diventa insopportabile e l’unica soluzione sembra essere la dissociazione dal corpo e dalle emozioni, raggiungere un livello di rigidità tale che porta all’immobilizzazione, alla difesa estrema di sembrare morti.
È la soluzione che adotta Fiore Blu, alla quale, dopo ripetuti ricoveri e indagini cliniche, viene diagnosticato il disturbo di conversione.
-
Gli eventi
Fiore Blu è una bambina congolese che all’età di cinque anni viene adottata da una coppia di genitori italiani. Quando arriva in Italia, ha già sperimentato profondi e laceranti sentimenti di dolore e di perdita, legati alla morte prematura della mamma, alla separazione dalla nonna e all’allontanamento dai fratelli. Soprattutto ha subito lo strappo dalle sue radici, che ha lasciato una ferita sempre aperta nella sua anima e un incolmabile senso di vuoto interiore. Nell’orfanotrofio per bambini “dimenticati e abbandonati” ha acquisito sin da subito consapevolezza della sua condizione e si è sentita “invisibile, trascurata, sola”. È in quel luogo di abbandono che il suo corpo ha imparato a raccontare quello che non le era consentito esprimere con le parole: febbre anomala, difficoltà respiratorie, indebolimento muscolare che la costringevano a letto, fitte allo stomaco, dolori acuti e insistenti si impossessavano di lei per lunghi periodi dando voce alla sua sofferenza. In quel posto “nessuno sembrava vederla, era diventata talmente trasparente che lei stessa faceva fatica a pensarsi ancora viva” e l’unico sollievo lo provava raggomitolarsi in un angolo, lontana da tutto e tutti, rendendosi sempre più invisibile, pensando che “morire fosse la soluzione migliore per la sua sfortunata e inutile esistenza”.
La notizia dell’adozione riaccende in lei la speranza, riattiva le sue energie e la sensazione di poter essere accolta e amata da due genitori che l’hanno attesa e desiderata per tanto tempo. Lascia l’orfanotrofio solo dopo essere stata opportunamente avvertita di non rivelare ai nuovi genitori l’esistenza dei fratelli e i maltrattamenti subiti, con la minaccia che in caso contrario, questi l’avrebbero “buttata sotto un treno o riportata in Africa”. Un logorante segreto da tenere dentro, altro dolore e paura che si annidano in ogni angolo del suo corpo e della mente!
Arrivata in Italia, Fiore Blu comincia a fare i conti con “una nuova realtà che la destabilizza: tutte le persone sono bianche, tranne lei!” Questo la espone a sensazioni di estraneità e nello stesso tempo la mette a contatto con l’inganno contenuto nelle parole della suora: “anche tu diventerai bianca”.
Mentre la bambina, aiutata dai genitori e dalla psicoterapeuta, cerca le risorse per fronteggiare questi nuovi vissuti, incomincia il suo percorso scolastico. Purtroppo anche la scuola diventa un luogo in cui è sottoposta a umiliazioni e rifiuti, inflitti da insegnanti e compagni, a causa della sua provenienza e del colore della sua pelle; un posto in cui ancora una volta le sue origini vengono attaccate! I ripetuti commenti denigranti, l’isolamento nel quale viene nuovamente a trovarsi, riattivano in lei le esperienze già vissute: “ogni contesto sembrava allontanarla e schifarla, questa sensazione l’annullò e l’annientò completamente, tanto da sentirsi invisibile agli occhi del mondo”.
Così le esperienze emotive e relazionali vissute da Fiore Blu si incarnano nel corpo e cominciano a dare voce al disagio e alla sofferenza accumulati nel tempo. L’incapacità e l’impossibilità della bambina di reagire e ribellarsi, il senso di vuoto e inadeguatezza che la pervadono, le provocano ogni volta uno stato di stordimento e torpore, sintomi vasovagali, irrigidimento degli arti, la fanno sentire distaccata dalla realtà e lontana dal corpo. Fiore Blu vive in un continuo stato di allarme, si sente minacciata dagli sguardi che si posano su di lei e questo le fa perdere il radicamento alla realtà: le gambe vacillano e non riescono a sostenerla, sente di non poter gestire il proprio corpo, sente di non esistere. Nel tempo gli episodi diventano sempre più frequenti e intensi, fino a indurla spesso in uno stato catatonico, una rigidità del corpo che la lascia cadere a terra con gli occhi sbarrati e lo sguardo perso nel vuoto… (Frondizi, 2024).
-
La prospettiva biodinamica
Fiore Blu è soggetta a una profonda disconnessione dal corpo che, come sostiene Van der Kolk (2015) è una reazione tipica di persone traumatizzate e gravemente trascurate di fronte a situazioni percepite come minacciose. “Non essere visti, non essere riconosciuti, non avere nessuno a cui rivolgersi per sentirsi al sicuro sono sconvolgenti a qualsiasi età, ma risultano particolarmente distruttivi per bambini piccoli che stanno ancora cercando di trovare il loro posto nel mondo.”
Lo stesso autore documenta come la dissociazione provocata da un evento traumatico consente di non sentire la paura e si traduce nella disconnessione di varie aree cerebrali, come strategia di sopravvivenza che impedisce alla persona di pensare, sentire, ricordare e dare senso a ciò che succede. In tali circostanze, la sola terapia verbale risulta inefficace, è necessario un approccio terapeutico bottom-up che abbia l’obiettivo di cambiare la fisiologia del paziente e il rapporto con le sue sensazioni corporee.
La dimensione corporea implicata dal disturbo di conversione, pone l’accento sull’opportunità di un intervento integrato che associ nel trattamento gli aspetti cognitivi e psicodinamici a quelli corporei, considerando il corpo non solo come canale di espressione di conflitti e disagi psichici, ma uno strumento di cura, una via preferenziale di accesso al campo emotivo della persona.
Alexander Lowen (1983), descrivendo il suo modello dell’analisi bioenergetica, ben illustra come in seguito a emozioni non espresse, conflitti irrisolti ed esperienze traumatiche, si strutturano tensioni muscolari croniche, le quali si traducono in blocchi energetici che limitano il regolare fluire dell’energia e causano rigidità e limitazione di movimento, sottraendo vitalità al corpo.
Le tensioni muscolari costituiscono un aspetto visibile del disagio psichico e un valico per il terapeuta che, insieme al paziente, lavora per ristabilire un flusso energetico armonioso e donare vitalità al corpo, muovendosi lungo un percorso bidirezionale dal pensare al sentire e viceversa.
Per promuovere una connessione autentica con le proprie emozioni, sciogliere le tensioni muscolari croniche e ripristinare il flusso energetico, Lowen (1977) pone l’accento su esperienze che coinvolgono prevalentemente il respiro, il movimento e il grounding. Quest’ultimo è inteso come la possibilità della persona di sentirsi presente nel proprio corpo, in contatto stabile con la realtà, le proprie origini e la propria esperienza emozionale. Essere radicati significa avere una presenza stabile nel qui e ora; sentire il proprio corpo come un punto di riferimento solido e affidabile, aiuta a sviluppare un senso di sicurezza, di identità e di equilibrio emotivo, riduce sensazioni di ansia o disorientamento.
Nei pazienti con disturbo di conversione, il grounding è compromesso e riflette la frattura tra psiche e soma, il soggetto non abita pienamente il corpo, quindi non riesce a regolare le emozioni, né a riconoscerle come proprie. Manca una connessione profonda e stabile con la realtà e il corpo, che non è vissuto come uno spazio sicuro o un mezzo per esprimersi, ma come un luogo di conflitto, di tensione, estraneo e minaccioso. Lo stesso sintomo fisico è spesso vissuto come qualcosa che “accade” al corpo, senza che il soggetto ne abbia padronanza (Avico, 2020).
Intervenire sul disturbo di conversione in prospettiva biodinamica consente al terapeuta di entrare in contatto con quello che la persona esprime al di là delle parole, di creare un collegamento tra passato e presente, accedere attraverso le sensazioni corporee alle dinamiche intrapsichiche di competenza psicodinamica. Permette di viaggiare lungo un continuum penso-sento, in cui la dimensione corporea favorisce il passaggio a quella cognitiva e permette all’intero organismo di tornare a vivere.
La teoria dell’appoggio oggettuale (Gilleron, 1994) sottolinea il bisogno dell’individuo di cercare nel mondo esterno oggetti (persone, situazioni) che possano fungere da supporto emotivo e strutturale, spiega come la persona utilizza le relazioni per mantenere l’equilibrio psichico, per sostenere la propria struttura di personalità e il senso di sé. In quest’ottica, le relazioni significative, inclusa quella con il terapeuta, diventano oggetti su cui appoggiarsi. L’appoggio oggettuale consentito dal terapeuta attraverso il corpo e la sua gestualità, presente e in sintonia emotiva con il paziente, aiuta questi a radicarsi. Inoltre, stabilendo forme di contatto oculare, fisico, etc. con il paziente, il terapeuta gli trasmette l’idea che lo sente e lo accetta come essere corporeo e si prende cura di lui (Lowen, 1983).
Conclusioni
Secondo il modello biodinamico, la trasformazione curativa è determinata proprio dal processo di sintonizzazione affettiva che si instaura all’interno del setting terapeutico, che permette un passaggio continuo dal pensare al sentire, dalla mente al corpo. Prestando attenzione al proprio sentire, il terapeuta raccoglie informazioni sul funzionamento e sullo stato emotivo del paziente e può restituirgli, rielaborati, aspetti intrapsichici di cui questi non è consapevole. Al contempo, il paziente, sperimentando un appoggio oggettuale positivo, vissuto attraverso la sensazione emotiva e fisica di potersi appoggiare, riconquista il senso di fiducia nella relazione con l’altro e con se stesso, può riconnettersi con il proprio Sé e con la realtà esterna.
Bibliografia
-
Frondizi, E. Fiore Blu. Sbocciare nell’ombra. Viterbo, Scatole Parlanti, 2024
-
Gilleron, E. Il primo colloquio in psicoterapia. Roma, Borla, 1994 (2007)
-
Lowen, A., Lowen, L. Espansione e integrazione del corpo in bioenergetica. Roma, Astrolabio, 1977 (1979)
-
Lowen, A. Bioenergetica. Milano, Feltrinelli, 1983 (1992)
-
Recalcati, M. Il mistero del corpo parlante. In Il corpo parla? Clinica psicoanalitica dei fenomeni psicosomatici, a cura di Natascia Ranieri – IRPA, Annali del dipartimento clinico “G. Lemoine” Milano e Ancina. Sesto San Giovanni (MI) Mimesis, 2023
-
Van der Kolk, B. Il corpo accusa il colpo. Milano, Raffaello Cortina Editore, 2015 (2025)
Sitografia
- Avico, R. Grounding: trauma e dissociazione. Il Foglio Psichiatrico. http://www.ilfogliopsichiatrico.it/wp-content/uploads/2020/07/Grunding-Estratti-Luglio-2020-1
-
Dimsdale, J. E. MD, University of California, San Diego – Reviewed By Mark Zimmerman, MD, South County Psychiatry – Revisionato/Rivisto lug 2024 in https://www.msdmanuals.com/ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition, Text Revision (DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing, Washington, DC, 2022
(*) Psicologa, psicoterapeuta