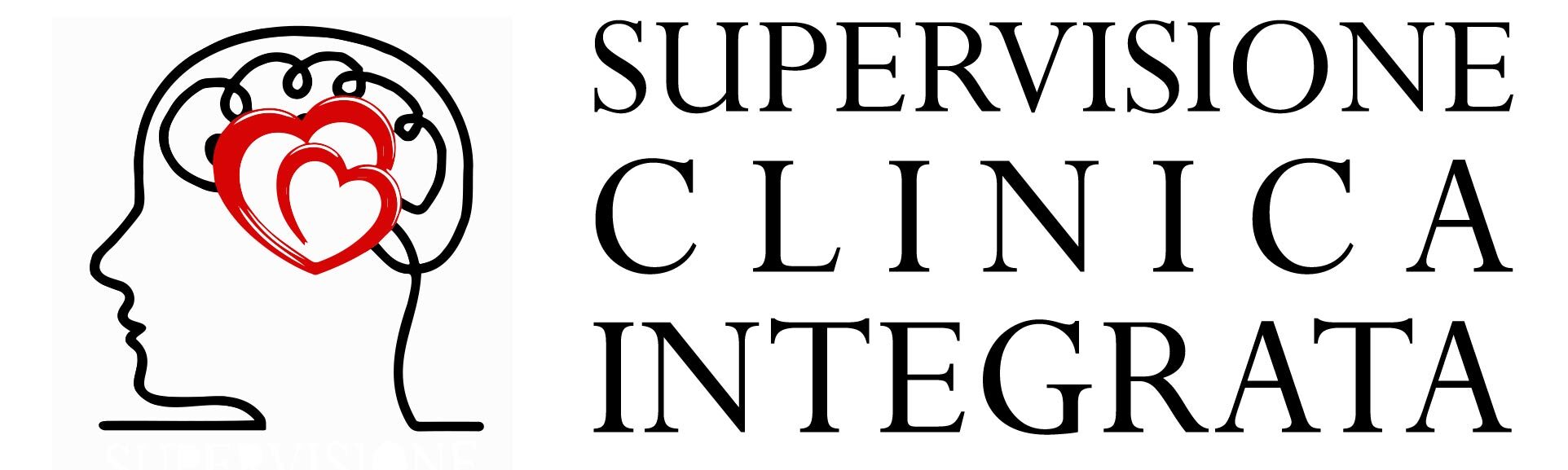Il Paradosso della Solitudine in Amore: Un’Analisi di “Dolce Nera” di Fabrizio De André
Il testo, utilizzando la canzone “Dolce Nera” di Fabrizio De André come spunto di riflessione, esamina come l’amore possa essere anche considerato una risposta alla solitudine. In particolare, da un punto di vista psicoanalitico sulla base del pensiero di Freud e Lacan, si mostra come il protagonista cerchi completezza nell’altro, ma si trovi di fronte all’impossibilità di colmare il proprio vuoto, determinando così l’insorgere di vissuti di frustrazione e angoscia. La tematica viene esaminata anche in una prospettiva psicocorporea sulla base del pensiero di A. Lowen, la quale permette di evidenziare come tale desiderio insoddisfatto e frustrato conduca all’instaurarsi nel corpo di inconsapevoli stati di tensione. In conclusione l’analisi di “Dolce Nera” permette di evidenziare come l’amore, invece di risolvere la solitudine del soggetto può amplificarne il senso di incompiutezza, intrappolandolo in un ciclo di desiderio e frustrazione.
(*) Daniela De Santis
Abstract
La canzone “Dolce Nera” di Fabrizio De André rappresenta una configurazione simbolica delle dinamiche intrapsichiche che governano il desiderio amoroso e l’esperienza della solitudine. Questo studio psicoanalitico indaga le tensioni sottese all’illusione di colmare il vuoto attraverso l’altro, esaminando il modo in cui la dialettica tra desiderio e mancanza si articola nel testo. Attraverso i concetti freudiani di Eros e Thanatos e la teoria lacaniana della mancanza strutturale, si esplora l’angoscia che accompagna il legame affettivo, con una particolare attenzione agli aspetti corporei, secondo l’approccio bioenergetico di Alexander Lowen.
Il tema dell’amore come risposta alla solitudine costituisce un punto focale della psicoanalisi, specialmente nei suoi risvolti legati alla ricerca del desiderio e alla struttura del soggetto. In “Dolce Nera”, De André rappresenta il soggetto in una ricerca disperata di completezza attraverso l’altro, solo per confrontarsi con il fallimento di tale impresa. Il desiderio di colmare il vuoto attraverso il legame amoroso incontra la propria impossibilità strutturale, generando frustrazione e accrescendo il sentimento di solitudine. L’analisi di questo testo si colloca nel contesto teorico freudiano e lacaniano, in cui la mancanza e la divisione interna del soggetto giocano un ruolo centrale nelle dinamiche affettive.
Il protagonista di “Dolce Nera” incarna il paradosso del soggetto freudiano, costantemente impegnato a cercare nell’altro una risposta alla propria mancanza, senza tuttavia mai trovarvi una soluzione stabile. L’Altro, infatti, non può fornire la pienezza desiderata, essendo anch’esso portatore di una mancanza strutturale. Freud sottolinea che “l’Io non è padrone in casa propria” (Freud, 1917), una nozione che riflette la complessità della psiche, divisa tra desiderio e angoscia, Eros e Thanatos. Il soggetto non è mai pienamente in controllo delle proprie pulsioni, il che rende l’esperienza amorosa precaria e potenzialmente angosciante.
Nella sua teoria delle pulsioni di vita (Eros) e di morte (Thanatos), Freud evidenzia il conflitto intrinseco che caratterizza l’esperienza amorosa. Eros spinge il soggetto verso l’altro, nella speranza di ricostruire una sorta di unità perduta, ma Thanatos riaffiora come timore della perdita del Sé nell’atto della fusione. In “Dolce Nera”, il protagonista vive questa tensione: desidera un legame che possa lenire il suo senso di frammentazione, ma al contempo teme che tale legame possa annientarlo.
L’acqua, presente come simbolo centrale nella canzone, incarna il desiderio di fusione con l’altro, un’immagine liquida e fluida che simboleggia l’aspirazione alla connessione. Tuttavia, la sua natura instabile riflette la pericolosità dell’amore, che può travolgere e distruggere l’identità del soggetto. In linea con la teoria freudiana, l’amore diviene una forma di illusione che, invece di offrire salvezza, conduce il soggetto a confrontarsi con la propria vulnerabilità e con la paura della dissoluzione dell’individualità (Freud, 1920).
Lacan descrive questa dinamica con il concetto di mancanza strutturale, affermando che “l’amore è un’esperienza di perdita” (Lacan, 1956). L’amore, piuttosto che colmare il vuoto del soggetto, ne amplifica la percezione, rivelandosi una fonte di angoscia.
Il soggetto lacaniano è segnato dalla “mancanza a essere“, una condizione ontologica che lo spinge verso l’Altro nella speranza di riempire questa assenza. Tuttavia, il desiderio è rivolto verso un oggetto fondamentalmente illusorio, che non può mai essere posseduto completamente. L’angoscia che deriva da questa impossibilità è centrale nel paradosso amoroso rappresentato in “Dolce Nera”: il soggetto desidera l’altro, ma tale desiderio si rivela irrealizzabile, poiché l’Altro stesso è mancante.
Se Freud e Lacan analizzano le dinamiche psichiche del desiderio, Lowen ci offre invece una prospettiva complementare che si focalizza sulla dimensione corporea dell’esperienza amorosa. Nella teoria bioenergetica di Lowen, il corpo diventa il teatro in cui si manifestano i conflitti psichici. Il protagonista della canzone, pur desiderando una connessione profonda, si trova bloccato da una dissonanza energetica: il desiderio non si realizza pienamente, e questa frustrazione si esprime a livello corporeo. La mancanza di fluidità nel flusso energetico riflette la difficoltà del soggetto di entrare in contatto con l’altro.
Lowen sostiene che il blocco energetico impedisce al soggetto di vivere appieno l’esperienza amorosa, trasformando il desiderio in una fonte di tensione fisica. In “Dolce Nera”, l’attrazione verso l’altro, tanto psichica quanto corporea, è segnata da un conflitto irrisolto, in cui il corpo diviene un veicolo per esprimere la frammentazione del Sé. Il corpo, come la psiche, è lacerato tra il desiderio di fusione e la paura della perdita di sé, manifestando così la complessità del paradosso amoroso.
Conclusione
L’analisi di “Dolce Nera” ci permette di comprendere come il paradosso dell’amore e della solitudine si radichi profondamente nella struttura psichica e corporea del soggetto. Il desiderio di colmare il proprio vuoto attraverso l’altro si rivela intrinsecamente fallimentare, poiché l’Altro stesso è mancante. Lacan e Freud, da un lato, mettono in luce la dimensione psichica di questo conflitto, evidenziando l’impossibilità di possedere l’oggetto del desiderio. Dall’altro lato, Lowen ci offre una chiave di lettura corporea, sottolineando come il fallimento del legame affettivo si manifesti anche a livello somatico.
In “Dolce Nera”, il protagonista vive l’amore come una fonte di angoscia, una “trappola” che lo costringe a confrontarsi con la propria mancanza strutturale. Il desiderio di fusione, anziché offrire salvezza, diviene una minaccia per l’integrità del Sé, ed il soggetto si ritrova intrappolato in un ciclo di desiderio e frustrazione. L’amore, lungi dall’essere una risposta alla solitudine, amplifica la consapevolezza della propria incompiutezza, lasciando il soggetto in balia di una mancanza che non può mai essere colmata.
Bibliografia
• De André, F. (1971). Dolce Nera. In Fabrizio De André: Le canzoni. Milano. Ricordi
• Freud, S. (1917). Introductory lectures on psycho-analysis. London. Hogarth Press
• Freud, S. (1920). Beyond the pleasure principle. London. Hogarth Press
• Lacan, J. (1956). Écrits: A selection. New York. Norton
• Lowen, A. (1980). Bioenergetics: Revolutionizing how you live, love, and perceive the world. New York. Penguin Books
(*) Psicologa, Psicoterapeuta