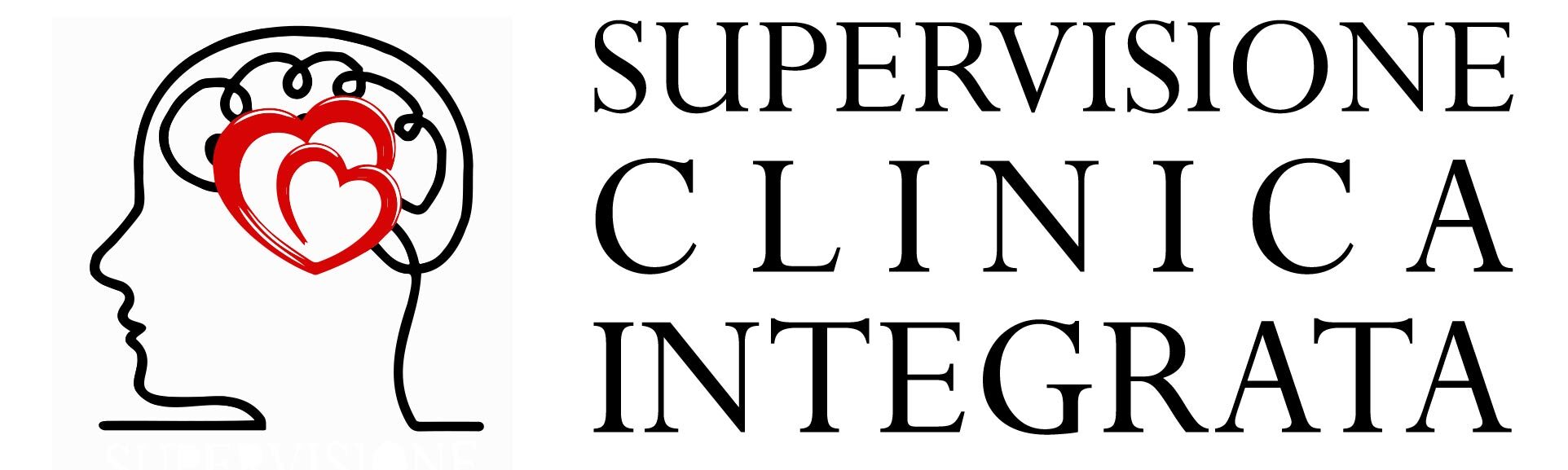Il sentimento del ridicolo e l’emozione della vergogna nelle esperienze corporee in analisi
L’articolo esamina un caso clinico utilizzando l’Analisi Bioenergetica come prospettiva teorica, concentrandosi sull’emozione della vergogna e su come questa possa manifestarsi nel paziente come una sensazione di sentirsi ridicolo durante le esperienze corporee in terapia. L’autore mette in evidenza come il processo terapeutico possa progredire attraverso l’elaborazione di questa emozione, ma anche come le intense emozioni coinvolte possano rendere complicata la gestione di questo compito all’interno della relazione terapeutica. Queste difficoltà portano a rivalutare il ruolo della vergogna nello sviluppo psicologico dell’individuo e sottolineano l’importanza dell’intersoggettività nella relazione terapeutica. In questa riflessione teorico-clinica, viene riconosciuta l’importanza del pensiero fenomenologico, secondo il quale anche le semplici espressioni non verbali possono avere un ruolo cruciale nella relazione tra terapeuta e paziente.
Giuseppe Carzedda (*)
Abstract
Nell’articolo, attraverso la discussione di un caso clinico trattato con il metodo dell’Analisi Bioenergetica, viene affrontato il tema dell’emozione della vergogna e del suo possibile emergere nel vissuto soggettivo del paziente attraverso il sentimento del percepirsi ridicolo nelle esperienze corporee proposte in psicoterapia.
L’autore evidenzia come il processo terapeutico possa svilupparsi a partire dall’elaborazione di questo sentimento, ma anche come le complesse e intense valenze affettive che ne risultano implicate possano rendere difficoltosa la gestione di tale compito all’interno della diade analitica.
Tali difficoltà, che spingono anche a riconsiderare il ruolo che all’emozione della vergogna deve essere in generale riconosciuto all’interno del processo di sviluppo psicologico dell’individuo, rendono ancora più evidente la rilevanza assunta dal tema dell’intersoggettività all’interno della relazione analitica: in tale prospettiva di riflessione teorico-clinica viene anche riconosciuta una particolare importanza a considerazioni derivate dal pensiero fenomenologico e in base alle quali anche i soli sguardi pensati possono assumere una centrale rilevanza lungo il ponte della relazione che unisce bidirezionalmente il terapeuta con il paziente.
Parole chiave: Difetti del Sé, Emozioni dell’Autocoscienza, Vergogna, Ridicolo, Narcisismo, Intersoggettività, Grounding.
Premessa
Il rinnovamento delle teorie psicologiche della conoscenza avvenuto negli ultimi decenni ha restituito nuova attualità al tema, comunque sempre rimasto vivo, della relazione mente-corpo e con esso, inevitabilmente, anche alla necessità di superare la cartesiana idea di separazione tra questi due livelli di funzionamento dell’individuo.
Questa rinvigorita attenzione è molto il risultato delle nuove conoscenze e prospettive aperte sia dall’adozione dei modelli relazionali e intersoggettivi negli studi sullo sviluppo psicologico e sulle dinamiche che regolano il funzionamento della mente, che degli altrettanto importanti contributi provenienti dagli studi svolti nell’ambito delle neuroscienze, con tutte le nuove e numerose evidenze che essi hanno portato alla luce.
Le influenze di tutto ciò sugli approcci riconducibili all’area della psicoterapia corporea e sull’Analisi Bioenergetica di Alexander Lowen in particolare, sono numerose e profonde: tra queste, nel generale processo di revisione e adeguamento del modello che tali conoscenze e
prospettive sollecitano, si deve anche osservare come numerosi dei concetti originariamente formulati da W. Reich (Reich, 1973) e successivamente sviluppati da A. Lowen (cfr. ad es. Lowen, 1978, 1983) hanno assunto una rinnovata fondatezza e centralità.
Tra questi possiamo dire che è proprio il concetto di identità funzionale mente-corpo ad aver ritrovato un valore particolarmente stimolante in un’ottica di sviluppo, sia di tipo teorico che di prassi clinica: ad esso va infatti riconosciuto innanzitutto il merito, quanto mai ancora attuale, sia di aver aperto la strada ad una comprensione olistica della persona in termini fisici, comportamentali e psichici, che quello di aver reso prima concepibile e poi praticabile un metodo analitico non più unicamente centrato sull’uso della parola e che fosse, in un certo senso, anche schiavizzato da questa.
Un concetto particolarmente fertile che ha fortemente stimolato questo processo di sviluppo, e che ne rappresenta ancora oggi un suo fecondo humus, è quello del Sè con il quale, anche per l’insieme di patologie emergenti ad esso riconducibili, siamo costretti nel nostro lavoro di clinici ad un quotidiano confronto.
Possiamo in proposito ritenere che questa entità esperienziale rappresenti un osservatorio privilegiato per un modello a matrice psico-corporea come l’Analisi Bioenergetica: in questo senso anche il tema affrontato in queste pagine, quello del sentimento del ridicolo, il quale rimanda direttamente a quello delle emozioni dell’autocoscienza ed in particolare alla vergogna in quanto innescata da un senso di esposizione e di nudità di un Sé percepito come difettoso, può essere visto come un esempio di questo privilegio, oltre che uno stimolo, sia dal punto di vista della riflessione teorica in generale che dal punto di vista della riflessione più specificamente clinica.
Il caso di M.
M. era un ingegnere di circa 40 anni, divenuto da poco dirigente di una importante società in cui lavorava sin da quando aveva concluso gli studi universitari.
Questo nuovo incarico rappresentava un riconoscimento da parte del management aziendale che aveva creduto e investito su di lui, ritenendolo non solo il brillante ideatore di nuovi innovativi servizi, ma anche una persona dotata delle giuste competenze e qualità per svolgere funzioni di responsabilità nell’ambito commerciale e del marketing.
Ciò aveva significato che, nell’arco di pochi mesi, la tipologia del suo lavoro aveva subito una trasformazione radicale: ciò anche per il fatto che le sue attività, prima svolte prevalentemente all’interno dell’azienda e caratterizzate da rapporti intrattenuti soprattutto con i colleghi, divennero all’improvviso proiettate verso l’esterno richiedendo una inedita esposizione di se stesso anche in termini di immagine.
M. si era sentito molto orgoglioso per questo riconoscimento e all’inizio per nulla intimorito da queste nuove responsabilità, considerandole, in fin dei conti, solo l’ultima naturale evoluzione professionale in un percorso che era stato sempre in crescita e punteggiato da numerose soddisfazioni e successi.
Nel suo racconto sottolineò come, dopo un primo periodo di orientamento rispetto al nuovo incarico, arrivò il momento di doversi esporre “in prima linea”, come disse, per presentare di fronte ad una qualificata platea appositamente invitata, ed insieme ad alcuni suoi superiori, non solo la parte dei nuovi servizi di cui era divenuto responsabile, ma anche se stesso nelle nuove funzioni.
Proprio in tale occasione si verificò però qualcosa di inaspettato che lo aveva molto spaventato al punto di averlo poi anche convinto a cercare l’aiuto di uno psicoterapeuta: nel corso di questo evento, mentre si avvicinava il momento in cui avrebbe dovuto parlare, fu investito da un inatteso timore rispetto al dover salire sul palco degli oratori, timore che col passare dei minuti si trasformò in montante ansia. Di quei momenti fece il seguente racconto: “All’improvviso mi vidi al posto del mio direttore che stava parlando prima di me e sentii una specie di stretta nella pancia e nel petto, con il cuore che accelerava e un senso di calore che montava fino al viso ….., iniziai a sentire che la prospettiva di dovermi esporre davanti agli occhi di tutte quelle persone, alle loro valutazioni e ai loro giudizi, mi rendeva sempre più insicuro…. Per calmarmi e per ritrovare la mia abituale sicurezza cercai di pensare cose positive, ripetendomi che quello che stavo provando era insensato, che era tutto a posto e che in quella sala ero il più competente rispetto ai temi che avrei trattato…., ma questi pensieri servirono a poco….. Quando fui annunciato e dovetti alzarmi dalla mia sedia per raggiungere il palco, fu una esperienza orribile….., mi sembrava di essere totalmente sconnesso dal mio corpo…, mi sembrò che quei pochi passi avvenissero non per terra ma su un cuscino di aria…, a un certo punto mi venne pure la paura di poter inciampare e di cadere……”. Anche il ricordo del momento in cui iniziò a parlare era ancora particolarmente penoso e angosciante: di questo gli era rimasta specificamente impressa la sensazione di non riuscire ad articolare le parole in uno stato della mente caratterizzato da quasi completo vuoto e spaesamento.
In qualche modo riuscì comunque ad iniziare, e poi a portare anche a termine la sua presentazione perché, disse, fu salvato da un filmato che per fortuna aveva in precedenza preparato il quale gli servì a mantenere un filo nel suo discorso ma, soprattutto, a farlo sentire meno al centro della scena e dell’attenzione dei presenti.
Definì questo come il tempo più lungo della sua vita , dove si era anche sentito “spogliato e visto da tutti… come in una stanza le cui pareti divengono improvvisamente inesistenti…”.
Rispetto ai momenti successivi di quella giornata ricordava infine una forte ansia caratterizzata sia dal bisogno di scoprire cosa si era visto di lui “da fuori”, che dal terrore di poter avere conferme esterne, più o meno esplicite, di ciò che aveva vissuto dentro.
Su un piano di realtà alcuni elementi lasciavano supporre che, probabilmente, quanto era apparso all’esterno rappresentava solo una piccolissima parte di ciò che egli aveva vissuto dentro, ma questo non era, ovviamente, il punto centrale della questione.
Era quindi molto preoccupato per quanto successo e temeva fortemente che in futuro potesse accadere nuovamente qualcosa del genere: vissuto anche aggravato dal fatto di non essere riuscito, fino a quel momento, a darsene una qualunque spiegazione plausibile.
Il sentimento che emergeva da questo primo racconto era soprattutto quello di non sapere più in che misura potersi ancora fidare di se stesso: si era infatti sentito “tradito” da qualcosa di non conosciuto che era emerso innanzitutto come una esperienza corporea di disagio incontenibile, di fronte alla quale si era sentito, e ancora si sentiva, impreparato e impotente.
Rispetto al nostro incontro precisò che era la prima volta nella sua vita che si rivolgeva ad uno psicoterapeuta e di aver lottato molto con una parte di lui fortemente tentata di liquidare il tutto come “un semplice incidente che può capitare”: si decise però a cambiare definitivamente idea nel momento in cui iniziarono a comparire alcuni sogni che lo rimettevano in contatto con quanto era successo e dove un comune denominatore era la perdita di controllo delle risposte del suo corpo il quale iniziava, nei diversi contesti della scena onirica, a sudare, palpitare, arrossire, oppure a raggelarsi.
Questo racconto fatto da M. nel nostro primo colloquio, il quale segnò anche l’inizio di un lavoro durato in tutto circa 4 anni, consentì a suo tempo di formulare alcune ipotesi preliminari che in questo contesto possono anche servire come punto di partenza per sviluppare ulteriori riflessioni.
Una prima semplice constatazione è quella che riguarda la seria ferita narcisistica vissuta da M. nella misura in cui si era sentito incapace di governare se stesso e le sue reazioni, soprattutto corporee e quindi potenzialmente visibili, anche di fronte agli occhi dei suoi superiori e della platea dei partecipanti.
Rispetto alle possibili cause e difetti all’origine di questo episodio, per molti versi traumatico, possiamo osservare come l’organizzazione dell’Io avesse mantenuto una sua piena coesione e adeguatezza rispetto ai nuovi compiti, fino a quando il grado di esposizione di sé stesso rispetto al mondo esterno non raggiunse il livello di soglia rappresentato dall’importante evento pubblico del convegno.
Quella situazione era evidentemente stata fortemente evocativa di stati in precedenza rimossi i quali, nel loro improvviso e incontrollato emergere, avevano colto totalmente impreparato il suo sistema cosciente di funzionamento, su cui poggiavano anche il suo senso di equilibrio e di padronanza, determinandone il quasi disastroso collasso.
Tutto ciò era successo perché una serie di circostanze concomitanti, anche da lui coscientemente desiderate e indotte, lo avevano in breve tempo fatto arrivare in una posizione in cui era richiesta anche una capacità di gestione di se stesso e delle sue emozioni che aveva inaspettatamente scoperto, almeno in certi contesti, di non possedere.
Leggendo l’accaduto in termini di struttura narcisistica (Kohut, 1976, 1985; Kaiser 1999) ciò avvenne per la presenza di una irrealistica e disfunzionale autopercezione, nella quale erano state oscurate alcune parti deficitarie del Sè che si rivelarono però decisive affinché le sue indubbie competenze, capacità e risorse potessero in pieno affermarsi anche in una situazione di esposizione come quella in cui si era trovato.
Un altro aspetto che si può cogliere dal racconto di M. riguarda il tipo di emozione da cui era stato travolto, emersa a seguito dell’improvvisa autopercezione di eccessiva visibilità ed esposizione a cui sarebbe da lì a poco andato incontro parlando in pubblico, e a quel pubblico in particolare: sia per questo che per una serie di precisi elementi emersi successivamente nel corso dell’analisi, fu possibile identificare nella vergogna la vera emozione che si celava dietro quelle intense manifestazioni di ansia e malessere generalizzato.
In proposito si deve notare che dovettero passare circa sei mesi prima che M. riuscisse a divenire consapevole del fatto che l’episodio accaduto era imputabile soprattutto a questa emozione, e che con essa si era da sempre dovuto confrontare sin da bambino anche attraverso il tentativo di sfuggirvi in tutti i modi.
Il momento in cui potè nominarla e questo indicibile potè tradursi in parola fu un significativo punto di svolta per l’analisi e la frase che pronunciò può esserne anch’essa una testimonianza: “Mi rendo conto che, al di là dell’immagine pubblica che ho sempre esibito agli altri e a me stesso per primo, mi sono sempre profondamente vergognato …. il fatto è che mi sono anche sempre sentito indegno e impresentabile”.
Anche alla luce di questa consapevolezza, emersa come un insigth, si può perciò sostenere che egli dovette coltivare una immagine narcisistica in parte irrealistica, nella misura in cui doveva essere compensatoria di questa deficitaria percezione, sempre in agguato e in grado di minare profondamente la propria fiducia e autostima.
Rispetto allo stato complessivo da cui fu accompagnata questa consapevolezza si deve osservare come esso fosse caratterizzato da una intensa percezione emotiva di se stesso; ciò anche confermato dal fatto che nel pronunciare queste parole anche il suo corpo aveva assunto alcune delle posizioni di nascondimento tipiche di questa emozione: la testa appariva incurvata verso il basso, il petto era imploso e ulteriormente nascosto dalle spalle collassate in avanti, lo sguardo era rivolto verso la terra e da questo orientamento aveva difficoltà a riemergere.
Come detto ci vollero alcuni mesi prima di giungere a questo significativo punto di svolta: in tale periodo ci furono molti passaggi intermedi nel nostro lavoro durante i quali ci si concentrò su una serie di sentimenti emergenti che già “parlavano” della vergogna ben prima che questa potesse essere, non solo trattata sul piano della coscienza rispetto alle sue origini e significati, ma anche solo chiamata con il suo nome.
Tra questi sentimenti uno particolarmente ricorrente, emerso in questo paziente ma osservabile anche in molti altri casi, era quello del sentirsi e vedersi ridicolo durante alcune esperienze corporee.
Esso si mostrò per la prima volta in tutta la sua chiarezza nel corso di una seduta dopo circa due mesi dall’inizio dell’analisi.
Nel corso di questo incontro proposi a M. un’esperienza, classica in Analisi Bioenergetica, in grado di poterlo aiutare a conoscersi meglio anche partendo del suo sentirsi appoggiato e sostenuto dalla terra sotto i suoi piedi: questa esperienza è basata sul concetto di grounding sviluppato da Alexander Lowen (Lowen, 1978, 1983, op.cit.), il quale per primo lo utilizzò per teorizzare e descrivere la relazione esistente tra tale stato insieme alle relative percezioni di se stessi a cui specificamente si accompagna, con dimensioni di natura più strettamente psicologica rilevabili nel singolo individuo.
Sulla base di questo concetto Alexander Lowen adottò, per la prima volta nella storia dell’analisi, la postura eretta nell’ambito del lavoro clinico, la quale consentì anche di creare una alternativa rispetto alla posizione più regressiva distesa fino a quel momento sempre assunta dai pazienti: ciò permise loro di confrontarsi ed esperire un sé più adulto caratterizzato, anche in senso strettamente evolutivo, dal “reggersi sulle proprie gambe” sentendo, nel contempo, la connessione e il sostegno rispetto alla terra sotto i propri piedi.
Con questo tipo di lavoro M. aveva già iniziato a familiarizzare nei nostri precedenti incontri e quando lo invitai a ripeterlo, gli ricordai anche in cosa consisteva insieme a tutti i semplici passaggi che avrebbe dovuto cercare di compiere: doveva perciò mettersi innanzitutto in piedi, tenendo le ginocchia leggermente flesse per poter meglio percepire le sensazioni che giungevano dalle sue gambe e dal senso dell’appoggio dei piedi sul pavimento. Poteva anche tenere gli occhi chiusi se sentiva che questo lo aiutava a concentrarsi sulle sue percezioni e sensazioni interne.
Lo invitai poi, una volta che si fosse sentito più consapevole di lui e del suo corpo, a pronunciare qualche volta anche la parola “Io”, cercando però di prestare attenzione non tanto al significato esplicito e scontato di questo termine, quanto al senso di risonanza interna che questa avesse eventualmente potuto suscitare in lui.
Lo invitai anche, ogni tanto, a ricordarsi di prestare attenzione ad altre due cose: al suo respiro e alla duplice sensazione del sostenersi ed essere sostenuto dalle sue gambe e dalla terra sotto i suoi piedi. Sottolineai infine che per questo lavoro poteva prendersi tutto il tempo necessario senza scivolare nella fretta, visto che eravamo ancora nella parte iniziale della seduta.
L’esperienza durò complessivamente circa venti minuti: diverse cose, anche molto interessanti dal punto di vista della comunicazione implicita e osservabili sul piano non verbale, accaddero in questo tempo trascorso senza parole.
Ai fini che qui specificamente interessano descriverò più diffusamente solo ciò che avvenne nei circa 5 minuti precedenti all’interruzione dell’esperienza.
In questa fase M. entrò in uno stato mente-corpo in cui a un certo punto tutto il suo essere, espresso ad esempio dal tono della voce mentre pronunciava la parola “Io” che divenne più profondo, da una postura meno esibita e con le spalle leggermente richiuse sul petto ma non collassate, dall’espressione concentrata del suo volto su cui comparve anche un leggero rossore, dal ritmo del respiro che divenne più profondo e sincronico anche in relazione al suono emesso, mostrò una condizione di profonda e intensa compartecipazione. Questo stato durò non più di 30 secondi, dopo di che mostrò di perderlo quasi interrompendosi: poco dopo però, senza che dicesse o ci dicessimo esplicitamente nulla, iniziò spontaneamente a cercarlo di nuovo. Dopo un po’ riuscì a ritrovarlo, mostrando a questo punto anche un rinnovato interesse e curiosità per ciò che stava inattesamente provando.
Ma a questo punto, repentinamente, avvenne che nel suo corpo iniziarono a mostrarsi i segni di un crescente e inequivocabile disagio: aprì infatti gli occhi, rimasti fino a quel punto per gran parte del tempo chiusi, mostrando uno sguardo che divenne roteante e sfuggente, un po’ come per scappare da una “vista” di se stesso, oltre che dalla mia vista che lo guardavo seduto di fronte a lui. Nel contempo iniziò a muovere il corpo piuttosto nervosamente, i segni di una crescente rigidità e sconnessione aumentarono, il respiro perse di fluidità e pienezza e quindi, in poco tempo, lo stato precedente svanì e si dissolse.
Quando si sedette era visibilmente colpito e disorientato, tanto che lo invitai a prendersi un attimo di tempo prima di provare a raccontarmi ciò che aveva sentito ed era accaduto in lui.
Dal suo successivo racconto e dal lavoro di ricostruzione fatto insieme emerse che a un certo punto, un po’ prima di interrompersi, aveva avuto la profonda sensazione di sentirsi intero dalla testa ai piedi. Questa all’inizio era stata molto piacevole perché accompagnata anche da un gradevole flusso di sensazioni che avevano percorso il suo corpo in varie parti e direzioni determinando un’inedita percezione di solidità e vitalità. Tutto ciò anche rinforzato sia da una percezione di forza e di autosostegno nelle sue gambe che, nel contempo, da una piacevole e rassicurante sensazione di eterosostegno ricevuta dal pavimento sotto i suoi piedi.
Ma a questo punto, col crescere di queste sensazioni e di questa percezione di se stesso, aveva iniziato anche a sentirsi progressivamente sempre più esposto e in balia di qualcosa che, seppur piacevole da un lato, sembrava poter sfuggire al suo controllo e portarlo in qualcosa di pericoloso. Questo stato divenne poi insostenibile quando, come in un flash, si era guardato da fuori e pure visto da me, percependosi “sgraziato e profondamente ridicolo, …. in quella postura con le ginocchia flesse innanzitutto!….”: fu proprio in quel punto che aveva quindi deciso di interrompere definitivamente l’esperienza.
Se si analizza questa seduta seguendo innanzitutto la sequenza di come i diversi vissuti e stati si susseguirono, si deve osservare come i primi ad emergere furono, in questo caso, quelli di segno decisamente positivo i quali aprirono la strada ad una consapevolezza di sé caratterizzata da padronanza, integrazione e vitalità. Con l’aprirsi di questa porta e in questo processo di espansione e amplificazione delle diverse sensazioni, M. iniziò però anche a sentirsi sempre meno in grado di contenere e autoregolare ciò che stava emergendo, tanto da entrare in contatto con il timore di poterne essere travolto: dopo poco queste sensazioni, di segno decisamente opposto rispetto alle prime, finirono perciò per occupare il centro della scena al punto di determinare la chiusura di quella stessa porta. Ciò anche a testimonianza del fenomeno ben noto in base al quale nel processo del sentire se stessi il varco che si apre rende possibile l’emergenza di qualunque contenuto presente nell’inconscio, indipendentemente dal suo segno: e in questo caso ciò che alla fine improvvisamente emerse fu proprio l’insopportabile vissuto di sentirsi “sgraziato e profondamente ridicolo”.
Quanto accadde in questa seduta può essere considerato un buon esempio di come con il metodo dell’Analisi Bioenergetica questo varco possa aprirsi partendo dagli input somatici e dalle sensazioni corporee, le quali possono essere poi successivamente utilizzate come base per creare una connessione e integrazione anche con altri livelli di rappresentazione mediati da codici diversi, come ad esempio quelli di tipo linguistico, con l’obiettivo più generale di ampliare la capacità di contenimento e di regolazione dei diversi stati affettivi attraverso lo sviluppo di un senso di sé meglio integrato ai diversi livelli della coscienza.
Si può in proposito ricordare come un’altra parte del metodo dell’Analisi Bioenergetica persegua lo stesso obiettivo, in un percorso però opposto che inizia, ad esempio, da rappresentazioni codificate ed espresse a un livello verbale per tentare poi di giungere all’esperienza dei correlati e concomitanti stati del corpo (Lowen, 1983, op.cit.).
In questa seduta M. entrò in contatto con il sentimento del sentirsi ridicolo partendo proprio dalle sensazioni e dalle percezioni del suo corpo o, potremmo dire, anche attraverso i sensi della propriocezione e dell’enterocezione, quest’ultimo in particolare riportato in primo piano anche all’interno di riflessioni maturate nell’ambito di studi neurobiologici (Damasio, 2003; Siegel, 2009).
Fu quindi proprio attraverso questi sensi e la focalizzazione su questo sentimento che il lavoro con M. potè proseguire fino all’emergere consapevole dell’emozione sottostante di vergogna: parallelamente ciò consentì anche di recuperare la memoria di alcuni episodi rimossi, occorsi nell’infanzia all’interno della relazione con i propri genitori e da cui sia questo sentimento che questa emozione potevano esser fatti discendere.
Le emozioni e i sentimenti
Una importante questione sollevata da quanto appena detto ha innanzitutto a che fare con la distinzione che qui viene fatta tra emozione e sentimento, termini spesso utilizzati in maniera piuttosto indistinta: si può invece ritenere che la separazione tra questi due concetti trovi una sua utilità anche in ambito clinico, nella misura in cui ci può aiutare ad osservare i fenomeni emergenti in una maniera più chiara e differenziata.
Possiamo intendere questi due concetti come entrambi riferiti ad uno stesso processo in un ciclo che parte dalle emozioni per arrivare ai sentimenti (Damasio, 2003). In esso le prime rappresentano la componente esibita all’esterno in quanto costituite da “azioni o movimenti in larga misura pubblici, ossia visibili ad altri nel momento in cui hanno luogo, manifestandosi nel volto, nella voce o in comportamenti specifici” (Damasio, ibid, p. 40). I sentimenti invece “sono sempre nascosti, come lo sono necessariamente tutte le immagini mentali, invisibili a chiunque salvo che al loro legittimo proprietario” (Damasio, ibid.).
Una importante implicazione di questa distinzione riguarda il fatto che il corpo viene chiamato direttamente in causa, anche se da diverse angolature, in entrambi i fenomeni. Mentre infatti le emozioni sono reazioni che si esprimono su un piano corporeo e somatico, i sentimenti possono essere considerati come pensieri che rappresentano il corpo durante questo suo coinvolgimento reattivo e nel suo essere in un certo modo: in questo senso “le emozioni si esibiscono nel teatro del corpo; i sentimenti in quello della mente” (Damasio, ibid.).
Quando perciò nel corso dell’analisi e delle esperienze che proponiamo in Analisi Bioenergetica, invitiamo i nostri pazienti a prestare una attenzione particolare a cosa sentono in loro, piuttosto che a cosa pensano di loro, li stiamo indirizzando verso un processo che, partendo dall’esperienza interna di se stessi, mira alla riconnessione con i sentimenti del loro corpo, per poter poi cercare anche di giungere ad altri livelli di rappresentazione, che potranno successivamente essere integrati, a un livello più generale, all’interno di una narrazione il più possibile coerente di se stessi e della propria storia.
Un altro aspetto da sottolineare è che i sentimenti coscienti “richiamano l’attenzione sulle emozioni che li hanno generati e sugli oggetti che, a loro volta, hanno indotto quelle emozioni” (Damasio, ibid., pag. 216). Inoltre, siccome essi vengono contestualizzati rispetto al sé autobiografico ed entrano a far parte del sistema della memoria, ciò gli consente di svolgere una funzione di valutazione rispetto alle situazioni e agli stati che possono evocare una certa emozione. In alcuni casi, quando il sentimento è ad esempio collegato ad un’emozione particolarmente penosa, essi segnalano all’organismo un incombente stato di pericolo per indirizzarlo verso la difesa o l’allontanamento.
Il ridicolo e la vergogna
Quanto fin qui detto consente di meglio comprendere quanto successe ad M. e perché il sentimento del ridicolo comparve in analisi prima che potesse riemergere l’emozione sottostante della vergogna, ridiventando anche parte del suo vocabolario.
Innanzitutto possiamo interpretare quanto accaduto nel corso di quell’evento traumatico e che lo spinse poi in analisi, come il risultato di una situazione in cui, possiamo dire, il suo inconscio fu il primo a esser colto di sorpresa: M. non aveva infatti in alcun modo potuto prevedere, soprattutto per l’oscuramento imputabile all’irrealistica immagine narcisistica di sé che aveva fino a quel momento dovuto coltivare, che un contesto pubblico come quello in cui si era trovato avrebbe potuto evocare un’emozione così violenta e incontrollabile; e quando le prime sensazioni di disagio iniziarono a comparire, era ovviamente ormai troppo tardi per farci qualcosa di più che cercar di arrivare alla fine nel modo meno rovinoso possibile .
Successivamente nel corso dell’analisi, come detto, prima che potesse essere affrontato il tema della vergogna, egli si dovette confrontare con il sentimento del ridicolo il quale, sia nella seduta citata che in altre occasioni, rappresentò un segnale di pericolo, uno stop che lo spingeva quindi ad interrompere in diversi modi le esperienze che stava facendo.
Possiamo quindi dire che esso svolgeva una funzione anticipatoria rispetto ad una situazione, che seppur vissuta nel contesto dell’analisi, era comunque temuta perché in grado di evocare una emozione ritenuta ingestibile dall’Io; esso rappresentava perciò un sentimento-segnale, rilevato dalla coscienza, il cui significato era più o meno questo: “Attenzione perché se questa esperienza va avanti potresti vergognartene”.
D’altro canto si deve anche notare come, mentre in analisi questo sentimento fu possibile isolarlo sul piano della coscienza risalendo poi alle sue probabili origini e ad alcuni dei suoi significati, in precedenza nella sua vita esso aveva sempre subito lo stesso destino di rimozione dell’emozione della vergogna da cui si originava e che a sua volta evocava: non era stato quindi per lui mai possibile utilizzarlo a nessun livello nella sua potenziale funzione anticipatoria e coscientizzante del profondo disagio occultato dentro di sè.
Rispetto a questo meccanismo generale attraverso il quale possiamo divenire consapevoli di come ci sentiamo in un certo momento, va ricordato come in ogni esperienza è il corpo che ci informa, attraverso i meccanismi di retroazione fisica e i segnali che giungono a livello centrale, su cosa stiamo provando. (Ruggieri, 2001; Siegel, 1999). Questo meccanismo è stato ipotizzato che operi anche per la presenza di “marcatori somatici”, definiti come le percezioni e le rappresentazioni a livello cerebrale degli stati del corpo e i relativi cambiamenti (Damasio, 1994). In proposito questo autore ha anche parlato di marcatori somatici “come se”, in grado di scatenare una risposta sensoriale pur riferendosi a rappresentazioni di risposte del nostro corpo svincolate dalla realtà del momento e attivabili anche sulla base del solo ricordo di una certa esperienza emozionale o di stati in qualche maniera ad essa associati.
Un altro aspetto da sottolineare riguarda il fatto che per l’attuarsi di questo meccanismo sono particolarmente rilevanti “i cambiamenti che si verificano a livello dei muscoli degli arti e del viso” che possono perciò esser visti come “componenti essenziali delle nostre reazioni emozionali….” (Siegel, 1999, p. 142).
Tutto ciò, oltre a rappresentare un sostegno ulteriore rispetto ai meccanismi di retroazione fisica da sempre postulati in Analisi Bioenergetica e su cui anche una significativa parte della sua prassi clinica si fonda, ci consente di descrivere, ad esempio, un’ulteriore parte del processo che dopo circa due mesi portò M. a percepirsi in analisi profondamente ridicolo.
Se infatti riprendiamo in considerazione proprio le parole di M. quando disse di sentirsi “sgraziato e profondamente ridicolo, …. in quella postura con le ginocchia flesse innanzitutto!….”, possiamo ipotizzare che fu questa posizione degli arti, vissuta come innaturale e goffa, ad attivare, attraverso i meccanismi di retroazione fisica, una rappresentazione anche visiva di se stesso “ridicolo” la quale era a sua volta originata, così come successivamente chiaramente emerse nel corso dell’analisi, da esperienze passate completamente rimosse dalla propria coscienza.
Il corpo visibile
Per cercare di comprendere i motivi per cui il corpo occupa una posizione così centrale nell’emozione della vergogna e nel correlato sentimento del ridicolo, non si può però prescindere dall’esaminare alcuni fattori che possiamo considerare la matrice su cui poi inevitabilmente si dovrà innestare anche il nostro lavoro clinico.
Una prima osservazione riguarda il fatto che il tema della corporeità tende di per sé a stimolare, oltre all’immanente desiderio della persona di conoscere e padroneggiare meglio se stessa in questa fondamentale dimensione, anche una corrispondente ambivalenza che si esprime, ad esempio, nella dialettica esistente tra le polarità del guardare e dell’essere guardati, dell’esser visti e del potersi vedere.
Questo perché è proprio attraverso il nostro corpo visibile che noi ci es-poniamo o ci nascondiamo, ci riveliamo o ci veliamo: è ciò che a livello letterario è stato numerose volte espresso attraverso la rappresentazione delle eterne polarità della persona e del personaggio, del volto e delle sue maschere, in altri termini dell’essere e dell’apparire.
Da osservare come tali dimensioni facciano riferimento ad un corpo già in relazione nella misura in cui, anche il solo atto consciamente e inconsciamente immaginato del guardare e dell’essere guardati, è già un evento relazionale che si colloca lungo una linea di confine posta tra l’interpersonale e l’intrapsichico, tra l’ambito oggettuale e quello narcisistico, e dove le forme che tale atto può assumere sono funzione della sua coniugazione con le categorie dell’essere soggetto o del sentirsi oggetto dell’osservazione secondo diverse simmetrie.
E quindi, se il nostro corpo è ciò che ci rende visibili, che ci vela e ci rivela a noi stessi e all’altro, sul versante dell’interpersonale esso può essere o divenire l’oggetto di un particolare sguardo che possiamo recepire in tutte le sue possibili valenze, tra le polarità del buono e del cattivo, dell’accettante e del rifiutante. Proprio a partire da questa esposizione, nella misura in cui esso rappresenta la nostra interfaccia rispetto al mondo esterno, si possono perciò innescare tutti i sentimenti possibili compresi tra il piacere e il massimo della sofferenza e della pena.
Possiamo infatti dire che attraverso il nostro corpo è la nostra intimità e l’immagine di noi stessi ad essere messa in gioco, ad essere potenzialmente resa pubblica o, si potrebbe anche dire, ad esser messa nelle mani dell’altro attraverso il reso visibile ai suoi occhi.
D’altro canto sul versante dell’intrapsichico, mai comunque nettamente separato dal precedente ma sempre ad esso variamente sovrapposto e intersecato, l’esposizione del corpo a se stessi ha innanzitutto a che fare con l’immagine autopercepita e con tutta una serie di valutazioni e giudizi su cui poggia il senso della nostra identità.
Rispetto a questa posizione centrale che assume il corpo nello svelarsi della nostra identità, che diviene anche sentimento laddove emerge consapevole la percezione di ciò che sentiamo di essere, possiamo dire che essa rappresenta anche il territorio di confine dove diviene evidente l’intersezione fra il piano dell’interpersonale e dell’intrapsichico ma dove è anche evidente la loro inestricabilità: ci si sente, e quindi ci si vede in un certo modo, perché ci si sente oggetto di un certo tipo di attenzione, ma anche viceversa. Questo vissuto presente è anche profondamente radicato nelle esperienze passate, dove la matrice di lettura utilizzata consciamente e inconsciamente nel sentire di oggi, è molto il prodotto attualizzato di attenzioni e di sguardi ricevuti e subiti in fasi anche precoci dell’esistenza e provenienti dalle principali figure di accudimento.
Nello specifico si vuole qui evidenziare come il tema della corporeità sia in grado di evocare già di per sé, a tutti i livelli della coscienza, una serie di vissuti personali per un complesso gioco di specchi e rispecchiamenti dove l’Io e l’Altro sono, sin da subito, in qualche misura seppure tra diverse penombre, già rappresentati in molte delle loro categorie.
Il tema del corpo e della sua stretta relazione con le emozioni non è nuovo nell’ambito della psicologia: le emozioni furono infatti definite già nel 1890 da W. James (James, 1890) come percezioni di stati corporei.
Tra tutte le emozioni la categoria che qui specificamente interessa riguarda quelle in cui una peculiare caratteristica è quella di innescarsi a partire da un giudizio espresso su di sé che a sua volta presuppone anche l’esistenza di un altro giudicante, interiormente anche solo rappresentato e non necessariamente reale e presente nel qui ed ora.
Sono appunto le emozioni definite dell’autocoscienza, o dell’autoconsapevolezza (Lewis, 1992), o anche interpersonali (Battacchi, 2000) nella misura in cui prevedono il confronto con l’altro percepito come presente.
In questa categoria rientrano emozioni come la vergogna, l’imbarazzo, l’orgoglio, il senso di colpa, emozioni che è possibile differenziare dalle altre fondamentali come la rabbia, la tristezza, la sorpresa, la gioia, per le quali non necessariamente è richiesto per il loro insorgere la presenza dell’altro come sopra definito.
Nel caso della vergogna, in particolare, è il senso del sentirsi visti e scoperti di fronte a sé stessi o agli altri (M. Lewis, op. cit.) a determinare il suo innesco. In questa emozione è come se si facesse un’esperienza di sé stessi solo nei termini di quegli aspetti ritenuti più indecorosi e ridicoli, e dove questa esperienza è pervasa da una sensazione di tipo percettivo, il cui accesso nella coscienza può essere molto rapido tanto da evocare un improvviso, violento e spesso invalidante senso di nudità e di paralisi. Essa è perciò spesso anche accompagnata da un potente impulso a scomparire, già identificato da Darwin (Darwin, 1890) come centrale rispetto alla sua fenomenologia.
Pur trovandoci però in presenza di un fenomeno percettivo pressoché istantaneo, spesso accompagnato da manifestazioni imputabili ad una elevata attivazione del sistema nervoso autonomo (rossore facciale, perdita di forze, sudorazione, battito cardiaco accelerato, ecc.), la vergogna rientra nella categoria delle emozioni definite complesse: essa compare infatti nel corso dello sviluppo più tardivamente rispetto ad altre, richiedendo la presenza di un Sé sviluppato a sufficienza in termini di coscienza e di autoriflessività.
Nel caso delle emozioni autoconsapevoli si è in presenza, infatti, di stati di coscienza in cui siamo noi stessi l’oggetto dell’osservazione: l’attenzione si dirige sul Sé oggetto e quindi verso il nostro interno e sugli stati e stimoli che vi provengono (Lewis, op. cit.).
Questo livello bipolare è ben evidente proprio nell’emozione della vergogna se la analizziamo dal punto di vista della sua struttura: vi possiamo infatti riconoscere un polo soggettivo, riconducibile all’Ideale dell’Io, il quale ha a che fare con l’esposizione di una parte difettosa del Sé che mette a repentaglio la propria immagine ideale (Kohut, 1986), e di un polo oggettivo rappresentato dallo sguardo osservante dell’altro vissuto come giudicante. In tal caso è quindi il sapersi, o anche il solo pensarsi, oggetto di un certo tipo di sguardo a poter indurre la vergogna.
Inoltre è anche il livello dell’immagine sociale ad essere coinvolto nella misura in cui la vergogna può esser vista come il segnale di una possibile, o già avvenuta, compromissione della buona immagine e della propria autostima. (C. Castelfranchi, 1998; Matarazzo, 1999).
Ciò che qui comunque più preme evidenziare è la forte caratterizzazione somatica di questa emozione: essa infatti può coinvolgere istantaneamente il corpo in numerose sue dimensioni di soggetto e di oggetto (cfr. ad es. anche in Lowen, 1985) fino ad arrivare, nei casi più gravi, a mettere a repentaglio il senso complessivo di Sé; in tali casi ciò avviene attraverso una specie di inondazione travolgente della persona intera che si ritrova così come nel caso di M, visibile, svelata e “nuda” di fronte agli occhi del mondo esterno, anche per le spesso vistose e incontrollabili manifestazioni somatiche di origine neurovegetativa prima citate che la possono accompagnare.
All’interno dell’esperienza psicoterapeutica, soprattutto se di tipo analitico corporeo, possiamo pertanto considerare questa emozione estremamente importante nello sviluppo del processo terapeutico (Lowen, 1984) sia per tutta la serie di rappresentazioni da cui si origina e che a sua volta evoca, sia per i diversi accadimenti corporei che la precedono e la accompagano nel suo emergere.
D’altro canto si può osservare come tale sua centralità tenda facilmente ad esser persa per l’instaurarsi anche in analisi di meccanismi difensivi, sia nel paziente che nel terapeuta, i quali tendono a deviare il fuoco dell’attenzione su altri registri emotivi, come ad esempio sulla rabbia o sul senso di colpa, in quanto percepiti molto più agevoli sia da esperire che da trattare.
I motivi di questo possono esser fatti risalire ad alcune caratteristiche specifiche e intrinseche di questa emozione in grado, già da sole, di spiegare in parte questa tendenza.
Si è ad esempio già detto come essa si presenti anche con accessi improvvisi e totalizzanti tali da annichilire il senso di sé (Schore, 2008): ma allo stesso modo essa può scomparire altrettanto repentinamente, cedendo la ribalta ad altre emozioni, in particolare alla rabbia ma anche alla tristezza, all’invidia o alla gelosia. Questo suo scomparire dalla ribalta, fortemente sostenuto dal desiderio che mai più ricompaia vista la penosità e l’insostenibilità dei vissuti che porta con sé, è sicuramente uno dei motivi per cui può risultare così difficile riportarla in primo piano per renderla analizzabile.
D’altro canto essa può essere considerata un’emozione fondamentalmente intersoggettiva, caratteristica ben rilevabile nella sua struttura fenomenica laddove il sé è diviso e contemporaneamente bilocato sia nel soggetto che nell’altro: anche per questo essa è caratterizzata da valenze fortemente contaminanti le quali possono percorrere anche il ponte della relazione terapeuta-paziente in entrambe le direzioni in maniera difficilmente arginabile e pressoché istantanea. Ci si può infatti vergognare anche attraverso la semplice osservazione dell’altro, e questo può mettere il terapeuta in contatto, diretto, inatteso e molto personale con questa entità che, in tali casi, potrebbe esser liquidata attraverso manovre difensive di diverso tipo, come ad esempio quella di spostare il registro dell’analisi.
Da ultima si deve ricordare una sua particolare caratteristica che contribuisce non poco nel rendere difficile il contatto con essa. Questa emozione, infatti, a differenza della colpa dove ad esempio non ci si sente in colpa per i propri sensi di colpa, tende a rinforzarsi in maniera circolare: ci si vergogna della propria vergogna, in un circuito autoalimentato fortemente temuto anche per questo suo potenzialmente incontrollato perpetuarsi.
La vergogna nella relazione analitico-corporea
Sulla base di tutto questo, ritornando al caso di M., possiamo dire che egli aveva scoperto, all’improvviso e dolorosamente, di non poter essere un bravo conferenziere: la sua storia professionale gli aveva dimostrato di poter essere tante altre cose ma non questo, almeno in quel momento.
Con l’emergere, infatti, di quello stato di incontenibile ansia e malessere, che poi si rivelò essere una antica e profonda vergogna per lungo tempo rimossa anche a livello del proprio vocabolario personale, aveva vissuto il potenziale dissolversi della parte illusoria della propria immagine, minata nel giro di pochi istanti in quella sala dove si era trovato esposto agli sguardi potenzialmente giudicanti e sprezzanti degli osservatori e dei suoi superiori in particolare. Nel momento in cui questa fragilità divenne ineludibile percezione cosciente e corporea, solo pochi minuti prima di prendere la parola, desiderò nascondersi e tornare, inaspettatamente, ad un più rassicurante anonimato: ma, come di norma accade in questa emozione per tutte le sue concomitanti manifestazioni fisiche, quello fu per lui proprio il momento di massima riconoscibilità e visibilità di fronte a se stesso e agli altri, dove si sentì completamente denudato in uno spazio “le cui pareti divennero improvvisamente inesistenti”.
E questo senso di svelamento, al di là di ciò che nella realtà venne pure colto all’esterno, fu così violento e totale perché gli occhi giudicanti con cui il suo Io dovette confrontarsi erano soprattutto quelli della sua coscienza, del suo vero sé, di fronte ai quali in quella occasione non gli fu possibile velarsi e sfuggire.
Ma in questo senso fu però, non un momento di sola sconfitta, ma anche un importante momento di verità, in cui M. potè iniziare a distaccarsi da un ideale illusorio fino ad allora inseguito con tutte le forze e che, non solo lo metteva in pericolo nella misura in cui inconsapevolmente ingaggiava ad esempio sfide a cui non era pronto e neppure veramente interessato, ma lo allontanava da una reale consapevolezza di sé e dall’opportunità di poter, con un più intero piacere di derivazione non solo narcisistica, coltivare le sue più genuine risorse e personali attitudini.
Perseguire questi obiettivi è ovviamente un compito sempre molto complesso e difficoltoso, esattamente come lo fu nel caso di M., per tutti i motivi già detti o anche per il semplice fatto che il solo pensare di provare vergogna porta in primo piano un vissuto particolarmente sgradevole in cui ci si percepisce come deboli, inadeguati e gravemente difettosi, al di là del pur auspicabile fine ultimo che si ha in prospettiva davanti.
Trasformare questo difficile vissuto in una opportunità di crescita personale richiede perciò l’attraversamento di un terreno molto complesso, non per il solo paziente ma per entrambi i membri della diade analitica, anche per la già citata forte componente intersoggettiva che vi è implicata: se infatti intendiamo quest’ultima come il “vissuto di una esperienza condivisa con un altro essere umano” (Trevarthen, 1998, cit. in Lavelli, 2007, p. XIX), è evidente come tale compito possa risultare, particolarmente in presenza di questa emozione, molto arduo anche dal punto di vita del terapeuta.
In un’ottica diversa possiamo però considerare queste indubitabili difficoltà anche nei termini delle opportunità che parallelamente ci vengono offerte dal punto di vista dello sviluppo del nostro modello e metodo dell’Analisi Bioenergetica, consentendoci di meglio comprendere proprio l’importante ruolo che l’intersoggettività (Orange et. al., 1999) riveste all’interno dell’esperienza analitico-corporea: per questo è però preliminarmente necessario anche riconsiderare un importante aspetto, finora rimasto spesso in ombra, e che attiene proprio al tema del corpo e alle sue implicazioni rispetto all’emozione della vergogna.
A tale proposito, in modo emblematico, si può riprendere in considerazione il lavoro sul grounding e osservare come in questo tipo di esperienza, contestualizzata all’interno della originaria matrice monopersonale del modello, a sua volta anche basato su una teoria psicologica centrata sul funzionamento intrapsichico, si è per molto tempo focalizzata l’attenzione sui fattori, concettualizzati anche in termini di “blocchi” psico-corporei, che limitavano o impedivano, al paziente e nel paziente, di esperire il proprio sé adulto in una maniera più piena e radicata, in analisi così come nella propria vita.
I tipi di intervento che in generale ne conseguivano erano molto del tipo “sul paziente”, finalizzati quindi alla eliminazione di quelle cause, rilevate anche a livello strettamente corporeo (tensioni, irrigidimenti, anestesie, ecc.) e ritenute determinanti sia per l’origine che per il mantenimento nel qui ed ora del “blocco” stesso.
In proposito si deve però rilevare come questo tipo di focalizzazione e di approccio abbia contribuito ad oscurare un altro importante aspetto, di natura anche specificamente relazionale, implicato nell’assunzione della postura eretta in analisi: il fatto cioè che il paziente, nel suo ritrovarsi sulle sue gambe, in piedi davanti al terapeuta osservante, diventava anche un “corpo visibile” e guardato; con questo egli diveniva pertanto non solo un soggetto più adulto in grado di autosostenersi attivamente, ma anche, allo stesso tempo, un corpo osservato, stato e posizione questa in grado di evocare fortemente tutte le tematiche in precedenza citate relative alla vergogna. Si può infatti considerare lo scenario relazionale potenzialmente indotto da questo tipo di esposizione, dove si è in piedi di fronte al Terapeuta-Altro-Osservante, in un certo senso archetipico proprio rispetto a questa emozione anche in funzione delle innumerevoli rappresentazioni che può, consciamente e soprattutto inconsciamente, evocare.
Si deve comunque rilevare come ad A. Lowen non sia sfuggito il nesso esistente tra l’esposizione, in particolare del viso inteso nell’accezione di faccia, rispetto all’insorgenza di questa emozione, anche se poi a questa osservazione non seguì un più specifico approfondimento delle numerose tematiche che vi erano connesse. In proposito egli ad esempio dice: “La parola faccia viene anche usata per riferirsi all’immagine di una persona, collegando così il concetto di faccia all’io… Perdere la faccia significa che l’io ha subito un’umiliazione….. Nascondere la faccia implica un senso di vergogna, di umiliazione dell’io.” (Lowen, 1983, p. 76; cfr. anche Anolli, 2000).
Se è perciò in generale vero che comunque e sempre, qualunque psicoterapia presuppone per il paziente una scelta di visibilità di parti intime e fragili di sé, in altri termini di rischiare la faccia, ciò lo è particolarmente nella misura in cui è anche il suo corpo a diventare così visibile ed esposto, innanzitutto in questa classica esperienza, ma anche in tutte le altre esperienze corporee che vengono proposte ai pazienti davanti ai nostri sguardi.
In questo senso è quindi necessario tenere ben presente che questa strada in grado di portare il paziente a sperimentarsi sempre di più soggetto attivo in grado di autosostenersi, inevitabilmente prevede anche l’attraversamento di questo territorio dominato dalla vergogna, scomodo e nel contempo delicato per il paziente, per il terapeuta e per la relazione nel suo complesso.
Ci sono pertanto numerosi motivi per riportare in primo piano questa emozione la quale, molto probabilmente “… è responsabile del corso che prende la nostra vita psichica …più del sesso e dell’aggressività…” (Lewis, op. cit. p. 6).
Tra questi motivi, in un’ottica di evoluzione del modello e della tecnica dell’Analisi Bioenergetica, c’è sicuramente quello che costringe ad un sempre più aperto confronto con la dimensione relazionale dell’analisi, quindi all’osservazione di ciò che accade su quel ponte ideale che unisce bidirezionalmente il terapeuta con il paziente anche attraverso i soli sguardi pensati.
Possiamo in proposito affermare, come già in precedenza sottolineato, che il rinnovamento della teoria psicologica della conoscenza, portato con sé dall’adozione di questo modello teorico-pratico, è molto grande: ciò innanzitutto perché il fuoco dell’osservazione non è più il paziente-oggetto, bensì è la relazione stessa che diviene il centro dell’osservazione, restituendo al paziente la dignità di persona e rendendo nel contempo anche il terapeuta “più persona”.
In questa logica bipersonale ciò che quindi accade in terapia non è più solo “in lui”, ma anche “in me”, “tra noi”, “in mezzo a noi”. In tutte le pieghe, si potrebbe anche dire, della nostra relazione e dei nostri stati mente-corpo consciamente e, soprattutto, inconsciamente condivisi e interagenti.
A tale proposito si può tornare proprio al caso di M., e in particolare alla seduta in cui egli interruppe l’esperienza del grounding quando si percepì sgraziato e profondamente ridicolo: tale sentimento di se stesso emerse infatti anche come risultato della situazione relazionale vissuta in analisi, in particolare nel momento in cui si guardò da fuori in quanto visto da me, nel gioco quindi di specchi e rispecchiamenti dove incarnai lo sguardo della sua coscienza giudicante.
Nelle sedute successive non fu facile esplorare insieme ad M. quest’area anche perché, quando ad esempio gli riproposi dopo alcuni incontri la stessa esperienza del grounding, mi odiò profondamente perché, disse, gli volevo “far riprovare quella insopportabile sensazione”.
Mentre mi diceva questo e sentivo profondamente il suo disagio e la sua rabbia, dovetti inevitabilmente confrontarmi anche con me stesso e con le sensazioni che si producevano in me, sia nel sentirmi oggetto di quelle emozioni così intense, sia nel ricordare bene come molti anni prima durante la mia formazione, e anche nella mia analisi personale, avevo a volte sperimentato sensazioni simili in un modo abbastanza penoso.
Anche per queste consapevolezze decisi di procedere con molta cautela senza forzare il processo, dando anche a me stesso il tempo di percepire e integrare più profondamente le sensazioni che questo suo intenso vissuto mi aveva evocato.
Penso che questa scelta, insieme alla considerazione fatta insieme che forse ciò che stava provando non era poi così distante e scollegato da ciò che aveva vissuto nella conferenza gli fecero, nelle successive sedute, trovare una motivazione e coraggio sufficienti per risperimentarsi in questo tipo di esposizione.
Penso poi che anche per questo potè successivamente svilupparsi un processo in cui iniziò a rendersi progressivamente conto che il giudice identificato in me era innanzitutto un suo giudice interno, e questo gli permise di distogliere progressivamente l’attenzione da me per spostarla sui suoi oggetti interni.
Fu proprio in questo processo che a un certo punto egli potè nominare la vergogna ricordando di essersi “anche sempre sentito indegno e impresentabile”.
Questo aprì progressivamente le porte ad altre memorie, e in particolare a queste, riguardanti il padre, emerse nel corso di alcune sedute dopo circa due anni che ci vedevamo:
“Sicuramente mio padre mi ha sempre voluto molto bene ed anche io gliene ho sempre voluto… Ho chiaramente impresse alcune immagini in cui ero piuttosto piccolo, direi tre-quattro anni, dove ho particolarmente in mente i suoi occhi brillanti che mi guardavano pieni di affetto nel rivedermi di ritorno dal lavoro …..”. ”I suoi occhi erano per me sempre molto importanti … i suoi sguardi li cercavo tutte le volte che potevo perché mi dicevano se andavo bene…” . Nel contesto di queste sedute, dove il tema degli sguardi, anche in generale, era piuttosto ricorrente, portò questo episodio: “Domenica scorsa sono andato a casa di mio cugino dove, dopo cena, abbiamo rivisto alcuni vecchi filmini girati da sua madre, tra cui uno, in occasione di un pranzo di Natale, quando avevo quasi cinque anni. Nella nostra famiglia in quelle circostanze, dopo il pranzo e prima di aprire i regali, c’era l’abitudine di far recitare, a me e ai miei tre cugini più piccoli, le tipiche filastrocche natalizie. Nel film, quando arriva il mio turno, si vede mio padre che mi prende in braccio e mi mette in piedi sulla cassapanca da cui recitavamo: io inizio con una certa foga la mia filastrocca ma a un certo punto faccio uno sbaglio e mi confondo: provo a riprendere ma sbaglio ancora. A quel punto si vede che, nel giro di pochi secondi, inizio a cambiare espressione e poi a piangere in maniera disperata e, prima che la scena si interrompa, si vedono per un attimo le braccia di mio padre che mi riprendono per togliermi da lì”.
Di quell’episodio specifico M. seguitava a non ricordare assolutamente nulla neanche dopo averlo rivisto nel filmato.
L’essersi riguardato in quei vecchi fotogrammi, e in particolare nel passaggio dalla foga della recita al pianto disperato dopo l’errore, gli fece però progressivamente tornare in mente alcuni ricordi che avevano a che fare con i vissuti dei suoi genitori, e di suo padre in particolare, quando commetteva degli errori, facendogli presumere che anche in quella occasione natalizia potesse esser successo qualcosa del genere.
In particolare iniziò a recuperare e a ricostruire la memoria di come egli era manifestamene orgoglioso tutte le volte che otteneva un successo, ad esempio a scuola con dei bei voti, e come questo sentimento gli si poteva leggere innanzitutto negli occhi, che a volte diventavano brillanti quasi al limite della commozione. Succedeva però che quando qualcosa non andava per il verso giusto, “e non ci voleva poi tanto..” precisò, diventava improvvisamente rigido e quegli occhi si trasformavano, ben più efficacemente di qualunque giudizio pronunciato con le parole, in “delle specie di lame affilate ..” che lo costringevano ad abbassare lo sguardo facendolo entrare in uno stato di implosione dove, potè a un certo punto riconoscere, c’era soprattutto tantissima vergogna.
In quella fase dell’analisi il suo interesse e curiosità crescenti per questa emozione, inabissatasi per lunghi anni dalla sua coscienza ma che sempre più riconosceva appartenergli, lo spinse a cercare di colmare i vuoti della sua memoria andando anche a rivedere alcuni album di vecchie foto conservate dai genitori.
Una mattina arrivò in seduta dicendo di aver scoperto una cosa importante proprio attraverso questi album e in particolare in uno dove c’erano una serie di foto scattate dal padre in occasione delle recite scolastiche che venivano organizzate alla fine di ogni anno prima delle vacanze estive.
La sequenza di queste foto si interrompeva però bruscamente in occasione dello spettacolo a cui aveva partecipato alla fine della terza elementare; ne aveva chiesto ai genitori il perché e gli fu detto che “la recita della terza non era andata bene”, perché sul palco a un certo punto si era talmente emozionato da non riuscire a portare a termine la sua parte: aggiunsero che negli anni successivi si era poi sempre categoricamente rifiutato di partecipare ad esibizioni di quel tipo, nonostante ci fossero state molte insistenze sia da parte loro che di diversi insegnanti.
Anche dopo questo chiaro e inequivocabile racconto M. riuscì comunque a recuperare solo vaghi ricordi rispetto a quell’esperienza, e fu proprio lui a imputare questo vuoto al fatto che doveva esser stata “talmente brutta …. e posso immaginare come la deve aver vissuta mio padre…. che potevo solo cancellarla”.
Questo persistente vuoto di memoria non impedì comunque lo svilupparsi di un processo di consapevolezza complessiva di se stesso dove progressivamente si ricongiunsero, in un significato anche emotivamente coerente, diversi vissuti che erano rimasti ai margini, o totalmente esclusi, dalla sua coscienza.
L’essersi reso conto, ad esempio, che nel rapporto con suo padre soprattutto attraverso i suoi sguardi estremamente amorevoli o all’opposto improvvisamente rifiutanti, aveva sperimentato una condizione dove “…molte volte mi sentivo sulle stelle, così come altre mi sentivo totalmente annientato”, lo rese anche consapevole del fatto che in presenza di sguardi accettanti come i miei in analisi, o anche di sguardi in cui traspariva un elevato livello di aspettativa, come nel caso del suo direttore commerciale, si poteva all’improvviso innescare uno stato di più o meno profondo disagio nella misura in cui veniva inconsciamente attivata l’associazione con le originarie esperienze, dove il processo di apertura indotto da figure per lui significative poteva essere il preludio per un grande senso di umiliazione e profonda vergogna.
Questa ed altre acquisizioni integrate sul piano della coscienza non servirono comunque, almeno fino a quando ci incontrammo, a far diventare M. il brillante oratore che una parte di lui aveva idealmente pensato di poter essere: servirono invece, ad esempio, a renderlo più consapevole dei suoi limiti e quindi molto più cauto anche nei suoi interventi in pubblico, dove potè accettare, senza sentirsi sconfitto e umiliato nella sua immagine pubblica, di leggere su un foglio invece di fare solo affidamento sulla sua memoria e sulle sue capacità di improvvisazione.
Ma soprattutto, più in generale, queste consapevolezze gli consentirono di governare e regolare meglio i propri stati di vergogna in un processo che lui stesso una volta, con soddisfazione, definì “la capacità di smascherare la mia stessa vergogna”.
Conclusioni
Quando si parla genericamente di vergogna in realtà ci si riferisce ad una famiglia di emozioni (Nathanson, 1987) per le numerose forme che essa può assumere, così come ce ne parlano numerosi sentimenti che possono affacciarsi sulla soglia della coscienza, tra cui in particolare quello del sentirsi ridicoli: in ogni caso si tratta di una dimensione mai comoda da trattare in analisi ed è forse anche per questo che ad essa, come più volte sottolineato, si tendono a preferire altri registri interpretativi.
D’altro canto l’importanza di restituirgli un ruolo centrale, oltre che per quanto già detto, è innanzitutto funzione dell’assunto, qui pienamente condiviso, in base al quale “è la vergogna a guidarci alla depressione o al comportamento antisociale. Le nostre lotte interiori non sono scontri fra gli istinti e la realtà, ma conflitti che tipicamente ci vedono alle prese con la vergogna, i suoi fattori scatenanti e la frequenza con la quale ci colpisce” (Lewis, op. cit., p. 6).
Le implicazioni di questa assunzione sono numerose proprio per un modello a matrice psicocorporea come è quello dell’Analisi Bioenergetica, innanzitutto per lo stretto intreccio che unisce il tema vergogna con quello del corpo.
In proposito, visto l’osservatorio privilegiato che questo metodo ci ha sempre offerto, viene da chiedersi come mai, nonostante ciò, a questa emozione sia stata finora dedicata così poca attenzione, sia in termini di riflessione teorica che nella nostra prassi clinica: sembrerebbe infatti che essa, coerentemente del resto con una delle sue peculiarità, anche in questo caso si sia inabissata da qualche parte per rimanere accuratamente lontana dalle nostre coscienze. Ma è evidente che in questo modo essa ha sicuramente seguitato ad operare in maniera ancora più incisiva, proprio a seguito di questo processo di parziale o totale rimozione.
Questa constatazione apre ovviamente numerose importanti questioni che possono innanzitutto servire ad alimentare un proficuo dibattito su questo tema, sia di carattere generale che specificamente all’interno del modello e metodo dell’Analisi Bioenergetica.
In questo contesto si può per ora solo sottolineare, ritornando al caso di M. da cui queste pagine hanno preso lo spunto, che il risultato raggiunto in cui egli si sentì soggetto attivo in grado di smascherare la sua stessa vergogna si potè ottenere anche perché, nella nostra relazione a volte con grande fatica, ci potemmo consentire di mantenere il sentimento del ridicolo in un posto di primo piano.
Bibliografia
Anolli L., La vergogna, Il Mulino, Bologna, 2000
Battacchi M.W., Vergogna e senso di colpa. In psicologia e nella letteratura, Raffaello Cortina, Milano, 2002
Castelfranchi C., Che figura. Emozioni e immagine sociale, Il Mulino, Bologna, 1998
Damasio, A. (1994), L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello, Trad. it. Adelphi, Milano, 1995
Damasio, A. (1999), Emozioni e coscienza, Trad. it. Adelphi, Milano, 2000
Damasio, A. (2003), Alla ricerca di Spinoza, Trad. it. Adelphi, Milano, 2003
Darwin, C. (1872), L’espressione delle emozioni nell’uomo e negli animali, Trad. it. Boringhieri, Torino 1962
James W. (1890), Principi di psicologia, Trad. it. Principato, Milano, 1978
Kaiser R.G.K. (1999), Il crollo del sé e la sua ricostruzione in terapia, Trad. it. Astrolabio, Roma, 2000
Kohut H. (1971), Narcisismo e analisi del sé, Trad. it. Boringhieri, Torino, 1976
Kohut H. (1985), Potere, coraggio e narcisismo, a cura di Stozier C. B., Trad. it. Astrolabio, Roma, 1986
Lavelli M., Intersoggettività: origini e primi sviluppi, Raffaello Cortina, Milano, 2007
Lewis M.(1992), Il sé a nudo, Trad. it. Giunti, Firenze, 1995
Lowen, A. (1956), Il linguaggio del corpo , Trad. it. Feltrinelli, Milano, 1978
Lowen, A. (1975), Bioenergetica , Trad. it. Feltrinelli, Milano, 1983
Lowen, A. (1970), Il piacere, Trad. it. Astrolabio, Roma, 1984
Lowen, A. (1982), Il narcisismo , Trad. it. Feltrinelli, Milano, 1985
Matarazzo O., Antecedenti situazionali di Vergogna, Imbarazzo e Senso di colpa, in M. Sbandi (a cura di), Memoria e narrazione, Idelson Gnocchi, Napoli, 1999
Merleau-Ponty M. (1964), Il visibile e l’invisibile, Trad. it. Bompiani, Milano, 1993
Orange D.M., Atwood G.E., Stolorow R.D. (1997), Intersoggettività e lavoro clinico , Trad. it. Raffaello Cortina, Milano, 1999
Reich, W. (1933), Analisi del carattere, Trad. it. Ed. Sugarco Milano, 1973
Ruggieri, V., L’ identità in psicologia e teatro. Analisi psicofisiologica della struttura dell’io, Ed. Ma. Gi., 2001
Sartre J.P. (1943), L’essere e il nulla, Trad. it. Il Saggiatore, Milano, 1984
Schore A. N. (2003), La regolazione degli affetti e la riparazione del sè, Trad. it. Astrolabio, Milano, 2008
Siegel D. J. (1999), La mente relazionale, Trad. it. Raffaello Cortina, Milano, 2001
Siegel D. J. (2007), Mindfullness e cervello, Trad. it. Raffaello Cortina, Milano, 2009
Trevarthen, C. (1998), The concept and foundations of infant intersubjectivity. In Braten, S. (a cura di), Intersubjective Communication and Emotion in Early Ontogeny. Cambridge University Press, Cambridge, UK, pp. 15-46
(*) Psicologo, psicoterapeuta