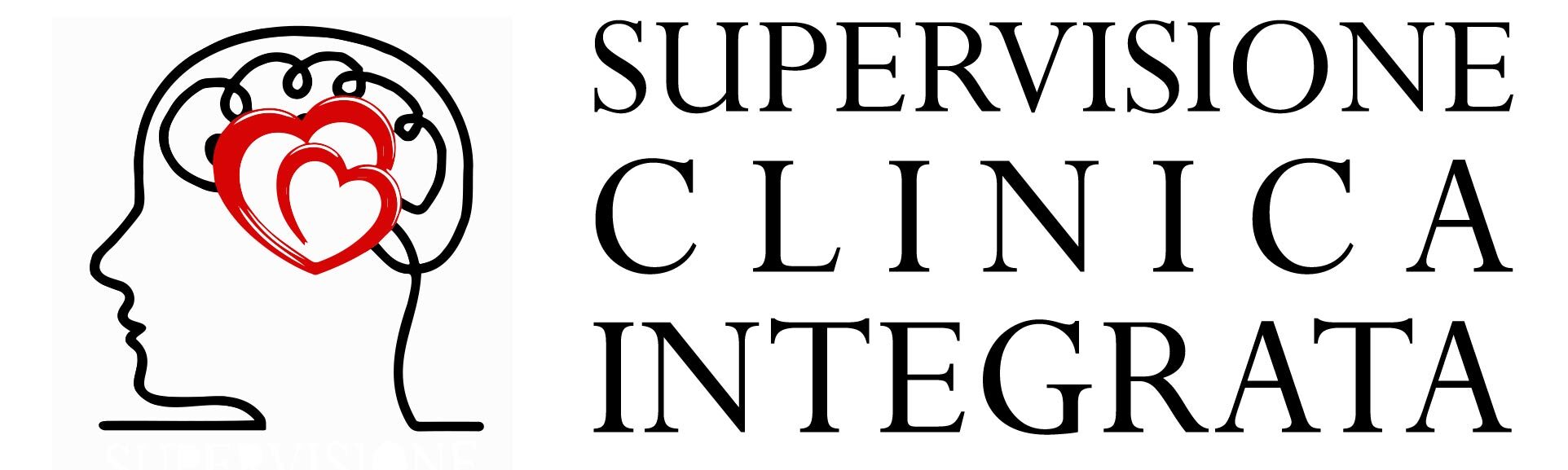Il terzo nella coppia: legami, intimità e psicodinamica della relazione
Abstract
L’articolo esplora la complessità delle relazioni di coppia, evidenziando l’importanza del “terzo” come elemento sempre presente e influente, che può essere una persona, un simbolo, un valore o persino un sintomo fisico o emotivo. Il terzo può sia rafforzare l’intimità sia diventare fonte di instabilità.
Il lavoro terapeutico si concentra sull’integrazione del terzo nel legame, aiutando i partner a muoversi lungo il continuum penso-sento, ovvero tra riflessione cognitiva e sentire emotivo e corporeo. L’obiettivo è trasformare il terzo da fattore destabilizzante a risorsa evolutiva, favorendo una connessione più profonda tra mente e corpo, e una maggiore consapevolezza delle dinamiche relazionali implicite.
(*) Violante Veronesi, Manuela La Neve
Introduzione: La coppia non è mai un’isola
La coppia non esiste mai come entità isolata. È sempre immersa in un tessuto di influenze interne ed esterne che ne modellano la forma, la funzione e il destino.
La dimensione del terzo attraversa il legame amoroso sin dalla sua costituzione: la coppia nasce in un campo di forze, in un’interazione continua tra il bisogno di fusione e il desiderio di individuazione (Mitchell, 2002). Questi due poli si alimentano reciprocamente e si regolano in relazione a un esterno che funge da punto di riferimento, regolazione o contrasto. In alcuni casi, il terzo è un elemento necessario alla coesione e alla continuità del rapporto; in altri, è il sintomo di un equilibrio che non regge, di un’incapacità di sostenere la tensione intima senza l’intervento di un mediatore interno o esterno.
La psicodinamica delle relazioni ha da sempre evidenziato come la diade amorosa sia attraversata da un “terzo” che ne influenza la stabilità e l’evoluzione (Kernberg, 1995; Mitchell, 2002). Questo terzo può essere rappresentato da una persona reale (figli, ex-partner, genitori, amanti), ma anche da elementi meno tangibili, come fantasmi relazionali, ruoli imposti, modelli transgenerazionali e norme culturali interiorizzate (Minuchin, 1974; Eiguer, 2014).
Quando parliamo di “terzo”, non facciamo riferimento esclusivamente a un’altra persona che entra nella dinamica relazionale. Questo “terzo allargato” può fungere da collante per la relazione o, al contrario, trasformarsi in un agente perturbatore che favorisce la distanza, la rottura, o l’implosione della coppia.
Il terzo può svolgere sia una funzione regolatrice, che stimola la crescita e la differenziazione dei partner, sia una funzione perturbatrice, che amplifica la distanza e il conflitto. La sua presenza può essere fonte di sicurezza e contenimento o, al contrario, innescare dinamiche di esclusione e gelosia. Questo articolo esplora la natura del terzo nella coppia, il suo impatto sulla relazione e le possibili strategie terapeutiche per integrare questa dimensione in modo costruttivo.
Nella coppia, la relazione stessa concide con il terzo: due persone si incontrano e creano uno spazio che contiene il modello inconscio dell’amore e si fonde all’apice nella relazione. La coppia nel modello psicoanalitico è considerata attraverso la metafora del tandem: non è solo necessario saper andare in bici ma richiede sintonizzazione, logica di fondo casualità circolare, identificazioni proiettive incrociate e influenza reciproca. Quando questo viene a mancare l’agito domina la relazione, lo spazio della relazione e della mentalizzazione viene a mancare e il terzo, la relazione decade. La coppia viene immersa in una modalità di causalità lineare che porta alla colpevolizzazione dell’altro.
Attraverso la lente biodinamica, che si muove lungo il continuum “penso-sento”, esploreremo come il terzo si manifesti nella coppia e quali siano i suoi effetti sulle dinamiche relazionali, sulle emozioni condivise e sul corpo. Il modello biodinamico considera l’esperienza della coppia come un organismo in movimento, in cui il corpo, le sensazioni e le memorie somatiche raccontano la storia relazionale tanto quanto le parole.
Analizzeremo insieme quindi come il terzo si incarna anche nel corpo e nella postura, nei blocchi muscolari e nelle risonanze emotive. Infine, esploreremo le possibilità di intervento terapeutico per integrare il terzo senza che diventi una frattura.
L’incastro di coppia: tra ripetizione e trasformazione
Ogni coppia si forma attraverso un incastro relazionale, una danza sottile di bisogni consci e inconsci, schemi di attaccamento e memorie emotive (Bowlby, 1988). Questo incastro non è mai casuale, ma riflette un intreccio profondo di aspettative, vulnerabilità e desideri che ciascun partner porta nella relazione. In molti casi, le relazioni amorose riproducono modelli relazionali interiorizzati nelle prime esperienze di attaccamento, determinando il modo in cui si sperimenta l’intimità, il conflitto e la dipendenza emotiva.
In questo senso, il partner è considerato come il portatore e proiezione del proprio mondo interno e la coppia come incastro di duemondi interni, al’interno della quale vengono ripetuti esperienze e vissuti antichi (Dicks, 1949)
L’incastro può essere evolutivo o regressivo. Nel primo caso, la relazione diventa un luogo di crescita, dove i partner riescono a negoziare i propri bisogni, integrare le reciproche differenze e costruire un legame flessibile. Quando, invece, l’incastro è rigido e inconsapevole, la coppia può cadere nella ripetizione di schemi disfunzionali, con dinamiche che sembrano riproporsi ciclicamente, senza soluzione. Questa ripetizione può manifestarsi in diversi modi:
- Attaccamento insicuro e paura dell’abbandono: uno o entrambi i partner possono cercare conferme continue o, al contrario, mantenere una distanza emotiva per paura di soffrire (Ainsworth et al., 1978).
- Ruoli fissi e asimmetrie relazionali: uno dei partner può assumere costantemente il ruolo del “salvatore” e l’altro del “bisognoso”, creando una dipendenza affettiva che ostacola l’
- Cicli di conflitto e riappacificazione: litigi ripetuti seguiti da riavvicinamenti intensi, spesso caratterizzati da dinamiche di amore/odio, tipiche delle coppie con forti oscillazioni emotive.
La possibilità di trasformazione dell’incastro dipende dalla capacità della coppia di rendere conscio ciò che è implicito, riconoscendo i pattern ripetitivi e comprendendone l’origine. Quando l’incastro si trasforma, la coppia può passare da una relazione basata sulla coazione a ripetere a una relazione più autentica, in cui il legame non è più governato da bisogni inconsci irrisolti, ma da una scelta consapevole di stare insieme.
La necessità del terzo: una prospettiva psicoanalitica e sistemica
Dal punto di vista psicoanalitico, la relazione di coppia si sviluppa all’interno di un continuum tra bisogno di fusione e desiderio di individuazione (Mitchell, 2002). In questa dialettica, il terzo può rappresentare una minaccia alla simbiosi originaria o una risorsa per differenziarsi e crescere.
La psicoanalisi ha spesso esplorato la presenza di fantasmi relazionali all’interno della coppia: ex-partner idealizzati, genitori interiorizzati, aspettative inconsce che proiettano nel legame attuale dinamiche non risolte del passato. Questi elementi possono influenzare il desiderio, il livello di sicurezza emotiva e la qualità della comunicazione nella coppia.
Nella prospettiva sistemica (Minuchin, 1974), il terzo è parte integrante della struttura familiare. La famiglia nucleare si regge su un equilibrio triadico, e quando ad esempio, i confini tra le funzioni dei partner e dei figli non sono chiari, possono emergere triangolazioni disfunzionali. In questi casi, il terzo può assumere il ruolo di alleato di un partner contro l’altro, o fungere da regolatore implicito del conflitto.
Una coppia in terapia riferiva conflitti ricorrenti legati al bisogno di controllo di uno dei partner. L’altro reagiva con chiusura emotiva. Le radici di questa dinamica risalivano all’infanzia: il primo partner aveva sviluppato una tendenza al controllo in risposta a un ambiente familiare caotico, mentre il secondo, cresciuto in un contesto rigido, evitava il confronto diretto. In questo caso, il “terzo” era rappresentato dal passato non elaborato, che interferiva con la relazione presente.
La terapia ha aiutato la coppia a riconoscere e rielaborare questi schemi, promuovendo una nuova narrazione condivisa che ha consentito un cambiamento reale nella dinamica relazionale.
Il terzo nella coppia: tra legame e separazione
La presenza del terzo è insita nella struttura stessa del legame amoroso. Ogni relazione si forma a partire da una matrice interpersonale e da un’eredità affettiva che accompagna i partner nel loro incontro. Questo significa che la coppia non è mai una somma di due individualità, ma il risultato di un’intersezione di storie, aspettative e desideri. Il terzo può emergere come:
- Persona concreta: un figlio, un ex-partner, un amante, un genitore ancora interiormente presente.
- Simbolo o valore: un ideale di coppia, un modello culturale, un mandato familiare che impone regole implicite.
- Sintomo psicosomatico: un disturbo somatico o emotivo che diventa il baricentro della relazione, legando i partner in una dinamica di cura, bisogno o dipendenza.
- Collante patologico: la proiezione di conflitti irrisolti su un elemento esterno che permette di evitare il confronto diretto tra i partner.
Quando il terzo agisce come regolatore implicito della coppia, può assumere una funzione stabilizzante o destabilizzante. Un figlio, ad esempio, può rafforzare il legame genitoriale e ridurre il conflitto coniugale, oppure può diventare un catalizzatore di tensioni e frustrazioni irrisolte.
Le molteplici forme del terzo nella coppia
Alcune delle espressioni più comuni del terzo nella coppia includono:
- Il figlio come terzo regolatore: spesso, con la nascita di un figlio, la coppia si riorganizza intorno alla funzione genitoriale. Se questa transizione non è gestita in modo equilibrato, il bambino può diventare il collante della relazione o un fattore di distanza tra i partner.
- L’ex-partner e i fantasmi relazionali: le relazioni passate possono continuare a esercitare un’influenza sulla coppia attuale, sia attraverso il confronto con il passato che tramite il timore del confronto con modelli idealizzati.
- Il terzo simbolico: elementi come il lavoro, la famiglia d’origine, la religione, o un hobby possono rappresentare un “terzo” che assorbe energie e tempo, creando un divario emotivo tra i partner.
- Il terzo intrusivo: in alcune situazioni, la presenza di un amante o di un interesse romantico esterno può generare tensioni e rotture, mettendo in discussione la solidità della coppia (Eiguer, 2014).
Secondo Eiguer (2014), il terzo può essere intrusivo (destabilizzante) o strutturante (favorisce la crescita). Questa presenza può manifestarsi sotto forma di:
- Persone esterne (figli, ex partner, amanti, genitori invadenti);
- Dinamiche inconsce (paure, desideri inespressi, aspettative culturali);
- Sintomi psicosomatici (disfunzioni sessuali, ansia, depressione);
- Aspettative e ruoli cristallizzati (rigidità nella divisione dei compiti e delle responsabilità).
In terapia, l’emersione del terzo aiuta a comprendere il funzionamento della coppia e a trasformare i conflitti in opportunità di crescita.
La collusione nella coppia e il ruolo del terzo
Secondo la teoria della collusione di Jürg Willi (1983), i partner sviluppano un incastro inconscio che si basa su bisogni complementari e difese speculari. Ogni coppia si fonda su una dinamica di equilibrio tra parti opposte che si attraggono e si regolano a vicenda: ad esempio, un partner con una struttura più controllante può attrarre qualcuno che tende alla dipendenza, così come una persona con un profondo bisogno di accudire può legarsi a qualcuno che cerca protezione e sostegno.
L’equilibrio collusivo è fragile e spesso instabile, poiché si basa su una negoziazione inconscia delle proprie mancanze emotive. Quando il terzo entra in scena, può fungere da elemento rivelatore di questa collusione:
- Può destabilizzare la coppia, rendendo evidenti le sue rigidità e le sue difficoltà ad adattarsi a cambiamenti. Ad esempio, la nascita di un figlio può far emergere conflitti latenti, perché il nuovo assetto rompe gli equilibri precedenti.
- Può rafforzare la coppia, permettendo di ridefinire i ruoli e di integrare nuovi aspetti della relazione. Un terzo positivo è quello che stimola una maggiore consapevolezza e una trasformazione del legame.
- Può essere un sintomo della relazione stessa, cioè non una causa esterna, ma il riflesso di qualcosa di già presente nella dinamica della coppia. Ad esempio, un tradimento può non essere il problema principale, ma il segnale di un malessere più profondo nel legame.
Intimità, collusione e difese relazionali
L’intimità di coppia è spesso percepita come il luogo della vicinanza emotiva, della condivisione autentica e della sicurezza affettiva. Tuttavia, essa è anche il campo in cui emergono le fragilità individuali, le paure più profonde e i conflitti irrisolti. L’accesso all’altro implica una messa a nudo non solo emotiva, ma anche psicocorporea: la possibilità di essere visti, riconosciuti e accolti è sempre accompagnata dal rischio di essere rifiutati, invasi o traditi.
In questa dialettica tra desiderio e paura, il terzo può assumere un ruolo difensivo, fungendo da protezione contro un’eccessiva esposizione affettiva. La sua funzione è quella di creare una distanza di sicurezza che impedisca alla relazione di diventare troppo soffocante o, al contrario, troppo minacciosa. Il terzo può essere una persona reale – un amante, un figlio, un genitore interiorizzato – oppure un elemento simbolico come un impegno lavorativo, un’ideologia o perfino una dipendenza.
Difese relazionali e distanza emotiva
L’ingresso del terzo può essere visto anche come un tentativo difensivo di protezione da un’intimità, percepita come pericolosa. Spesso, infatti, le coppie utilizzano meccanismi inconsci per mantenere una certa distanza e prevenire il rischio di fusione o perdita di autonomia. Alcune delle difese più comuni sono:
- Il triangolo relazionale: invece di affrontare direttamente i conflitti, uno dei partner coinvolge una terza persona (un ex-partner, un amico intimo, un collega di lavoro) come strumento per riequilibrare il legame e ridurre la tensione.
- L’investimento su un elemento esterno: il lavoro, la famiglia d’origine, una causa ideale o un hobby possono diventare delle “vie di fuga” per evitare di confrontarsi con le difficoltà interne alla relazione.
- La somatizzazione: quando l’ansia relazionale non viene elaborata a livello emotivo, può manifestarsi nel corpo sotto forma di disturbi psicosomatici, tensioni muscolari, disfunzioni sessuali o sintomi di stress cronico.
Il corpo come luogo dell’intimità e della distanza
Nel modello biodinamico, che integra la dimensione psicocorporea nel trattamento delle relazioni, si osserva che il terzo non è solo una presenza psicologica, ma anche una realtà incarnata nel corpo dei partner. Il modo in cui una coppia gestisce la propria intimità si riflette nel linguaggio corporeo:
- L’eccessiva rigidità posturale o la mancanza di contatto fisico possono indicare una difficoltà a vivere la vicinanza.
- Il respiro corto e frammentato può segnalare una paura inconscia della dipendenza o della perdita del controllo.
- L’asimmetria nella postura di coppia (ad esempio, uno dei due partner tende a sporgersi verso l’altro, mentre l’altro si ritrae) può rivelare dinamiche di potere e sbilanciamento nella relazione.
Il lavoro terapeutico su questi aspetti aiuta a rendere consapevoli le modalità con cui il terzo si manifesta nella coppia e permette di trasformare i meccanismi di difesa in nuove possibilità di connessione.
Il corpo come linguaggio relazionale
Il legame di coppia non si esprime soltanto attraverso il dialogo e le interazioni esplicite, ma anche tramite livelli di comunicazione sotterranei, fatti di gesti, posture, micro-espressioni e stati fisiologici condivisi. Il corpo diventa il primo e più autentico mediatore di questa dimensione implicita della relazione: la posizione reciproca nello spazio, il modo in cui i partner si toccano o evitano il contatto, la sincronia (o asincronia) nel ritmo del respiro, la qualità della voce e dell’espressione facciale.
Questi segnali non verbali non sono semplici dettagli accessori, ma veri e propri codici relazionali che raccontano la storia emotiva della coppia. Essi rivelano come i partner si sentano l’uno nei confronti dell’altro e quale sia il livello di sicurezza, distanza o tensione presente nella relazione.
Il terzo nella coppia e le dinamiche corporee
Quando un terzo si introduce nel legame, il suo impatto non è solo cognitivo o emotivo, ma anche profondamente somatico. L’insicurezza, la gelosia, la paura della perdita, o al contrario, l’espansione e l’integrazione di nuovi elementi nella relazione, si traducono in segnali corporei immediati.
Alcuni esempi:
Chiusura posturale e rigidità muscolare → Segnala una difficoltà a tollerare il cambiamento, una difesa inconscia contro l’insicurezza.
Respiro frammentato o trattenuto → Può indicare ansia, paura del rifiuto o difficoltà a esprimere ciò che si prova verbalmente.
Sguardo evitante → L’incapacità di sostenere il contatto visivo può rivelare vergogna, senso di colpa o il timore di essere esposti in una vulnerabilità troppo grande.
Movimento espansivo e rilassato → Se il terzo è integrato armonicamente nella dinamica di coppia (ad esempio, nel caso di un figlio desiderato o di un cambiamento accettato), il corpo rifletterà apertura e maggiore fluidità nei gesti.
La memoria somatica della relazione
Le relazioni di coppia non si sviluppano nel vuoto, ma sono intrise di memorie corporee che derivano dalle esperienze passate di attaccamento e intimità. Queste tracce somatiche si manifestano attraverso schemi relazionali impliciti, che determinano la capacità di fidarsi, di lasciarsi andare o di mantenere il controllo nella relazione.
Un esempio clinico di questa memoria somatica può essere osservato nei casi di persone che hanno vissuto relazioni precedenti caratterizzate da tradimenti o abbandoni: anche senza un motivo apparente, il loro corpo può reagire in modo ipervigilante nella nuova relazione, con tensioni involontarie, contrazione del diaframma o difficoltà a rilassarsi nel contatto fisico con il partner.
Allo stesso modo, una coppia che ha attraversato un evento traumatico congiunto (una perdita, una crisi) può sviluppare una sincronizzazione corporea in cui il dolore è tacitamente condiviso, attraverso posture ricurve, muscoli contratti e un ritmo respiratorio rallentato.
La lettura biodinamica: il continuum “penso-sento” nella coppia
Nel modello biodinamico, l’analisi delle dinamiche di coppia avviene lungo il continuum penso-sento, ossia un asse che integra la dimensione cognitiva e psicodinamica (i pensieri, le narrative e i significati attribuiti alla relazione) con la dimensione corporea (le emozioni, le sensazioni e le memorie somatiche).
Quando un terzo entra in gioco nella relazione, è possibile osservare come i partner si muovano lungo questo continuum:
Se prevale il penso, la coppia tende a razionalizzare e analizzare la situazione, ma può risultare scollegata dal proprio sentire corporeo e dalle emozioni più profonde.
Se prevale il sento, le reazioni possono essere molto intense e viscerali, ma senza un’elaborazione che permetta di dare loro un significato e trasformarle in opportunità di crescita.
L’intervento terapeutico, in questa prospettiva, mira a riequilibrare questi due poli, aiutando la coppia a riconnettersi sia a livello emotivo che corporeo per integrare il terzo senza che diventi un elemento di frattura o alienazione.
L’approccio biodinamico consente di decifrare questi segnali impliciti e di lavorare sulla connessione mente-corpo, affinché la coppia possa trasformare la presenza del terzo da minaccia inconscia a risorsa evolutiva.
Il terzo nella prospettiva psicocorporea
Nella prospettiva della psicoterapia corporea, il terzo nella coppia non è solo una presenza simbolica o relazionale, ma si manifesta direttamente nel corpo dei partner. Il modo in cui due persone si avvicinano, si toccano, si sottraggono al contatto o si irrigidiscono di fronte all’intimità rivela molto più di ciò che viene espresso verbalmente.
Lowen (1975) ha descritto come il corpo registri tensioni e conflitti relazionali attraverso schemi posturali, blocchi muscolari e pattern respiratori alterati. Queste manifestazioni somatiche non sono solo espressioni momentanee di disagio, ma veri e propri depositi di esperienze emotive e relazionali vissute nel corso della vita. Il terzo nella coppia, quindi, può essere “incarnato” in posture di chiusura, in un respiro trattenuto, in tensioni muscolari croniche che esprimono un conflitto non risolto.
Il corpo come teatro della relazione
Nel legame di coppia, i partner comunicano costantemente attraverso il linguaggio del corpo. Quando un terzo si introduce nella dinamica – sia esso un’altra persona, un’aspettativa inconscia o un vissuto relazionale pregresso – il corpo reagisce, registrando questa presenza attraverso cambiamenti sottili ma significativi. Alcuni esempi clinici mostrano come queste dinamiche si esprimano:
- Evitamento del contatto visivo e rigidità posturale → Indicano spesso una difficoltà a tollerare la vicinanza emotiva, segnalando la presenza di un conflitto non elaborato.
- Blocchi nella respirazione → Il respiro trattenuto o irregolare può riflettere paura della vulnerabilità, ansia o un vissuto di esclusione nella relazione.
- Disallineamento nei movimenti reciproci → Se i partner non riescono a sintonizzarsi nei gesti o nei ritmi corporei, questo può rivelare una difficoltà a creare uno spazio relazionale condiviso.
Una coppia in terapia riportava difficoltà di intimità e una distanza crescente tra i partner. Nonostante il desiderio di avvicinarsi, ogni tentativo di contatto emotivo sembrava generare tensione e frustrazione. Attraverso il lavoro corporeo sulla sincronizzazione del respiro e il contatto visivo, è emerso un vissuto di esclusione emotiva legato alla presenza simbolica di un ex-partner, mai completamente elaborato dalla relazione.
Il corpo dei due partner raccontava questa storia di evitamento in modi diversi:
- La moglie assumeva una postura chiusa, con le spalle leggermente incurvate in avanti, segno di una difesa emotiva e di un vissuto di protezione dal dolore passato.
- Il marito presentava una rigidità nel petto e nel diaframma, trattenendo inconsapevolmente il respiro in un atteggiamento di contenimento emotivo.
Attraverso esercizi di respiro guidato e movimenti dolci di riavvicinamento corporeo, i partner hanno iniziato a riconoscere la presenza implicita del terzo e a trasformare il loro modo di stare insieme, passando da una condizione di distanza a una possibilità di nuova connessione e integrazione.
Lavorare sulla dimensione psicocorporea permette di dare voce alle tensioni relazionali in modo immediato e profondo, favorendo l’accesso a quelle dinamiche implicite che spesso restano fuori dalla consapevolezza cosciente.
Strategie terapeutiche per integrare il terzo
Riconoscere il terzo: Il primo passo è identificare la presenza del terzo, che sia una persona, un ideale o una dinamica ripetitiva. Questo processo permette ai partner di dare un nome e un senso alla tensione relazionale.
Ridefinire i confini: Lavorare sulla differenziazione tra coppia e altri elementi esterni, ridefinendo ruoli e spazi per evitare triangolazioni disfunzionali.
Lavoro sul corpo e sulle emozioni: Tecniche di respirazione, esercizi di contatto e ascolto corporeo possono aiutare i partner a esplorare il proprio vissuto emotivo in relazione alla presenza del terzo.
Sviluppo della comunicazione autentica: Favorire un dialogo aperto e non difensivo, in cui i partner possano esprimere bisogni, paure e desideri, senza sentirsi minacciati dalla presenza del terzo.
Strategie terapeutiche per integrare il terzo nella coppia
La terapia di coppia può offrire uno spazio sicuro per riconoscere e integrare la presenza del terzo in modo funzionale, trasformandolo da elemento perturbante a opportunità di crescita e ridefinizione del legame. L’approccio terapeutico deve tenere conto sia delle dimensioni psicodinamiche che di quelle corporee, lavorando su più livelli contemporaneamente.
Alcune strategie chiave includono:
- Analisi delle proiezioni e delle aspettative
Ogni partner porta nella relazione modelli relazionali interiorizzati, spesso inconsapevoli, che influenzano la percezione del terzo. Esplorare queste dinamiche aiuta a comprendere il ruolo del passato nella costruzione delle interazioni presenti e a distinguere i conflitti attuali da quelli ereditati.
- Lavoro sulle emozioni corporee e sulle tensioni somatiche
La dimensione corporea è fondamentale nella regolazione emotiva della coppia. Tecniche di consapevolezza corporea, come il lavoro sul respiro, il rilassamento delle tensioni muscolari e la sincronizzazione dei movimenti, possono favorire un’elaborazione profonda delle dinamiche relazionali, permettendo ai partner di accedere a vissuti spesso inespressi verbalmente.
- Rinegoziazione dei confini e dei ruoli
Le coppie spesso funzionano su accordi impliciti che determinano la distribuzione di ruoli e spazi. Quando il terzo entra nella dinamica, questi equilibri possono essere messi in crisi. La terapia aiuta a portare alla luce questi accordi, rinegoziando confini più flessibili che permettano a entrambi i partner di mantenere un senso di identità individuale e di connessione reciproca.
L’integrazione di queste strategie consente alla coppia di trasformare il terzo da elemento destabilizzante a fattore di crescita, rafforzando la consapevolezza e la capacità di gestione delle proprie dinamiche relazionali.
La dimensione psicocorporea del trattamento
Un approccio terapeutico che integri il corpo è essenziale per lavorare sulla presenza del terzo nella coppia. Ci si dovrebbe concentrare su tre livelli di intervento:
- Consapevolezza corporea: esplorare come il terzo si manifesti nel corpo, attraverso esercizi di percezione somatica e rilascio di tensioni.
- Respiro e contatto: il respiro condiviso e il contatto guidato possono facilitare il riconoscimento di emozioni represse e di dinamiche inconsce.
- Ritualità trasformativa: introdurre movimenti o gesti simbolici che permettano alla coppia di integrare il terzo senza percepirlo come minacci
Sezione domande e risposte
Il terzo è sempre un elemento negativo nella coppia?
No, il terzo può essere una risorsa se riconosciuto e integrato. La sua funzione può favorire la crescita della coppia, offrendo uno spazio di differenziazione e autonomia.
Come si manifesta il terzo nelle relazioni di lunga durata?
Può emergere sotto forma di routine, aspettative rigide o modelli interiorizzati che limitano la spontaneità. Il rischio è che la coppia diventi troppo chiusa e perda la capacità di evolvere.
Quale ruolo ha la terapia nella gestione del terzo?
La terapia aiuta a riconoscere il terzo, trasformandolo in un elemento di crescita anziché di separazione. Il lavoro psicocorporeo può facilitare questa integrazione.
Conclusione: verso una lettura integrata della coppia
Il terzo nella coppia, lungi dall’essere un elemento meramente perturbante, rappresenta una componente inevitabile del legame. Esso può essere vissuto come una minaccia, ma anche come un’opportunità per ridefinire l’intimità e la dinamica relazionale. Studi recenti in neurobiologia interpersonale (Siegel, 2012) indicano che la regolazione affettiva in coppia passa attraverso processi di co-regolazione neurofisiologica, in cui il corpo e le emozioni giocano un ruolo centrale. Quando il terzo emerge nella relazione, si attivano risposte somatiche e affettive che vanno ben oltre la dimensione cognitiva. La tensione muscolare, la respirazione frammentata, la postura chiusa o il bisogno di distanza fisica raccontano, spesso più delle parole, la difficoltà di integrare l’alterità all’interno della relazione.
Affrontare la presenza del terzo richiede una prospettiva terapeutica che non si limiti all’analisi verbale, ma che includa anche l’ascolto del corpo e delle sue manifestazioni. Il modello biodinamico, muovendosi lungo il continuum penso-sento, offre strumenti preziosi per accogliere questa complessità: attraverso la consapevolezza corporea, il lavoro sulle emozioni e la rinegoziazione dei confini, la coppia può trasformare il terzo da ostacolo a risorsa.
Il terzo può separare o unire, bloccare o liberare, a seconda di come viene vissuto e integrato. Quando rimane nell’ombra, può alimentare dinamiche di chiusura, paura e ripetizione. Quando viene riconosciuto, nominato e accolto, può diventare un ponte verso una nuova fase della relazione.
La coppia non è un sistema statico, ma un organismo in continua trasformazione. Riconoscere il terzo, dargli un nome e uno spazio, significa non solo affrontare le difficoltà, ma anche aprire la relazione a una crescita condivisa. È in questo movimento tra penso e sento, tra consapevolezza e corporeità, che risiede la possibilità di una connessione più autentica e vitale.
Bibliografia
- Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Waters, E., & Wall, S. (1978). Patterns of Attachment: A Psychological Study of the Strange Situation.
- Bowlby, J. (1988). A Secure Base: Parent-Child Attachment and Healthy Human Development. Basic Books.
- Dicks, H. V. (1949). Marital Tensions: Clinical Studies Towards a Psychological Theory of Interaction. Routledge & Kegan Paul.
- Eiguer, A. (2014). Il terzo nella coppia.
- Kernberg, O. (1995). Love Relations: Normality and Pathology. Yale University Press.
- Lowen, A. (1975). Penguin Books.
- Minuchin, S. (1974). Families and Family Therapy. Harvard University Press.
- Mitchell, S. A. (2002). Can Love Last? The Fate of Romance Over Time. W. Norton & Company.
- Siegel, D. J. (2012). The Developing Mind: How Relationships and the Brain Interact to Shape Who We Are.Guilford Press.
- Stern, D. N. (2004). The Present Moment in Psychotherapy and Everyday Life. W. Norton & Company.
- Willi, J. (1983). The Couple’s Interaction.
(*) Psicologhe, psicoterapeute